Fondamenti di illuminotecnica Artificiale e naturale
|
|
|
- Rosalinda Di Carlo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Fondamenti di illuminotecnica Artificiale e naturale Simone Secchi Dipartimento di Tecnologie dell'architettura e Design "Pierluigi Spadolini", Università degli Studi di Firenze
2 La natura della luce La luce è energia che si propaga in forma di onde elettromagnetiche alla velocità di circa km/s, nel vuoto, caratterizzata da lunghezza d onda comprese tra circa 0,38 μm e078μm 0,78 μm, campo di sensibilità dell occhio umano. 0,38 μm 0,78 μm
3 Le principali grandezze che caratterizzano le onde Ampiezza Periodo T (s) Tempo (s) frequenza f = 1/T (Hz) lunghezza d onda λ = c/f (m) velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto c = 2,998 x 10 8 (m/s)
4 Le leggi fisiche per il corpo nero La potenza emessa da un corpo nero è fornita dalla legge di distribuzione di Planck, in funzione della temperatura e della lunghezza d onda La legge dello spostamento di Wien fornisce la lunghezza d onda di massima emissione del corpo nero ( λt) = 2897,8 ( μm K) max potenza La legge di Stefan fornisce il potere emissivo integrale del corpo nero e = σ 2 ( W / ) 4 0T m
5 L emissione del sole
6 Le grandezze illuminotecniche Ω Flusso luminoso (φ) [lumen, lm] Quantità di energia luminosa emessa nell unità di tempo da una sorgente. Intensità luminosa (I) [candela, cd = lm / sr] Flusso luminoso emesso all interno dell angolo solido unitario (steradiante) in una direzione data. I dφ ds dφ = d Ω Illuminamento (E) [lux, lx = lm / m²] Rapporto tra flusso luminoso ricevuto da una superficie e area dφ E = dll della superficie fii stessa ds Luminanza (L) [candela / m², cd / m²] Rapporto tra intensità i àluminosa emessa da una superficie i in una data direzione e l area apparente di tale superficie. di L = ds α
7 Le relazioni tra le grandezze illuminotecniche Incidenza normale (θ = 0 ) Ω n r θ ds dφ I dθ I 2 E = = = r = ds ds ds I r 2 Incidenza obliqua (θ 0 ) (legge del coseno) ds E = I cos 2 r ( θ)
8 La visione I coni sono responsabili della visone diurna e dei dei colori, i bastoncelli sono responsabili della visione notturna Il fattore di visibilità Il fattore di visibilità per visione fotopica (diurna) (v) per visione scotopica (notturna) (v )
9 La riflessione, l assorbimento e la trasmissione Principio del bilancio energetico E a E i E E E E t r a i + + = Principio del bilancio energetico a E E E E E E E E t r a i t r a i + + = t r a 1 E E E E i i i i + + = E t E r a = coefficiente di assorbimento; r = coefficiente di riflessione; t = coefficiente di trasmissione
10 La riflessione luminosa ed il colore degli oggetti Riflessione irregolare Diffusore lambertiano I α = I m cos α Riflessione diffusa Riflessione speculare
11 Coefficiente di trasmissione del vetro L effetto serra
12 Valori raccomandati secondo la norma UNI Illuminotecnica, illuminazione di interni con luce artificiale
13 Valori raccomandati secondo la norma UNI 10380:1994/A1 Illuminotecnica, illuminazione di interni con luce artificiale
14 Valori raccomandati per le scuole secondo la norma UNI locali scolastici - criteri generali per l illuminazione artificiale e naturale
15 L illuminazione artificiale degli interni
16 Tipologie di sorgenti luminose artificiali a incandescenza a scarica in gas a induzione
17 Le lampade ad incandescenza Temperatura di funzionamento da 2700 a 2900 K. Quantità di luce emessa dal filamento della lampada proporzionale alla temperatura di funzionamento. Sorgente di luce a bassa efficienza: solo una piccola parte della potenza elettrica assorbita viene trasformata in luce. Elevati invecchiamento e riduzione i del flusso luminoso. Diversi formati, distinti per potenza e caratteristiche fotometriche, oltre che per le diverse esigenze d impiego. Si distinguono i seguenti tipi principali: p con bulbo trasparente; con bulbo diffondente; con riflettore incorporato. Spettro di emissione di un corpo nero in funzione della temperatura (K)
18 Lampade ad incandescenza con alogeni Dal 1972 lampade ad alogeni a bassissima tensione. Permettono la miniaturizzazione i i i delle sorgenti luminose. Evitano la perdita di efficienza causata dall evaporazione del tungsteno. L alogeno aggiunto al gas si unisce al tungsteno evaporato e torna a depositarlo sul filamento. Hanno migliori caratteristiche prestazionali rispetto alle lampade ad incandescenza: Durata da 1000 a 3000 ore; Efficienza sino a 25 lm/w; Temperatura di colore più elevata, da 2900 a 3100 K; Dimensioni estremamente ridotte del corpo luminoso.
19 Lampade ad incandescenza con alogeni Il riflettore delle lampade alogene può essere in quarzo trattato con l applicazione li i di strati ti di ossidi riflettenti ti alle radiazioni i i visibili, ma non a quelle infrarosse. La lampada, essendo dotata di riflettore, dovrà essere scelta in funzione dell ampiezza del fascio luminoso e l apparecchio di illuminazione nel quale andrà collocata ha la sola funzione di proteggerla e collegarla alla rete di alimentazione. Il riflettore può essere in alluminio oppure in vetro con trattamento della superficie riflettente (dicroico, dal greco: due colori ). Nel caso del vetro si tratta di una parabola in quarzo opportunamente trattata con l applicazione in alto vuoto di strati di ossidi selettivi a determinate lunghezze d onda: gli ossidi sono riflettenti alle radiazioni visibili, ma si lasciano attraversare dalla maggior parte della radiazione infrarossa. La luce emessa dalle lampade ad alogeni con riflettore dicroico è dunque una luce più fredda, sia dal punto di vista termico che cromatico, priva del 66% della radiazione i infrarossa emessa da una lampada ad alogeni con riflettore in alluminio i di pari potenza.
20 Le lampade a scarica Radiazione luminosa provocata dagli urti reciproci di particelle, cariche elettricamente, ltti t di un gas o di un vapore. Durata assai maggiore delle lampade ad incandescenza. Esistono i seguenti tipi di lampade a scarica: a) lampade fluorescenti; b) lampade a vapori di mercurio; c) lampade a vapori di alogenuri; d) lampade a luce miscelata; e) lampade a vapori di sodio; f) lampade allo xeno; g) sistemi ad induzione.
21 Lampade fluorescenti Lampade a vapori di mercurio a bassa pressione con tubo di vetro rivestito con polveri fluorescenti. Trasformazione della radiazione ultravioletta in radiazioni visibili. Caratterizzate da bassa luminanza (evitano l abbagliamento) abbagliamento). Flusso luminoso dipendente dalla temperatura-ambiente. Situazione ottimale tra 20 e 25 C. Durata molto elevata: circa 7500 ore per uso medio. Colore della luce molto variato a seconda delle sostanze fluorescenti usate.
22 Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione Radiazione contenuta per la maggior parte nel campo del visibile. Scarica in un piccolo tubo di quarzo protetto da un bulbo di vetro. Rivestimento in polvere fluorescente trasforma lo spettro a righe (radiazione i ultravioletta). l tt Pieno flusso luminoso raggiunto dopo alcuni minuti di accensione. Necessario periodo di raffreddamento di diversi minuti prima della riaccensione. Vasta gamma di potenze: da 50 a 2000 W; Flusso luminoso da 2000 a lm. Due grandi campi principali di applicazione: illuminazione industriale; Illuminazione stradale Spettro tipico di una lampada al mercurio a bassa pressione
23 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione Luce gialla e monocromatica. Efficienza i luminosa molto elevata (per funzionamento ad una determinata temperatura). Tempo iniziale d accensione di alcuni minuti. Impiego consigliabile dove occorre un alto grado di visibilità purché non sia necessaria la distinzione dei colori: -illuminazione stradale; -Illuminazione di interni ed esterni industriali. Spettro tipico di una lampada al sodio a bassa pressione
24 Lampade a luce miscelata Sono basate sulla tecnologia delle lampade a vapori di mercurio, a cui viene aggiunto un filamento ad incandescenza in serie al tubo di scarica. Presentano una luce con una componente a spettro continuo tipica del filamento ad incandescenza. Vantaggio nella facilità d uso: non è necessario alcun tipo di ausiliario elettrico (sostituito dal filamento interno alla lampada), per cui risulta possibile connettere la lampada su un comune attacco Edison. Efficienza e durata di vita fortemente condizionate dalla presenza del filamento che inoltre le rende abbastanza sensibili alle variazioni della tensione. Conveniente l applicazione in contesti dove la facilità d uso è più importante degli aspetti economici. Forte quantità di luce e temperatura di colore più elevata rispetto alle lampade a filamento hanno creato una notevole diffusione di queste lampade per l illuminazione residenziale e (giardini, garage, age, ecc.).
25 Lampade allo xeno Caratterizzate da una distribuzioneib i dell energia nello spettro praticamente identicai a quella della luce diurna e non influenzata dalle oscillazioni della tensione di rete. Resa dei colori eccellente e corrispondente a quella della luce naturale. Si accendono istantaneamente eraggiungono g immediatamente la piena emissione luminosa. Richiedono, per il loro funzionamento, un alimentatore e un accenditore.
26 Sistemi ad induzione Associano i principi della scarica in gas e dell induzione elettromagnetica. La ionizzazionei i degli atomi di mercurio è realizzata grazie ad un campo elettromagnetico indotto da una corrente elettrica ad alta frequenza che circola in un apposita bobina. Costituite dai seguenti componenti: - bulbo entro cui avviene la scarica in gas; - bobina-antenna; - generatore elettronico; - cavo coassiale di collegamento all antenna antenna. Grazie all assenza di filamenti ed elettrodi, sono caratterizzate da una durata eccezionale (circa ore di funzionamento pressoché prive di manutenzione). Particolarmente adatte per i luoghi in cui è difficile accedere agli apparecchi di illuminazionei i e dove lasostituzione i delle lampadine costituisce i un operazione costosa e pericolosa.
27 LED (Light Emitting Diode) Sfruttano le proprietà ottiche di materiali semiconduttori (in genere silicio) che, una volta eccitati da un tensione diretta, emettono una luce visibile in un determinato colore. Nei materiali semiconduttori vengono inserite delle impurità che ne incrementano le capacità di conduzione. Quando la corrente viene applicata al reticolo cristallino semiconduttore del diodo, gli elettroni (con carica negativa) e le lacune (con carica positiva) si combinano e convertono in luce il loro eccesso di energia. Dal tipo di semiconduttori e dal processo di drogaggio dipendono la lunghezza d'onda emessa, l'efficienza energetica dell'apparecchio e l'intensità luminosa. Funzionamento a basso voltaggio. Rendimento energetico molto elevato (40-70 lm/w). Lunga durata (durata media attorno alle ore). Dimensioni ridotte. Assenza di produzione di calore. Accensione istantanea. Dimmerabili.
28 Principali caratteristiche delle sorgenti luminose da interni Tipo di lampade Efficienza energetica (lm/w) Potenza lampada (W) Durata vita (ore) Ad incandescenza Ad alogeni Fluorescenti compatte elletroniche Fluorescenti tubolari LED (Light Emitting Diode) (il singolo LED)
29 Le caratteristiche direzionali delle lampade Cd/1000 lm Solido fotometrico Proiezione di un solido fotometrico
30 Coefficiente di utilizzazione Progetto di illuminazione di interni η = Φ u Φ t Flusso totale richiesto Φ t = E S η Il coefficiente di utilizzazione dipende da: Sistema di illuminazione; Rendimento ν dell apparecchio; Coefficienti di riflessione di soffitto e muri; Forma del locale 0,8a + 0,2b b>a K = h=altezza utile h Numero di sorgenti necessarie Φ η = Φ t L
31
32
33
34
35 Lampade ad incandescenza Dtit Dati tecnici ii
36 Lampade fluorescenti lineari e circolari Dtit Dati tecnici ii
37 Progetto di illuminazione di esterni Illuminamento richiesto nel singolo punto I E = α cosα 2 r (Prima legge del coseno) r = distanza tra sorgente e punto; α = angolo formato tra la direzione del raggio e la normale al piano illuminato I E = cos 2 h α 3 α h sorgente r α
38 L illuminazione naturale degli interni
39 I motivi per l illuminazione naturale EFFETTI DELLA CARENZA DI LUCE NATURALE PSICOLOGICI FISIOLOGICI PSICO- FISIOLOGICI Stress Tendenza alla miopia Alterazione ritmo cardiaco Depressione SAD Irritabilità Alterazione Affaticamento oculare Cefalea Abbattimento percezione visiva Esaltazione dei difetti dell occhio Alterazione orologio biologico Alterazione metabolismo Alterazione pressione dell equilibrio neurovegetativo arteriosa EFFETTI DI UNA BUONA LUCE NATURALE BATTERICIDI Distruzione dei germi e batteri prodotti negli ambienti per aerodiffusione FISIOLOGICI Stimolazione della produzione di vitamina D Effetti antirachitici Attivazione del ricambio calcio-fosforo Effetto sulle attività ità endocrine Effetto sul metabolismo del glucosio Aumento delle difese immunitarie PSICO- FISIOLOGICI Mantiene il corretto equilibrio dell orologio biologico e l alternanza della veglia-riposo i Aumento della produttività lavorativa
40 Il quadro normativo relativo all illuminazione naturale degli ambienti Circ. Min. LL. PP del 22 maggio 1967 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie) Circ. Min. LL. PP del 22 novembre 1974 (requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere: proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione) D.M. 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione) i ) D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) UNI (Luce e illuminazione - locali scolastici: criteri generali per l illuminazione artificiale e naturale)
41 Il fattore di luce diurna Rapporto fra il livello di illuminamento in un punto posto su un piano orizzontale all interno del locale (E int ) e il livello di illuminamento in un punto posto su di un piano orizzontale sotto l intero emisfero celeste in assenza di ostruzioni e di irraggiamento solare diretto (E 0 ) con misure fatte nello stesso momento E FLD = int 100 E 0 (%) E 0 E int
42 Metodo di calcolo del fattore puntuale di luce diurna Il calcolo del Fattore puntuale di Luce Diurna prevede la stima separata delle tre componenti: - Componente Cielo (C.C.) - Componente Riflessa Internamente (C.R.I.) - Componente Riflessa Esternamente t Le tre componenti possono essere stimate, t oltre che con software specifici, i con differenti metodi grafici, analitici o tabulari. In ogni caso è necessario porre delle ipotesi sul modello adottato per descrivere la distribuzione ib i della luminanza del cielo.
43 Modelli di luminanza del cielo Il modello adottato per descrivere la luminanza del cielo è importante perché determina la distribuzione dell'illuminazione naturale negli interni e gli effetti legati alla direzionalità della luce. Con il cielo coperto lo zenit è più luminoso dell'orizzonte. Ciò produce soltamente forti gradienti di illuminamento tra la zona più prossima alla finestra e quella sul fondo della stanza. Con il cielo sereno la distribuzione della radianza è funzione dell'angolo di altitudine del sole. Ciò può produrre un gradiente di illuminazione minore o maggiore di quello che si ha con cielo coperto. In regioni dove prevalgono condizioni meteorologiche di cielo coperto è indicato In regioni dove prevalgono condizioni meteorologiche di cielo coperto, è indicato l uso dei lucernari che producono una forte luce zenitale.
44 Modelli di cielo coperto I più diffusi modelli per descrivere la luminanza del cielo coperto sono: - cielo a luminanza uniforme - cielo a luminanza standard CIE Il cielo a luminanza standard d CIE ipotizza che la luminanza allo zenit sia tre volte superiore quella all orizzonte. Tale situazione corrisponde a quella di un atmosfera limpida con cielo completamente coperto da nuvole chiare. L p = L z 1+ 2cos 3 ( zs) Lp = luminanza nel punto p; Lz = luminanza allo zenit; Z l it l h i di id l i i Zs = angolo zenitale che individua la posizione del sole.
45 Confronto tra ipotesi di cielo uniforme e di cielo CIE
46 Rilievi sperimentali di luminanza di cielo sereno
47 Metodo di calcolo del fattore medio di luce diurna FLD m = A A f tot t ε ψ 1 r ( ) m A f è l area della superficie della finestra, escluso il telaio; t è il fattore di trasmissione luminosa del vetro; ε è il fattore finestra, rappresentativo ti della posizione i di volta celeste vista dal baricentro della finestra (ε = 1 per finestra orizzontale lucernario - senza ostruzioni; ε = 0,5 per finestra verticale senza ostruzione; ε < 0,5 per finestra verticale con ostruzione) A to t è l area totale t delle superfici i che delimitano it l ambiente; r m è il fattore medio di riflessione luminosa delle superfici che delimitano l ambiente; ψ è il fattore di riduzione del fattore finestra.
48 Calcolo della superficie vetrata Af (Quando non sia nota la superficie precisa dell area vetrata dell infisso) Af = 0,75 Ai Ai = area totale dell infisso t = 0,9 τ Calcolo del coefficiente di trasmissione luminosa del vetro t (Quando non sia noto il livello di pulizia dell infisso)
49 Le caratteristiche dei materiali Coefficiente di riflessione luminosa di alcune finiture Coefficiente i di trasmissione i luminosa di alcuni vetri Correzione per condizioni di pulizia del vetro
50 Calcolo del fattore finestra ε
51 Calcolo del fattore finestra ε Ostruzioni che occupano la parte bassa del panorama ε = 1 senα 2 α = angolo piano di altitudine che sottende la parte ostruita di cielo α L a H H-h h Ostruzioni che occupano la parte alta del panorama ε sen α 2 α = 2 = angolo piano che sottende la parte visibile ibil di cielo 2 L α 2 H Ostruzioni che occupano sia la parte alta che quella bassa del panorama ε = senαα 2 senαα 2
52 Calcolo del fattore riduttivo ψ
53 Valori limite del fattore di luce diurna secondo la legislazione vigente Ambienti residenziali (D.M. 5/7/75) Locali di abitazione: 2% (inoltre la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore i a 1/8 della superficie i del pavimento) ) Ambienti ospedalieri (Circ /11/74) Ambienti di degenza, diagnostica, laboratori: 3% Palestre, refettori: 2% Uffici, spazi per la distribuzione, scale: 1% Ambienti scolastici (D.M. 18/12/75) Ambienti ad uso didattico (aule per lezione, studio, lettura, disegno ecc.): 3% Palestre, refettori: 2% Uffici, spazi per la distribuzione, scale, servizi igienici: 1%
Facoltà di Architettura- Corso di Tecnica del Controllo Ambientale
 Le sorgenti di luce costituiscono il mezzo attraverso cui si assicura ad un ambiente una qualità illuminotecnica. La luce costituisce uno strumento di progettazione SORGENTI DI LUCE DISPONIBILI ARTIFICIALE
Le sorgenti di luce costituiscono il mezzo attraverso cui si assicura ad un ambiente una qualità illuminotecnica. La luce costituisce uno strumento di progettazione SORGENTI DI LUCE DISPONIBILI ARTIFICIALE
Grandezze fotometriche
 Capitolo 3 Grandezze fotometriche 3.1 Intensità luminosa E una grandezza vettoriale di simbolo I. Ha come unità di misura la candela(cd). La candela è l unità di misura fondamentale del sistema fotometrico.
Capitolo 3 Grandezze fotometriche 3.1 Intensità luminosa E una grandezza vettoriale di simbolo I. Ha come unità di misura la candela(cd). La candela è l unità di misura fondamentale del sistema fotometrico.
Allegato K al Regolamento Edilizio del Comune di Prato Area 4 - Scheda 4.1 (Illuminazione naturale) Norme per la compilazione
 Allegato K al Regolamento Edilizio del Comune di Prato Area 4 - Scheda 4.1 (Illuminazione naturale) Norme per la compilazione SCHEDA 4.1 Area di Valutazione: 4 - Qualità ambiente interno Esigenza: Categoria
Allegato K al Regolamento Edilizio del Comune di Prato Area 4 - Scheda 4.1 (Illuminazione naturale) Norme per la compilazione SCHEDA 4.1 Area di Valutazione: 4 - Qualità ambiente interno Esigenza: Categoria
DETERMINAZIONE DEL REQUISITO D ILLUMINAMENTO NATURALE PER LE NUOVE COSTRUZIONI
 DETERMINAZIONE DEL REQUISITO D ILLUMINAMENTO NATURALE PER LE NUOVE COSTRUZIONI ILLUMINAMENTO NATURALE IN SEDE PROGETTUALE Il controllo dell illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al
DETERMINAZIONE DEL REQUISITO D ILLUMINAMENTO NATURALE PER LE NUOVE COSTRUZIONI ILLUMINAMENTO NATURALE IN SEDE PROGETTUALE Il controllo dell illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al
Fondamenti di illuminotecnica. Laboratorio di illuminazione CORVO - Ispra
 Fondamenti di illuminotecnica Laboratorio di illuminazione CORVO - Ispra Ispra, 24 novembre 2014 Luce Cos è la luce 1 nm = 10-9 m La luce è radiazione elettromagnetica, visibile all'uomo. la lunghezza
Fondamenti di illuminotecnica Laboratorio di illuminazione CORVO - Ispra Ispra, 24 novembre 2014 Luce Cos è la luce 1 nm = 10-9 m La luce è radiazione elettromagnetica, visibile all'uomo. la lunghezza
Trasmissione di calore per radiazione
 Trasmissione di calore per radiazione Sia la conduzione che la convezione, per poter avvenire, presuppongono l esistenza di un mezzo materiale. Esiste una terza modalità di trasmissione del calore: la
Trasmissione di calore per radiazione Sia la conduzione che la convezione, per poter avvenire, presuppongono l esistenza di un mezzo materiale. Esiste una terza modalità di trasmissione del calore: la
VINCI FINE INSTRUMENTS MONTEROTONDO ROMA Tel mail web : https//
 UnitÄ fotometriche: lumen, candele, lux. Con la comparsa nel mercato di lampade e lampadine a LED sono diventati comuni anche i termini di lumen, candele e lux. UnitÄ di misura fotometriche molto importanti
UnitÄ fotometriche: lumen, candele, lux. Con la comparsa nel mercato di lampade e lampadine a LED sono diventati comuni anche i termini di lumen, candele e lux. UnitÄ di misura fotometriche molto importanti
Impianti di illuminazione. Impianti di illuminazione
 Impianti Meccanici 1 L di un locale industriale influenza la percentuale di infortuni e sulla qualità della produzione Illuminamento scarso significa : - Un progressivo senso di stanchezza degli operatori
Impianti Meccanici 1 L di un locale industriale influenza la percentuale di infortuni e sulla qualità della produzione Illuminamento scarso significa : - Un progressivo senso di stanchezza degli operatori
Lampade per capannoni magazzini e gallerie stradali
 LC 340 - LC 480 Lampade per capannoni magazzini e gallerie stradali Indice Pag 5: Nozioni riguardo l illuminazione a LED Pag 6: Serie LC Pag 8: Optional: Dimmer di potenza Pag 10: Marchi di controllo 5
LC 340 - LC 480 Lampade per capannoni magazzini e gallerie stradali Indice Pag 5: Nozioni riguardo l illuminazione a LED Pag 6: Serie LC Pag 8: Optional: Dimmer di potenza Pag 10: Marchi di controllo 5
Fondamenti di illuminotecnica
 Fondamenti di illuminotecnica Corso di Fisica Tecnica Ambientale Scienze dell Architettura Grandezze del moto oscillatorio E ( m) Periodo T (s) tempo occorrente per compiere una oscillazione frequenza
Fondamenti di illuminotecnica Corso di Fisica Tecnica Ambientale Scienze dell Architettura Grandezze del moto oscillatorio E ( m) Periodo T (s) tempo occorrente per compiere una oscillazione frequenza
Illuminazione naturale
 Illuminazione naturale L illuminazione naturale è importante per diversi aspetti che possono sintetizzarsi nel benessere fisiologico e psicologico degli individui e nel risparmio energetico, riducendosi
Illuminazione naturale L illuminazione naturale è importante per diversi aspetti che possono sintetizzarsi nel benessere fisiologico e psicologico degli individui e nel risparmio energetico, riducendosi
Seminario di aggiornamento sull illuminazione esterna
 Seminario di aggiornamento sull illuminazione esterna Introduzione alle problematiche relative all illuminazione pubblica Paolo Soardo Unità fotometriche La luce è energia che si propaga per onde elettromagnetiche
Seminario di aggiornamento sull illuminazione esterna Introduzione alle problematiche relative all illuminazione pubblica Paolo Soardo Unità fotometriche La luce è energia che si propaga per onde elettromagnetiche
Lampade per distributori di benzina
 LD 340 - LD 480 Lampade per distributori di benzina Indice Pag 5: Nozioni riguardo l illuminazione a LED Pag 6: Serie LD Pag 8: Optional: Dimmer di potenza Pag 10: Marchi di controllo 5 Nozioni riguardo
LD 340 - LD 480 Lampade per distributori di benzina Indice Pag 5: Nozioni riguardo l illuminazione a LED Pag 6: Serie LD Pag 8: Optional: Dimmer di potenza Pag 10: Marchi di controllo 5 Nozioni riguardo
Facoltà di Architettura- Corso di Tecnica del Controllo Ambientale. Illuminotecnica
 Le radiazioni elettromagnetiche come Onde radio Radiazioni infrarosse Raggi X Raggi gamma etc Grandezze caratteristiche Lunghezza d onda L onda passa 5 volte al secondo Frequenza Sono comprese nell intervallo
Le radiazioni elettromagnetiche come Onde radio Radiazioni infrarosse Raggi X Raggi gamma etc Grandezze caratteristiche Lunghezza d onda L onda passa 5 volte al secondo Frequenza Sono comprese nell intervallo
L illuminamento medio in esercizio risulta pari a 500 lux. Determinare :
 1)Un sala di lettura, di pianta rettangolare 10 x 5 metri, è illuminata con plafoniere dotate di due lampade fluorescenti tubolari, di potenza 36 W ciascuna e flusso luminoso 2800 lm. Le dimensioni dell
1)Un sala di lettura, di pianta rettangolare 10 x 5 metri, è illuminata con plafoniere dotate di due lampade fluorescenti tubolari, di potenza 36 W ciascuna e flusso luminoso 2800 lm. Le dimensioni dell
Un immagine digitale. Dimensioni finite (X,Y) No profondità inerente Numero finito di pixel Rappresentazione numerica dell energia luminosa
 Un immagine digitale Dimensioni finite (X,Y) No profondità inerente Numero finito di pixel Rappresentazione numerica dell energia luminosa Y X x y f(x,y) = intensità luminosa in (x,y) Tre livelli di image
Un immagine digitale Dimensioni finite (X,Y) No profondità inerente Numero finito di pixel Rappresentazione numerica dell energia luminosa Y X x y f(x,y) = intensità luminosa in (x,y) Tre livelli di image
Sorgenti luminose. Prof. Ing. Cesare Boffa
 Sorgenti luminose Caratteristiche illuminotecniche delle sorgenti Naturali Le sorgenti luminose Sole (luna) Volta celeste Artificiali Lampade a incandescenza Lampade a scarica nei gas Lampade a luce miscelata
Sorgenti luminose Caratteristiche illuminotecniche delle sorgenti Naturali Le sorgenti luminose Sole (luna) Volta celeste Artificiali Lampade a incandescenza Lampade a scarica nei gas Lampade a luce miscelata
Lampada a incandescenza
 I diversi tipi di lampade Lampada a incandescenza La lampada a incandescenza tradizionale è una sorgente luminosa in cui la luce viene prodotta dal riscaldamento di un filamento di tungsteno (un metallo)
I diversi tipi di lampade Lampada a incandescenza La lampada a incandescenza tradizionale è una sorgente luminosa in cui la luce viene prodotta dal riscaldamento di un filamento di tungsteno (un metallo)
Impianti di illuminazione. Impianti Meccanici 1
 Impianti Meccanici 1 L di un locale industriale influenza la percentuale di infortuni e la qualità della produzione Illuminamento scarso significa : - Un progressivo senso di stanchezza degli operatori;
Impianti Meccanici 1 L di un locale industriale influenza la percentuale di infortuni e la qualità della produzione Illuminamento scarso significa : - Un progressivo senso di stanchezza degli operatori;
ILLUMINOTECNICA. Spettro o.e.m. Sensibilità occhio. Grandezze illuminotecniche
 U V - A Spettro o.e.m. Sensibilità occhio ILLUMINOTECNICA R A G G I x R A G G I γ ULTRAVIOLETTI U V - C U V - B VISIBILE Infrarossi Onde radio 100 280 315 380 780 10 6 nm Grandezze illuminotecniche La
U V - A Spettro o.e.m. Sensibilità occhio ILLUMINOTECNICA R A G G I x R A G G I γ ULTRAVIOLETTI U V - C U V - B VISIBILE Infrarossi Onde radio 100 280 315 380 780 10 6 nm Grandezze illuminotecniche La
Elementi di illuminotecnica. La percezione della luce, sintesi fotometria, Illuminazione naturale
 Elementi di illuminotecnica Capitolo 2 La percezione della luce, sintesi fotometria, Illuminazione naturale La luce La luce è l agente fisco che rende visibile gli oggetti, ovvero è la sensazione determinata
Elementi di illuminotecnica Capitolo 2 La percezione della luce, sintesi fotometria, Illuminazione naturale La luce La luce è l agente fisco che rende visibile gli oggetti, ovvero è la sensazione determinata
Fisica Tecnica Ambientale
 Università degli Studi di Perugia Sezione di Fisica Tecnica Fisica Tecnica Ambientale Lezione del 28 maggio 2015 Ing. Francesco D Alessandro dalessandro.unipg@ciriaf.it Corso di Laurea in Ingegneria Edile
Università degli Studi di Perugia Sezione di Fisica Tecnica Fisica Tecnica Ambientale Lezione del 28 maggio 2015 Ing. Francesco D Alessandro dalessandro.unipg@ciriaf.it Corso di Laurea in Ingegneria Edile
Soluzioni professionali d illuminazione con tecnologia a LED per centri sportivi indoor e outdoor. BBTel
 Soluzioni professionali d illuminazione con tecnologia a LED per centri sportivi indoor e outdoor. i vantaggi La tecnologia a LED, la soluzione L avvento della tecnologia a LED ha notevolmente accentuato
Soluzioni professionali d illuminazione con tecnologia a LED per centri sportivi indoor e outdoor. i vantaggi La tecnologia a LED, la soluzione L avvento della tecnologia a LED ha notevolmente accentuato
RISCHIO ILLUMINAZIONE
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO RISCHIO ILLUMINAZIONE Vincenzo Duraccio University of Cassino Department of Industrial Engineering e-mail: duraccio@unicas.it telefono: 0776-2993721 Videoterminali Microclima
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO RISCHIO ILLUMINAZIONE Vincenzo Duraccio University of Cassino Department of Industrial Engineering e-mail: duraccio@unicas.it telefono: 0776-2993721 Videoterminali Microclima
CORSO DI FISICA TECNICA
 CORSO DI FISICA TECNICA Trasmissione del calore Irraggiamento IRRAGGIAMENTO Trasferimento di energia per onde elettromagnetiche Moto vibratorio delle molecole Tutte le superfici emettono onde elettromagnetiche
CORSO DI FISICA TECNICA Trasmissione del calore Irraggiamento IRRAGGIAMENTO Trasferimento di energia per onde elettromagnetiche Moto vibratorio delle molecole Tutte le superfici emettono onde elettromagnetiche
Luce naturale e ambiente costruito Strumenti e metodi per il controllo della luce naturale in fase di progetto.
 Luce naturale e ambiente costruito Strumenti e metodi per il controllo della luce naturale in fase di progetto. LA LUCE IN Architettura L architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi
Luce naturale e ambiente costruito Strumenti e metodi per il controllo della luce naturale in fase di progetto. LA LUCE IN Architettura L architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi
COMFORT IN UFFICIO LA LUCE
 COMFORT IN UFFICIO LA LUCE Parte 1: Nozioni base e fondamenti di illuminotecnica CONTENUTI 1. Caratteristiche della sorgente luminosa - Intensità luminosa - Flusso luminoso - Efficienza luminosa - Temperatura
COMFORT IN UFFICIO LA LUCE Parte 1: Nozioni base e fondamenti di illuminotecnica CONTENUTI 1. Caratteristiche della sorgente luminosa - Intensità luminosa - Flusso luminoso - Efficienza luminosa - Temperatura
Lampade per capannoni magazzini e gallerie stradali
 LC 36 LC 54 Lampade per capannoni magazzini e gallerie stradali 2 Nozioni riguardo l illuminazione a LED I LED (Light Emitting Diodes) sono sempre più utilizzati in ambito illuminotecnico in sostituzione
LC 36 LC 54 Lampade per capannoni magazzini e gallerie stradali 2 Nozioni riguardo l illuminazione a LED I LED (Light Emitting Diodes) sono sempre più utilizzati in ambito illuminotecnico in sostituzione
Fondamenti di illuminotecnica e Sicurezza sul lavoro: modulo illuminotecnica
 Giornata di formazione e informazione A.F.Varese - Luino Laura Blaso - Ricercatrice ENEA Fondamenti di illuminotecnica e Sicurezza sul lavoro: modulo illuminotecnica Luino, 21 maggio 2015 Luce Cos è la
Giornata di formazione e informazione A.F.Varese - Luino Laura Blaso - Ricercatrice ENEA Fondamenti di illuminotecnica e Sicurezza sul lavoro: modulo illuminotecnica Luino, 21 maggio 2015 Luce Cos è la
ALLEGATO L1 - Caratteristiche tecniche dei LED 1,8-3 - 4,8-5 mm (Ledz).
 ALLEGATO L1 - Caratteristiche tecniche dei LED 1,8-3 - 4,8-5 mm (Ledz). Tipo Colore (K) Caratteristiche elettriche e ottiche (*) Vf (V) If Intensità Angolo Tipica Max (ma) luminosa (cd) proiezione ( )
ALLEGATO L1 - Caratteristiche tecniche dei LED 1,8-3 - 4,8-5 mm (Ledz). Tipo Colore (K) Caratteristiche elettriche e ottiche (*) Vf (V) If Intensità Angolo Tipica Max (ma) luminosa (cd) proiezione ( )
Il fenomeno luminoso
 Un immagine Dimensioni finite (X,Y) No profondità inerente Rappresentazione numerica energia luminosa Y X x y B(x,y) = intensità luminosa in (x,y) Il fenomeno luminoso Fisica della luce e grandezze fotometriche
Un immagine Dimensioni finite (X,Y) No profondità inerente Rappresentazione numerica energia luminosa Y X x y B(x,y) = intensità luminosa in (x,y) Il fenomeno luminoso Fisica della luce e grandezze fotometriche
A4.2c ILLUMINAZIONE. CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03. MODULO A Unità didattica
 Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole ILLUMINAZIONE MODULO A Unità didattica A4.2c CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 Spettro visibile All'interno dello
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole ILLUMINAZIONE MODULO A Unità didattica A4.2c CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 Spettro visibile All'interno dello
NOZIONI DI ILLUMINOTECNICA
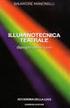 Giulia Voltolini matr. 233527, Luca Giglioli matr. 231963 Lezione del 9/05/2014 ora 14:30-17:30 NOZIONI DI ILLUMINOTECNICA 1_introduzione 2_la propagazione della luce 3_le grandezze fotometriche 4_la percezione
Giulia Voltolini matr. 233527, Luca Giglioli matr. 231963 Lezione del 9/05/2014 ora 14:30-17:30 NOZIONI DI ILLUMINOTECNICA 1_introduzione 2_la propagazione della luce 3_le grandezze fotometriche 4_la percezione
Materiale didattico validato da: L ambiente luminoso. Il Benessere Visivo. Rev. 1 lug Illuminamento slide 1 di 25
 L ambiente luminoso Il Benessere Visivo Rev. 1 lug. 2009 Illuminamento slide 1 di 25 Cos è la luce La luce è un energia radiante in grado di eccitare la retina dell occhio producendo una sensazione visiva.
L ambiente luminoso Il Benessere Visivo Rev. 1 lug. 2009 Illuminamento slide 1 di 25 Cos è la luce La luce è un energia radiante in grado di eccitare la retina dell occhio producendo una sensazione visiva.
Una sorgente luminosa artificiale è generalmente costituita da due parti:
 Illuminotecnica Sorgenti luminose artificiali Definizioni Una sorgente luminosa artificiale è generalmente costituita da due parti: La lampada L apparecchio illuminante Le lampade, preposte alla conversione
Illuminotecnica Sorgenti luminose artificiali Definizioni Una sorgente luminosa artificiale è generalmente costituita da due parti: La lampada L apparecchio illuminante Le lampade, preposte alla conversione
I problemi dalle nuove normative: dall acustica all illuminazione e ventilazione naturale
 I problemi dalle nuove normative: dall acustica all illuminazione e ventilazione naturale Simone Secchi Dipartimento Tecnologie dell Architettura e Design Pierluigi Spadolini simone.secchi@unifi.it http://www.taed.unifi.it/fisica_tecnica
I problemi dalle nuove normative: dall acustica all illuminazione e ventilazione naturale Simone Secchi Dipartimento Tecnologie dell Architettura e Design Pierluigi Spadolini simone.secchi@unifi.it http://www.taed.unifi.it/fisica_tecnica
BENESSERE VISIVO ED ILLUMINOTECNICO. arch. Cristina Carletti Dip. TAeD Università di Firenze
 BENESSERE VISIVO ED ILLUMINOTECNICO arch. Cristina Carletti Dip. TAeD Università di Firenze BENESSERE TERMOIGROMETRICO Stato di neutralità termica, in cui il soggetto non sente né caldo né freddo. Benessere
BENESSERE VISIVO ED ILLUMINOTECNICO arch. Cristina Carletti Dip. TAeD Università di Firenze BENESSERE TERMOIGROMETRICO Stato di neutralità termica, in cui il soggetto non sente né caldo né freddo. Benessere
Grandezze fotometriche 1
 Grandezze fotometriche 1 Le grandezze fotometriche sono definite partendo dalle grandezze radiometriche ma tenendo conto della curva di risposta dell occhio umano, che agisce come un fattore di peso. In
Grandezze fotometriche 1 Le grandezze fotometriche sono definite partendo dalle grandezze radiometriche ma tenendo conto della curva di risposta dell occhio umano, che agisce come un fattore di peso. In
Facoltà di Architettura- Corso di Tecnica del Controllo Ambientale. Illuminotecnica
 Le radiazioni elettromagnetiche come Onde radio Radiazioni infrarosse Raggi X Raggi gamma etc Grandezze caratteristiche Lunghezza d onda L onda passa 5 volte al secondo Frequenza Sono comprese nell intervallo
Le radiazioni elettromagnetiche come Onde radio Radiazioni infrarosse Raggi X Raggi gamma etc Grandezze caratteristiche Lunghezza d onda L onda passa 5 volte al secondo Frequenza Sono comprese nell intervallo
Fenomeni quantistici
 Fenomeni quantistici 1. Radiazione di corpo nero Leggi di Wien e di Stefan-Boltzman Equipartizione dell energia classica Correzione quantistica di Planck 2. Effetto fotoelettrico XIII - 0 Radiazione da
Fenomeni quantistici 1. Radiazione di corpo nero Leggi di Wien e di Stefan-Boltzman Equipartizione dell energia classica Correzione quantistica di Planck 2. Effetto fotoelettrico XIII - 0 Radiazione da
SCHEDA PRODOTTO P MR W/827 GU5.3
 P MR16 20 36 2.9 W/827 GU5.3 PARATHOM MR16 Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali AREE APPLICATIVE Negozi Strutture ricettive Musei, gallerie d'arte Interni residenziali
P MR16 20 36 2.9 W/827 GU5.3 PARATHOM MR16 Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali AREE APPLICATIVE Negozi Strutture ricettive Musei, gallerie d'arte Interni residenziali
Corpi illuminanti a LED
 Corpi illuminanti a LED ARMATURA STRADALE LD201 LD201 Armatura stradale a LED di ultima generazione, nata dalla sintesi tra il design e la tecnologia più avanzati nel settore. La gradevole forma geometrica
Corpi illuminanti a LED ARMATURA STRADALE LD201 LD201 Armatura stradale a LED di ultima generazione, nata dalla sintesi tra il design e la tecnologia più avanzati nel settore. La gradevole forma geometrica
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE
 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE La lampadina è un dispositivo elettrico specificamente progettato per produrre luce. Ci sono diversi tipi di lampadina per usi diversi. Anzitutto una lampadina
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE La lampadina è un dispositivo elettrico specificamente progettato per produrre luce. Ci sono diversi tipi di lampadina per usi diversi. Anzitutto una lampadina
L irraggiamento termico
 L irraggiamento termico Trasmissione del Calore - 42 Il calore può essere fornito anche mediante energia elettromagnetica; ciò accade perché quando un fotone, associato ad una lunghezza d onda compresa
L irraggiamento termico Trasmissione del Calore - 42 Il calore può essere fornito anche mediante energia elettromagnetica; ciò accade perché quando un fotone, associato ad una lunghezza d onda compresa
Fabio Peron. La trasmissione del calore: 3. radiazione termica. Le modalità di scambio del calore. La radiazione termica. Onde e oscillazioni
 Corso di Progettazione Ambientale prof. Fabio Peron Le modalità di scambio del calore Una differenza di temperatura costituisce uno squilibrio che la natura cerca di annullare generando un flusso di calore.
Corso di Progettazione Ambientale prof. Fabio Peron Le modalità di scambio del calore Una differenza di temperatura costituisce uno squilibrio che la natura cerca di annullare generando un flusso di calore.
Alogene. Lampade CARATTERISTICHE. Attacchi GU5,3 - GU4 - G4 - GY6,35 - G9 - GU10 - E14 - E27 - R7s
 Lampade Alogene 79 Le Lampade ad Alogeni Beghelli coniugano l eccezionale qualità della luce emessa dalle lampade incandescenti ad affidabilità ed efficienza. Il risultato sono sorgenti luminose con vita
Lampade Alogene 79 Le Lampade ad Alogeni Beghelli coniugano l eccezionale qualità della luce emessa dalle lampade incandescenti ad affidabilità ed efficienza. Il risultato sono sorgenti luminose con vita
Sorgenti di radiazione luminosa
 Sorgenti di radiazione luminosa Quello che differenzia le fonti di luce (e quindi la qualità della radiazione emessa) è il meccanismo con cui viene generata l onda elettromagnetica. Poiché l onda trasporta
Sorgenti di radiazione luminosa Quello che differenzia le fonti di luce (e quindi la qualità della radiazione emessa) è il meccanismo con cui viene generata l onda elettromagnetica. Poiché l onda trasporta
Facoltà di Architettura- Corso di Tecnica del Controllo Ambientale
 Il comfort luminoso o visivo Il comfort visivo è una necessità essenziale dell uomo che può influenzare le prestazioni lavorative, la salute e la sicurezza, l umore e l atmosfera.. (manuale dell Illuminating
Il comfort luminoso o visivo Il comfort visivo è una necessità essenziale dell uomo che può influenzare le prestazioni lavorative, la salute e la sicurezza, l umore e l atmosfera.. (manuale dell Illuminating
Componenti. 1/3. Lampada al Neon:
 Lampade al Neon. Componenti. Funzionamento. Caratteristiche elettriche. Analogie e differenze (neon-incandescenza). Conduzione del gas. Forma geometrica. Smaltimento RAEE. Spettro luminoso. Componenti.
Lampade al Neon. Componenti. Funzionamento. Caratteristiche elettriche. Analogie e differenze (neon-incandescenza). Conduzione del gas. Forma geometrica. Smaltimento RAEE. Spettro luminoso. Componenti.
Analisi delle Strategie di Risparmio Energetico adottate nel Nuovo Meyer di Firenze: il primo Ospedale Bioclimatico d Italia
 Analisi delle Strategie di Risparmio Energetico adottate nel Nuovo Meyer di Firenze: il primo Ospedale Bioclimatico d Italia Daylighting Daylighting Definizione Vantaggi Nozioni Base Daylight Strategies
Analisi delle Strategie di Risparmio Energetico adottate nel Nuovo Meyer di Firenze: il primo Ospedale Bioclimatico d Italia Daylighting Daylighting Definizione Vantaggi Nozioni Base Daylight Strategies
DURATA UTILE IN ORE COLORI. alogene continuo molto piccole diurna ottima o molto grandi
 TIPO DI LAMPADA GAMME DI POTENZE IN W EFFICIENZA lm/w DURATA UTILE IN ORE TONALITA RESA DEI COLORI DIMENSIONI CAMPI D IMPIEGO AD INCANDESCENZA normali 25 1500 8 20 bianco impieghi generali tubolari 15
TIPO DI LAMPADA GAMME DI POTENZE IN W EFFICIENZA lm/w DURATA UTILE IN ORE TONALITA RESA DEI COLORI DIMENSIONI CAMPI D IMPIEGO AD INCANDESCENZA normali 25 1500 8 20 bianco impieghi generali tubolari 15
SUPER FLAT SUSPENSION 90X90 UP&DOWN DALI VERSION
 SUPER FLAT SUSPENSION 90X90 UP&DOWN DALI VERSION Montaggio Sospeso a soffitto Descrizione delle lampade Top LED 4000K CRI 80 Tensione (V) 220/240 Ambiente di utilizzo Per interni Note Consumo totale del
SUPER FLAT SUSPENSION 90X90 UP&DOWN DALI VERSION Montaggio Sospeso a soffitto Descrizione delle lampade Top LED 4000K CRI 80 Tensione (V) 220/240 Ambiente di utilizzo Per interni Note Consumo totale del
Fondamenti di illuminotecnica
 Fondamenti di illuminotecnica Corso di Fisica Tecnica Ambientale Scienze dell Architettura Grandezze del moto oscillatorio E T λ (μm) Periodo T (s) tempo occorrente per compiere una oscillazione frequenza
Fondamenti di illuminotecnica Corso di Fisica Tecnica Ambientale Scienze dell Architettura Grandezze del moto oscillatorio E T λ (μm) Periodo T (s) tempo occorrente per compiere una oscillazione frequenza
KEY WORDS LA LUCE. Zumtobel. Dario Bettiol Settembre 2012 1 LANGEN FOUNDATION, NEUSS DE ARCHITETTURA: TADAO ANDO JP RENDIMENTO COSTI DI ESERCIZIO
 LA LUCE. Zumtobel. Dario Bettiol Settembre 2012 1 LANGEN FOUNDATION, NEUSS DE ARCHITETTURA: TADAO ANDO JP SERVICE COSTI DI ESERCIZIO BENESSERE SOSTENIBILITÀ RENDIMENTO SICUREZZA IDENTITÀ SALUTE KEY WORDS
LA LUCE. Zumtobel. Dario Bettiol Settembre 2012 1 LANGEN FOUNDATION, NEUSS DE ARCHITETTURA: TADAO ANDO JP SERVICE COSTI DI ESERCIZIO BENESSERE SOSTENIBILITÀ RENDIMENTO SICUREZZA IDENTITÀ SALUTE KEY WORDS
L energia assorbita dall atomo durante l urto iniziale è la stessa del fotone che sarebbe emesso nel passaggio inverso, e quindi vale: m
 QUESITI 1 Quesito Nell esperimento di Rutherford, una sottile lamina d oro fu bombardata con particelle alfa (positive) emesse da una sorgente radioattiva. Secondo il modello atomico di Thompson le particelle
QUESITI 1 Quesito Nell esperimento di Rutherford, una sottile lamina d oro fu bombardata con particelle alfa (positive) emesse da una sorgente radioattiva. Secondo il modello atomico di Thompson le particelle
Codice 30QP. Questa lampada assicura un flusso luminoso di 979 lumen con indice di resa cromatica superiore a 80 ed un consumo di 11,5 watt.
 SUPERFICIE 30 QUADRO PLAFONE 30QP 9.1 28.4 5.6 3.5 28.4 Codice 30QP Finitura: Withe RAL9003 / Custom Tecnologia Samsung mix Flusso luminoso: 979 lumen Potenza assorbita: 24Vdc 11,5 watt 350mA < 500mA CRI:
SUPERFICIE 30 QUADRO PLAFONE 30QP 9.1 28.4 5.6 3.5 28.4 Codice 30QP Finitura: Withe RAL9003 / Custom Tecnologia Samsung mix Flusso luminoso: 979 lumen Potenza assorbita: 24Vdc 11,5 watt 350mA < 500mA CRI:
Lampade con LED rossi per benessere notturno degli animali da allevamento
 Serie-LCS Lampade con LED rossi per benessere notturno degli animali da allevamento 2 Nozioni sul benessere delle bovine da latte Il benessere animale porta ad un miglioramento delle rese produttive delle
Serie-LCS Lampade con LED rossi per benessere notturno degli animali da allevamento 2 Nozioni sul benessere delle bovine da latte Il benessere animale porta ad un miglioramento delle rese produttive delle
E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la
 1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
1 E noto che la luce, o radiazione elettromagnetica, si propaga sottoforma di onde. Un onda è caratterizzata da due parametri legati fra loro: la lunghezza d onda ( ), definita come la distanza fra due
SCHEDA PRODOTTO ST MR W/827 GU5.3
 ST MR16 35 36 4.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 12 V Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali AREE APPLICATIVE Negozi Strutture ricettive Musei, gallerie d'arte Interni
ST MR16 35 36 4.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 12 V Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali AREE APPLICATIVE Negozi Strutture ricettive Musei, gallerie d'arte Interni
Gamma di LED retrofit Aura Light
 G a m a d i L E D r e t ro f i t Au r a l i g h t Gamma di retrofit Aura Light Risparmio energetico fino all 80% grazie alla semplice sostituzione di tubi e lampade alogene. Efficienza energetica Aura
G a m a d i L E D r e t ro f i t Au r a l i g h t Gamma di retrofit Aura Light Risparmio energetico fino all 80% grazie alla semplice sostituzione di tubi e lampade alogene. Efficienza energetica Aura
Lampade alogene Green Solutions
 Lampade alogene Green Solutions Forma Goccia GS contenute e rispecchiano le forme classiche delle lampadine ad incandescenza. Sono indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi
Lampade alogene Green Solutions Forma Goccia GS contenute e rispecchiano le forme classiche delle lampadine ad incandescenza. Sono indicate per apparecchi di illuminazione da tavolo, sistemi decorativi
DEFINIZIONI (D.Lgs. 81/08)
 Radiazioni Ottiche Artificiali -ROA- Cosa sono Anna Maria Vandelli Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Modena SPSAL Sassuolo Fonte ISPESL 1 DEFINIZIONI (D.Lgs. 81/08) si intendono per radiazioni ottiche:
Radiazioni Ottiche Artificiali -ROA- Cosa sono Anna Maria Vandelli Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Modena SPSAL Sassuolo Fonte ISPESL 1 DEFINIZIONI (D.Lgs. 81/08) si intendono per radiazioni ottiche:
3ª lezione. Generalità sulle lampade Corso di illuminotecnica
 Generalità Corso di illuminotecnica Criteri generali di scelta Per poter impostare razionalmente lo studio dei progetti di illuminazione è molto importante saper scegliere tra le varie sorgenti luminose
Generalità Corso di illuminotecnica Criteri generali di scelta Per poter impostare razionalmente lo studio dei progetti di illuminazione è molto importante saper scegliere tra le varie sorgenti luminose
manuale per le aziende di trattamento del CdC RAEE lampade fluorescenti
 manuale per le aziende di trattamento del CdC RAEE lampade fluorescenti LINEARI E COMPATTE Cenni storici Le lampade a fluorescenza rientrano nella categoria delle lampade a scarica, il cui primo esempio
manuale per le aziende di trattamento del CdC RAEE lampade fluorescenti LINEARI E COMPATTE Cenni storici Le lampade a fluorescenza rientrano nella categoria delle lampade a scarica, il cui primo esempio
DEFINIZIONE DI RADIANZA La radiazione è caratterizzata tramite la Radianza Spettrale, I (λ, θ, φ, T), definita come la densità di potenza per unità di
 SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
SISTEMI PASSIVI Ogni corpo a temperatura T diversa da 0 K irradia spontaneamente potenza elettromagnetica distribuita su tutto lo spettro Attraverso un elemento da della superficie del corpo, fluisce p
SERIE DI APPARECCHI SL 740 LED
 SERIE DI APPARECCHI SL 740 LED 2 3 3 CONTENUTO Lampada a sospensione quadrata Lampada da parete quadrata S.10 S.12 SL 740 LED Proiettore a sospensione Lampade a montaggio superficiale Piantana Apparecchio
SERIE DI APPARECCHI SL 740 LED 2 3 3 CONTENUTO Lampada a sospensione quadrata Lampada da parete quadrata S.10 S.12 SL 740 LED Proiettore a sospensione Lampade a montaggio superficiale Piantana Apparecchio
CORSO DI FISICA TECNICA Tecniche del COSTRUIRE AA 20010/11 ILLUMINOTECNICA. Lezione n 4: La luce naturale
 CORSO DI FISICA TECNICA Tecniche del COSTRUIRE AA 20010/11 ILLUMINOTECNICA Lezione n 4: La luce naturale 1 Il benessere visivo negli interni è fortemente influenzato dalla presenza in essi di luce naturale.
CORSO DI FISICA TECNICA Tecniche del COSTRUIRE AA 20010/11 ILLUMINOTECNICA Lezione n 4: La luce naturale 1 Il benessere visivo negli interni è fortemente influenzato dalla presenza in essi di luce naturale.
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
 Laser? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Produce un fascio coerente di radiazione ottica da una stimolazione elettronica, ionica, o transizione molecolare a più alti livelli energetici
Laser? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Produce un fascio coerente di radiazione ottica da una stimolazione elettronica, ionica, o transizione molecolare a più alti livelli energetici
La soluzione per esterni facile da installare che offre luce biancaaffidabile a efficienza energetica
 Lighting La soluzione per esterni facile da installare che offre luce biancaaffidabile a efficienza energetica MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra Lampade tubolari ad alogenuri metallici in ceramica di nuova
Lighting La soluzione per esterni facile da installare che offre luce biancaaffidabile a efficienza energetica MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra Lampade tubolari ad alogenuri metallici in ceramica di nuova
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA
 INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA. Anno accademico 2013/14. Figure utili da libri di testo
 Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
Università degli Studi di Milano Dipartimento di Fisica Corso di laurea triennale in FISICA Anno accademico 2013/14 Figure utili da libri di testo Onde & Oscillazioni Corso A Studenti con il cognome che
Sorgenti di luce Colori Riflettanza
 Le Schede Didattiche di Profilocolore IL COLORE Sorgenti di luce Colori Riflettanza Rome, Italy 1/37 La luce: natura e caratteristiche La luce è una radiazione elettromagnetica esattamente come lo sono:
Le Schede Didattiche di Profilocolore IL COLORE Sorgenti di luce Colori Riflettanza Rome, Italy 1/37 La luce: natura e caratteristiche La luce è una radiazione elettromagnetica esattamente come lo sono:
Spettroscopia. Spettroscopia
 Spettroscopia Spettroscopia IR Spettroscopia NMR Spettrometria di massa 1 Spettroscopia E un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni sulla struttura di una molecola attraverso l interazione
Spettroscopia Spettroscopia IR Spettroscopia NMR Spettrometria di massa 1 Spettroscopia E un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni sulla struttura di una molecola attraverso l interazione
Calcoli di illuminamento artificiale per interni. Prof. Ing. Cesare Boffa
 Calcoli di illuminamento artificiale per interni Illuminazione per interni Illuminazione Generale Localizzata D accento D effetto Mood lighting s a i Ambiente chiuso Coefficiente di assorbimento delle
Calcoli di illuminamento artificiale per interni Illuminazione per interni Illuminazione Generale Localizzata D accento D effetto Mood lighting s a i Ambiente chiuso Coefficiente di assorbimento delle
Le vecchie lampadine verranno sostituite dai LED?
 Per conoscere i prodotti Ledrich consultare il sito www.ledrichproject.com LEDRICH blog, 19 Maggio 2014 Le vecchie lampadine verranno sostituite dai LED? La sostituzione delle lampadine tradizionali con
Per conoscere i prodotti Ledrich consultare il sito www.ledrichproject.com LEDRICH blog, 19 Maggio 2014 Le vecchie lampadine verranno sostituite dai LED? La sostituzione delle lampadine tradizionali con
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA
 INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
INTRODUZIONE ALLA SPETTROMETRIA La misurazione dell assorbimento e dell emissione di radiazione da parte della materia è chiamata spettrometria. Gli strumenti specifici usati nella spettrometria sono chiamati
COMPARAZIONE COSTI LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO AL ALTA PRESSIONE VS LED BAY ECOMAA
 COMPARAZIONE COSTI LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO AL ALTA PRESSIONE VS LED BAY ECOMAA VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE PRINCIPALI LAMPADE UTILIZZATE NELL ILLUMINAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI, FABBRICHE,
COMPARAZIONE COSTI LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO AL ALTA PRESSIONE VS LED BAY ECOMAA VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE PRINCIPALI LAMPADE UTILIZZATE NELL ILLUMINAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI, FABBRICHE,
Lampade LED anti Black-Out
 NOVITÀ ANTEPRIMA MONDIALE Lampade LED anti Black-Out La lampada LED che si accende automaticamente in caso di mancanza di rete elettrica e non ti lascia mai al buio! Si usa come una normale lampadina;
NOVITÀ ANTEPRIMA MONDIALE Lampade LED anti Black-Out La lampada LED che si accende automaticamente in caso di mancanza di rete elettrica e non ti lascia mai al buio! Si usa come una normale lampadina;
Nozioni di illuminotecnica
 Corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione Nozioni di illuminotecnica Loredana Dioguardi Istituto di Ingegneria Agraria 17 giugno 2004 Argomenti della lezione Cos è la luce e le caratteristiche
Corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione Nozioni di illuminotecnica Loredana Dioguardi Istituto di Ingegneria Agraria 17 giugno 2004 Argomenti della lezione Cos è la luce e le caratteristiche
- Quantità e qualità della luce per ridurre i consumi e favorire lo svolgimento delle attività (benessere visivo)
 Quantità e qualità della luce Obbiettivi del progetto - Quantità e qualità della luce per ridurre i consumi e favorire lo svolgimento delle attività (benessere visivo) - Controllo della radiazione diretta
Quantità e qualità della luce Obbiettivi del progetto - Quantità e qualità della luce per ridurre i consumi e favorire lo svolgimento delle attività (benessere visivo) - Controllo della radiazione diretta
La candela. La storia della realizzazione della candela
 La candela La storia della realizzazione della candela 1860 La prima realizzazione di riferimento per la misura delle luce utilizza delle candele ricavate dal grasso di balena (spermaceti). 1898 Il passo
La candela La storia della realizzazione della candela 1860 La prima realizzazione di riferimento per la misura delle luce utilizza delle candele ricavate dal grasso di balena (spermaceti). 1898 Il passo
Università di Roma Sapienza Facoltà di Medicina e Odontoiatria. Ruolo dell illuminazione nell ipovisione. Nicola Pescosolido
 Università di Roma Sapienza Facoltà di Medicina e Odontoiatria Ruolo dell illuminazione nell ipovisione Nicola Pescosolido Grandezze fotometriche riassumendo. L intensità luminosa I (cd) genera un flusso
Università di Roma Sapienza Facoltà di Medicina e Odontoiatria Ruolo dell illuminazione nell ipovisione Nicola Pescosolido Grandezze fotometriche riassumendo. L intensità luminosa I (cd) genera un flusso
Onde e oscillazioni. Fabio Peron. Onde e oscillazioni. Le grandezze che caratterizzano le onde
 Onde e oscillazioni Lezioni di illuminotecnica. Luce e Onde elettromagnetiche Fabio Peron Università IUAV - Venezia Si parla di onde tutte le volte che una grandezza fisica varia la sua entità nel tempo
Onde e oscillazioni Lezioni di illuminotecnica. Luce e Onde elettromagnetiche Fabio Peron Università IUAV - Venezia Si parla di onde tutte le volte che una grandezza fisica varia la sua entità nel tempo
Uso razionale dell energia elettrica per l illuminazione di interni
 Uso razionale dell energia elettrica per l illuminazione di interni 12 Novembre 2004 Ing. Fabio Pedrazzi Ing. Stefano Caselli Beghelli S.p.A. Incidenza percentuale dell'illuminazione sul totale dei consumi
Uso razionale dell energia elettrica per l illuminazione di interni 12 Novembre 2004 Ing. Fabio Pedrazzi Ing. Stefano Caselli Beghelli S.p.A. Incidenza percentuale dell'illuminazione sul totale dei consumi
Illuminazione piacevole in un design minimalista
 2 ETAP Illuminazione piacevole in un design minimalista L illuminazione con diffusori è diventata un must assoluto per l illuminazione generale di uffici ed edifici pubblici: ciò non stupisce, dal momento
2 ETAP Illuminazione piacevole in un design minimalista L illuminazione con diffusori è diventata un must assoluto per l illuminazione generale di uffici ed edifici pubblici: ciò non stupisce, dal momento
Grandezze fotometriche
 3 Grandezze fotometriche Fabio Peron Alessandra Vivona Anno Accademico 2016-2017 Università IUAV di Venezia la proprietà letteraria e i diritti sono riservati agli autori il presente materiale può essere
3 Grandezze fotometriche Fabio Peron Alessandra Vivona Anno Accademico 2016-2017 Università IUAV di Venezia la proprietà letteraria e i diritti sono riservati agli autori il presente materiale può essere
Fabio Peron. Grandezze fotometriche. Sensibilità dell occhio umano. Sensibilità dell occhio umano
 Grandezze fotometriche Flusso luminoso caratteristica propria delle sorgenti luminose; Intensità luminosa caratteristica propria delle sorgenti luminose; Lezioni di illuminotecnica. Grandezze illuminotecniche
Grandezze fotometriche Flusso luminoso caratteristica propria delle sorgenti luminose; Intensità luminosa caratteristica propria delle sorgenti luminose; Lezioni di illuminotecnica. Grandezze illuminotecniche
CORSO DI FISICA TECNICA 2 AA 2013/14 ILLUMINOTECNICA. Lezione n 10: Fattore di luce diurna (DF - Daylight Factor) Ing.
 CORSO DI FISICA TECNICA 2 AA 2013/14 ILLUMINOTECNICA Lezione n 10: Fattore di luce diurna (DF - Daylight Factor) Ing. Oreste Boccia 1 Il fattore di luce diurna è un parametro molto utilizzato per controllare
CORSO DI FISICA TECNICA 2 AA 2013/14 ILLUMINOTECNICA Lezione n 10: Fattore di luce diurna (DF - Daylight Factor) Ing. Oreste Boccia 1 Il fattore di luce diurna è un parametro molto utilizzato per controllare
VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI LUCE DIURNA IN PRESENZA DI UNA SERRA SOLARE
 VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI LUCE DIURNA IN PRESENZA DI UNA SERRA SOLARE (Roberto Carratù giugno 2014) Premessa: Innanzi tutto si deve chiarire che il fattore di luce diurna non misura la quantità di luce
VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI LUCE DIURNA IN PRESENZA DI UNA SERRA SOLARE (Roberto Carratù giugno 2014) Premessa: Innanzi tutto si deve chiarire che il fattore di luce diurna non misura la quantità di luce
MOTTA MARIA LIDIA MOTTA ALESSANDRO
 Protocollo : V1515BPPA0 Revisione : 0 PARCHEGGIO Via Valletta Fogliano Data 13/03/2015 MOTTA MARIA LIDIA MOTTA ALESSANDRO Strada Vignazza n 24 LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI Via Valletta Fogliano AMBITO DI
Protocollo : V1515BPPA0 Revisione : 0 PARCHEGGIO Via Valletta Fogliano Data 13/03/2015 MOTTA MARIA LIDIA MOTTA ALESSANDRO Strada Vignazza n 24 LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI Via Valletta Fogliano AMBITO DI
La corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro e necessaria per consentire, in modo agevole,lo svolgimento delle mansioni in tutte le stag
 Unitamente ad altri fattori ambientali che condizionano lo stato di benessere, l illuminazione assume nel campo del lavoro una estrema importanza, in quanto un suo razionale impiego non solo favorisce
Unitamente ad altri fattori ambientali che condizionano lo stato di benessere, l illuminazione assume nel campo del lavoro una estrema importanza, in quanto un suo razionale impiego non solo favorisce
LUCE NECESSITA e RISORSA
 LUCE NECESSITA e RISORSA liceo scientifico Giordano Bruno Mestre - Venezia 11 febbraio 2010 LUCE ARTIFICIALE Nel 1876 Edison e Swan inventano la lampadina. A partire dalla seconda metà del 900, grazie
LUCE NECESSITA e RISORSA liceo scientifico Giordano Bruno Mestre - Venezia 11 febbraio 2010 LUCE ARTIFICIALE Nel 1876 Edison e Swan inventano la lampadina. A partire dalla seconda metà del 900, grazie
Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione
 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell energia UFE Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione nel 2014 13.11.2015
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell energia UFE Scheda informativa: il mercato svizzero dell illuminazione nel 2014 13.11.2015
isla led LA LUCE VERDE
 LA LUCE VERDE 29 4-6m SOLUZIONE LED LEGGERA ED ELEGANTE, OVUNQUE IN CITTÀ Palo dirit to 647 L apparecchio Isla dotato di LED è proposto con palo conico-cilindrico in acciaio zincato. Le caratteristiche
LA LUCE VERDE 29 4-6m SOLUZIONE LED LEGGERA ED ELEGANTE, OVUNQUE IN CITTÀ Palo dirit to 647 L apparecchio Isla dotato di LED è proposto con palo conico-cilindrico in acciaio zincato. Le caratteristiche
Capitolo 4. L Insolazione e la Temperatura.
 Capitolo 4. L Insolazione e la Temperatura. L energia di cui dispone la popolazione umana deriva direttamente o indirettamente dal Sole. Il Sole emette costantemente una radiazione di tipo elettromagnetico
Capitolo 4. L Insolazione e la Temperatura. L energia di cui dispone la popolazione umana deriva direttamente o indirettamente dal Sole. Il Sole emette costantemente una radiazione di tipo elettromagnetico
SPETTRO ELETTROMAGNETICO. Lunghezza d onda (m)
 SPETTRO ELETTROMAGNETICO Lunghezza d onda (m) ONDE RADIO λ 1 m f 3 10 8 Hz DOVE LE OSSERVIAMO? Radio, televisione, SCOPERTA Hertz (1888) Marconi: comunicazioni radiofoniche SORGENTE Circuiti oscillanti
SPETTRO ELETTROMAGNETICO Lunghezza d onda (m) ONDE RADIO λ 1 m f 3 10 8 Hz DOVE LE OSSERVIAMO? Radio, televisione, SCOPERTA Hertz (1888) Marconi: comunicazioni radiofoniche SORGENTE Circuiti oscillanti
ALESSANDRO MONTICELLI - LEDVANCE SpA TECNOLOGIA LED: LA NUOVA FRONTIERA DEL RISPARMIO ENERGETICO
 ALESSANDRO MONTICELLI - LEDVANCE SpA TECNOLOGIA LED: LA NUOVA FRONTIERA DEL RISPARMIO ENERGETICO 2 LEDVANCE: CHI SIAMO LEDVANCE SpA è la nuova società indipendente che nasce dalla divisione di OSRAM dedicata
ALESSANDRO MONTICELLI - LEDVANCE SpA TECNOLOGIA LED: LA NUOVA FRONTIERA DEL RISPARMIO ENERGETICO 2 LEDVANCE: CHI SIAMO LEDVANCE SpA è la nuova società indipendente che nasce dalla divisione di OSRAM dedicata
Illuminazione di Emergenza. Aspetti tecnico-normativi
 Illuminazione di Emergenza Aspetti tecnico-normativi Illuminazione di emergenza Definizione - Obbiettivo per illuminazione di emergenza si intende l illuminazione ausiliaria che interviene quando viene
Illuminazione di Emergenza Aspetti tecnico-normativi Illuminazione di emergenza Definizione - Obbiettivo per illuminazione di emergenza si intende l illuminazione ausiliaria che interviene quando viene
Compatte non integrate
 Lampade fluorescenti Compatte non integrate 31 Potenza Tonalità colore Attacchi CARATTERISTICHE 7W 55W Le Lampade Fluorescenti Compatte Beghelli consentono di portare il risparmio energetico anche nelle
Lampade fluorescenti Compatte non integrate 31 Potenza Tonalità colore Attacchi CARATTERISTICHE 7W 55W Le Lampade Fluorescenti Compatte Beghelli consentono di portare il risparmio energetico anche nelle
LED:SORGENTE LUMINOSA A BASSO CONSUMO VANTAGGI ED APPLICAZIONI. Saros Energia - Via gabelli, 17 Porcia (PN) - Tel. 0434-555156
 LED:SORGENTE LUMINOSA A BASSO CONSUMO VANTAGGI ED APPLICAZIONI Cos è un LED? I LED, anche chiamati diodi ad emissione di luce, sono molto più che semplici lampadine: sono sicuramente la nuova frontiera
LED:SORGENTE LUMINOSA A BASSO CONSUMO VANTAGGI ED APPLICAZIONI Cos è un LED? I LED, anche chiamati diodi ad emissione di luce, sono molto più che semplici lampadine: sono sicuramente la nuova frontiera
