LA GESTIONE IN EMERGENZA DEL PAZIENTE PEDIATRICO INTOSSICATO
|
|
|
- Evangelina Rosa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LA GESTIONE IN EMERGENZA DEL PAZIENTE PEDIATRICO INTOSSICATO Eduardo Ponticiello Coordinatore del Gruppo di studio di tossicologia pediatrica SIMEUP Dipartimento di Emergenze Pediatriche AORN Santobono-Pausilipon-SS Annunziata Le intossicazioni acute in età pediatrica rappresentano un problema sempre più pressante, non solo per gli operatori sanitari dei Dipartimenti di Emergenza Ospedalieri, ma per tutti gli operatori sanitari in ambito pediatrico. L immissione nell ambiente di oltre 2000 nuove sostanze chimiche ogni anno aumenta sempre di più il rischio di intossicazione. L evidente curiosità del bambino per l ambiente circostante, il desiderio di esplorarlo e di emulare gli adulti, rende i bambini particolarmente suscettibili alle intossicazioni acute. The American Association of Poison Control Centers riporta oltre un milione di casi di avvelenamento in bambini al di sotto dei 6 anni, circa casi in bambini tra 6 e 12 anni e circa nella fascia d età tra 13 e 19 anni. In Italia le intossicazioni acute in età pediatrica rappresentano circa il 3% dei ricoveri ospedalieri, circa il 7% dei ricoveri d urgenza, con un tasso di mortalità che oscilla tra 0.1% e 0.3%. Le intossicazioni acute in età pediatrica rappresentano oltre il 40% dei casi di avvelenamento segnalati ai Centri Anti Veleno. In ogni caso, il numero dei casi pediatrici di intossicazione acuta è certamente sottostimato, in quanto molti sono i casi non segnalati ai Centri Anti Veleno (CAV) ed ai Dipartimenti di Emergenza. Nella casistica dell Ospedale Santobono di Napoli, i casi di intossicazione acuta risultano attestarsi intorno allo 0.7% del numero totale degli accessi in pronto Soccorso. Nel lattante e nella prima infanzia il motivo più frequente di intossicazione acuta è rappresentato da errore di somministrazione terapeutico qualitativo o quantitativo, in genere accidentale, mentre al di sopra dei 10 anni, l intossicazione è spesso volontaria ed è a scopo suicida-dimostrativo e più frequente nel sesso femminile. Le sostanze più frequentemente coinvolte nell intossicazione acuta sono i farmaci in circa il 30% dei casi, seguite da prodotti per l igiene domestica nel 27% dei casi ed in percentuali nettamente minori altre sostanze come pesticidi (6.8%), alimenti (4.7%), prodotti industriali (3%), piante (2.3%), punture o morsi di animali (2%), sostanze d abuso (1.5%). I farmaci variamente colorati, spesso dall odore o sapore gradevoli, sollecitano il bambino per il loro aspetto e per spirito di emulazione dell adulto. Altrettanto accade per i prodotti per la pulizia domestica, che spesso sono contenuti in recipienti dai colori vivaci, che naturalmente attirano l attenzione la curiosità del bambino. I luoghi nei quali avviene l intossicazione mostrano nettissima predominanza dell ambito domestico in circa 88% dei casi ed in circa 80% dei casi la modalità di intossicazione è rappresentata dall ingestione. In circa il 92% dei casi l intossicazione avviene in maniera accidentale, mentre è volontaria soltanto nello 0.9%. Le intossicazioni acute in età pediatrica si realizzano soprattutto in fasce orarie corrispondenti ad una maggiore disattenzione dei genitori, in particolare appaiono più a rischio la fascia oraria e 18-21, in cui generalmente le madri sono impegnate nella preparazione dei pasti e conseguentemente meno attente alla sorveglianza dei bambini. La gestione in emergenza del paziente pediatrico intossicato, si realizza attraverso la valutazione di 3 fondamentali aspetti: potenziale tossicità della sostanza, riduzione dell assorbimento della sostanza tossica, possibile inattivazione della tossicità della sostanza già assorbita. La peculiarità del paziente pediatrico è rappresentata dall effetto della sostanza in relazione all età ed al peso, circostanze in cui si realizza l intossicazione, valutazione clinica dei parametri vitali ed eventuale stabilizzazione degli stessi. Per ciò che concerne la possibile tossicità della sostanza, è fondamentale ricordare che l esposizione ad una sostanza tossica o potenzialmente tale non implica necessariamente evidenza dei sintomi, né che si renda sempre necessario l intervento terapeutico. Fortunatamente non tutte le sostanze con cui i bambini entrano in contatto sono pericolose, molte sono sostanze prive di tossicità (ad esempio matite contenenti grafite,
2 acquarelli, pennarelli, pennarello cancellabile, pastelli a cera, evidenziatori, evidenziatori indelebili, inchiostro da penna sfera, inchiostro per tampone di timbri, gomma per cancellare, gesso) per le quali il bambino non va indirizzato al Pronto Soccorso e si può non riferirsi al CAV ed altre a bassa tossicità (Makeup, mascara, rossetti, smalto per unghie, trucco per occhi, lozione e creme solari, deodoranti, fazzolettini igienici, acqua di colonia, creme a base di ossido di zinco, amido, argilla, candele, carbone, cenere di sigaretta, filtro di sigaretta non fumata, colla al ciano acrilato, foglio di alluminio, fotografie, giornale, silica gel, cibo per gatti, lettiera per gatti, pannolini, plastica, ruggine, saccarina, stucco, terriccio, insetticidi a base di piretro e piretroidi, detersivi per piatti o bucato a mano, fertilizzanti per piante, Candeggina con concentrazioni di ipoclorito di sodio < 5%, cere per mobili e pavimenti, cere e lucidi per calzature, bagno schiuma, balsamo per capelli, shampoo non medicati, saponi o saponette, schiuma da barba, creme idratanti, antiacidi ed adsorbenti, fermenti lattici, creme antibiotiche, pillole anticoncezionali, vitamine salvo vit. A e vit. D ) per le quali se il bambino viene condotto presso il DEA, dopo valutazione clinica, può essere dimesso a domicilio. L approccio al paziente pediatrico intossicato riconosce differenti momenti, strettamente concatenati, spesso da effettuare in tempi estremamente ristretti. L anamnesi tossicologica costituisce il primum movens dell approccio al paziente intossicato, ed è di capitale importanza. E fondamentale informarsi bene circa la sostanza in causa, chiedendo il contenitore originale, modalità di intossicazione, tempo intercorso tra l evento e l osservazione, quantità della sostanza. Ricordiamo che per i prodotti per la pulizia domestica,in età prescolare e scolare in genere l intossicazione è per lo più un assaggio, per cui la quantità di sostanza tossica è generalmente modica, mentre nell età adolescenziale di contro l ingestione avviene per fini dimostrativi o francamente suicidari, pertanto le quantità in questione sono più cospicue. Ai fini di un corretto inquadramento diagnostico e di un mirato intervento terapeutico, è utile ricordare qual è la differenza tra sostanza caustica e semplicemente irritante se ci riferiamo al ph della sostanza. Le sostanze caustiche, estremamente pericolose, risultano quelle con un ph al di sotto di 2 (sostanze acide che realizzano danno tissituale determinando necrosi coagulativa secondario ad azione degli idrogenioni) o con un ph superiore a 11 (sostanze basiche che realizzano necrosi colliquativa per azione ossidrilica). Nel range di ph compreso tra 2 ed 11, si colloca una vasta gamma di prodotti, che sono solo irritanti (ad esempio, che prevedono un iter diagnostico meno invasivo (inutile ad esempio praticare esofago-gastro-duodeno-scopia) ed un approccio terapeutico facilmente realizzabile anche al di fuori delle aree emergenziali. E altrettanto opportuno rammentare che l azione caustica può essere anche indipendente dal ph della sostanza, come è il caso dei Sali quaternari dell ammonio o del perossido di idrogeno, il cui ph è compreso tra 4 e 7, che elicitano lesività mediante per ossidazione dei tessuti.purtroppo molto spesso i prodotti per l igiene domestica vengono conservati in contenitori non originali, per cui non ne è noto il ph, e per ovviare a tale limite, l utilizzo di una cartina al tornasole, presidio di facile utilizzo e bassissimo costo, può essere di grande ausilio. Anche in caso di intossicazione da farmaci, sia per ingestione accidentale che per errore quantitativo nella somministrazione, l anamnesi riconosce un ruolo determinante. In tali intossicazioni va sempre indagata la dose di farmaco assunta, valutando qual è la dose minima in grado di produrre sintomi, il tempo intercorso tra assunzione ed eventuale sintomatologia, l eventuale concomitante assunzione di altri farmaci. Naturalmente la valutazione clinica del paziente ha un ruolo centrale in tossicologia pediatrica, e viene effettuata secondo i dettami delle linee guida del Pediatric Advanced Life Support, con una valutazione primaria on the door (aspetto, tipo di respiro, refill cutaneo), seguita poi da una valutazione secondaria indirizzata alla storia e meccanismo della lesione, con dettagliato esame obiettivo, e successive rivalutazioni. L esame clinico deve valutare attentamente l attività respiratoria (frequenza e tipo di respiro, ascoltazione toracica,colorito cutaneo) e cardiocircolatoria (frequenza, ritmo, pressione arteriosa, refill capillare), fondamentale l esame neurologico che da solo può orientare la diagnosi, come in caso di intossicazione da
3 atropina e scopolamina, da oppiacei, da benzodiazepine o barbiturici, da sostanze d abuso. L esame neurologico deve tener conto di livello di coscienza (AVPU), tipo di comportamento del paziente (agitazione, orientamento spazio-temporale), stato delle pupille, riflessi, andatura e convulsioni. Vi sono alcune sindromi caratteristiche, la cui presentazione è tipica, e che indirizzano la diagnosi tempestivamente. La sindrome anti colinergica (caratterizzata da tachicardia, midriasi, xerostomia, riduzione della peristalsi intestinale,alterazioni del sensorio) è ad esempio tipicamente peculiare dell intossicazione da alcuni farmaci (atropina),o funghi (amanita muscaria), mentre la sindrome colinergica (caratterizzata da miosi, bradicardia, sudorazione profusa,scialorrea, broncorrea, vomito) è tipicamente presente nelle intossicazioni da esteri organo fosforici e carbamati, come pure da fisostigmina ed alcuni funghi (es.clitocybe). Il laboratorio d analisi, supporta il dipartimento d emergenza, svolgendo un ruolo fondamentale, permettendo di confermare o escludere il sospetto tossicologico ed indirizzando spesso la scelta terapeutica, ma anche stabilendo l eventuale durata del trattamento terapeutico e consentendo di monitorare lo stato del paziente intossicato. Nella diagnosi di intossicazione acuta sono utilmente impiegati sia esami di routine che specifici test analitico-tossicologici. Altrettanto di fondamentale supporto è la diagnostica strumentale, l elettrocardiografia ad esempio è una tecnica semplice, normalmente utilizzata in tutti i dipartimenti d emergenza, che è spesso indicata, anche nell intossicazione da sostanze primitivamente non cardiotossiche come ad esempio alcuni neuro psicofarmaci. Alterazioni del tratto QT e del complesso QRS sono tipicamente presenti nelle intossicazioni da neurospicolettici ed antidepressivi, che sono abbastanza frequenti in età pediatrica per ingestione accidentale di tali farmaci usati ad esempio dai nonni. La radiografia è altrettanto utilissima, come accade in caso di ingestione di sostanze radiopache (es. solventi clorurati e preparati a base di ferro). L esofagogastroduodenoscopia è fondamentale per la diagnosi ed il grading delle lesioni da caustici o ai fini terapeutici per rimozione delle pile al litio, causa di una temibile emergenza tossicologica. Prescindendo dalle manovre aspecifiche di supporto alle funzioni vitali, il trattamento in emergenza del bambino intossicato si fonda su tre elementi fondamentali specifici: la decontaminazione per impedire o ridurre l assorbimento della sostanza tossica, l impiego di antidoti specifici e tecniche di depurazione per ridurre il carico della sostanza tossica già assorbita. Va sottolineato come alcuni interventi terapeutici, purtroppo ancora oggi erroneamente effettuati, non sono soltanto inutili, ma in alcune occasioni addirittura dannosi. E opportuno a tal proposito ricordare di non indurre il vomito in caso di ingestione di sostanza caustica ( al fine di evitare un secondo passaggio esofageo del caustico) o di sostanza schiumogena (riduzione della possibilità di inalazione). L intervento di decontaminazione è particolarmente indicato nei casi di intossicazione secondaria ad ingestione, e se effettuato in tempi rapidi limita o previene l assorbimento del tossico già presente nel tratto digerente. Sono disponibili diverse tecniche di decontaminazione, che differiscono tra loro per applicabilità e limiti. Tali interventi sono rappresentati da: induzione del vomito, gastrolusi per la decontaminazione del tratto digerente superiore, la catarsi ed il lavaggio intestinale per il tratto inferiore. La somministrazione di sostanze adsorbenti come il carbone attivato, come poi riportato in seguito, trova indicazione in associazione alle tecniche di decontaminazione ma anche in alcuni casi indipendentemente da esse. Le indicazioni di ciascuna tecnica di decontaminazione sono legate a diversi fattori quali la natura della sostanza tossica, il tempo trascorso dall assunzione del tossico, e le condizioni cliniche del paziente intossicato. Non vi è quindi una singola strategia ma scelte terapeutiche ragionate. Per quanto concerne l induzione del vomito, prevede l utilizzo di farmaci emetici come l ipecacuana, tale intervento è però gravato da un elevata quota di controindicazioni quali: età < 6 mesi, compromissione vie aeree, convulsioni presenti o prevedibili entro 1h (sostanze attive sul SNC), ingestione di sostanze con alto
4 grado di aspirazione (idrocarburi), ingestione di caustici, ipertensione endocranica, ed uso di anticoagulanti. Peraltro l uso di tale farmaco non è scevro da complicanze (emesi protratta per più di 1 ora,sonnolenza/ipereccitabilità, tossicità cardiaca) pertanto l uso di tale tecnica è molto limitato nel paziente pediatrico. La gastrolusi invece costituisce, quando indicato e se non trascorso troppo tempo dall assunzione della sostanza tossica, un valido presidio terapeutico. Tale tecnica consiste nello svuotamento meccanico dello stomaco mediante inserimento di sonda oro-gastrica o naso-gastrica. Sulla base degli studi sperimentali e clinici, lo svuotamento gastrico dovrebbe essere considerato solo se attuabile entro 60 minuti dall ingestione di una sostanza tossica in dosi potenzialmente pericolose per la vita del paziente, ma nella pratica clinica i limiti temporali e l utilità di questa manovra possono variare in considerazione di diversi fattori quali: ingestione recente di una sostanza in quantità tossica e non sufficientemente assorbibile dalla sola somministrazione di carbone attivato, ingestione di una sostanza altamente tossica, per cui anche la rimozione di una piccola quantità può essere cruciale per la sopravvivenza del paziente, ingestione d'agenti che possono formare concrezioni gastriche e/o a rilascio protratto e rallentato di sostanze tossiche (aspirina, teofillina, barbiturici, farmaci in formulazioni retard), presenza di condizioni cliniche in cui vi sia un rallentato svuotamento gastrico (coma, pasto ricco e copioso, co-ingestione di alcool o agenti ad azione anticolinergica). In linea generale le indicazioni alla gastrolusi sono rappresentate da: esecuzione entro 60 minuti dall'ingestione, in pazienti coscienti dopo ingestione di tossico pericoloso. Le controindicazioni invece includono: ingestione di sostanze caustiche o schiumogene, ferro, ingestione di sostanze ad alto potenziale di aspirazione (idrocarburi), vie aeree non protette (alterazione stato di coscienza), pazienti a rischio di emorragia o perforazione (patologie sottostanti o interventi chirurgici recenti). La gastrolusi permette di aspirare il contenuto dello stomaco fino allo svuotamento e, se indicato, conservare un campione dell aspirato da poter analizzare. La tecnica prevede l introduzione di un sondino nasogastrico mediante il quale si attua il lavaggio della cavità gastrica introducendo per gavage, piccoli volumi di soluzione fisiologica riscaldata ( ml a seconda dell età del bambino, fino a 50 ml nel bambino fino a 5 anni, fino a 100 ml tra 5 e 12 anni). L introduzione del sondino naso-gastrico viene effettuata immobilizzando il bambino in decubito laterale sinistro e lieve Trendelenburg (tale postura consente di pescare più facilmente, con la sonda, il contenuto gastrico che si viene a raccogliere lungo la grande curvatura dello stomaco). La gastrolusi permette inoltre la somministrazione di carbone attivato attraverso il sondino. Il carbone vegetale attivato è una polvere insolubile, inodore, insapore, di colore nero, di origine naturale resa attiva con mezzi fisici o chimici ad alte temperature, in modo da aumentare la capacità adsorbente che da 2-4 mq/gr arriva a mq/gr, con la formazione di minuscole particelle porose. Il Carbone Vegetale Attivato, una volta ingerito, attraverso i micropori, adsorbe la sostanza tossica con cui viene a contatto nel tratto gastrointestinale, riducendone la quantità assorbibile attraverso un meccanismo di legame sostanza tossica-carbone attivato e successiva escrezione fecale. Perché sia efficace, va somministrato il più precocemente possibile in dosi 10 volte maggiori alla dose di sostanza tossica assunta. La dose prevista nei bambini fino a 12 anni è di 0,5-1g/kg che è possibile somministrare in dose multipla ogni 2-6 ore, in caso di di assunzione di tossici in dosi elevate, farmaci retard, tossici che rallentano la motilità gastrointestinale o tossici ad elevata escrezione biliare e ricircolo enteroepatico. Le controindicazioni o limiti all uso sono rappresentati da ingestione di Idrocarburi, acidi, alcali, alcoli, ferro, litio o concomitante presenza di lesioni del tratto gastrointestinale. Il carbone vegetale attivato è praticamente sprovvisto di effetti indesiderati, è facilmente reperibile ed a basso costo.
5 La catarsi salina è una tecnica di decontaminazione che promuove l eliminazione del complesso tossicocarbone attivo, accelerandone il transito gastrointestinale e viene eseguita attraverso la somministrazione di Solfato di magnesio 250mg/kg nel bambino > 6 anni, e può essere utilizzata solo in casi specifici legati alle caratteristiche della sostanza ingerita e alle condizioni cliniche del paziente. Il lavaggio intestinale consta della somministrazione per via enterale di una soluzione osmoticamente bilanciata che determina la propulsione e l eliminazione per via rettale delle sostanze presenti nel tratto gastrointestinale. Le indicazioni al lavaggio intestinale sono rappresentate da : eliminazione tossici non più recuperabili con emesi o gastrolusi o non adsorbiti dal carbone vegetale attivato (es. metalli) oppure da ingestione di farmaci a lento rilascio o a rilascio enterico o che formano conglomerati gastrici. Le controindicazioni sono costituite da depressione SNC e concomitanza di patologie intestinali. Va sottolineato che l intossicazione non si realizza solamente per ingestione, ma anche per contatto cutaneo ed oculare. Anche in tali casi, sono disponibili interventi di decontaminazione. La decontaminazione cutanea prevede l allontanamento dei vestiti, il lavaggio della superficie (unghie pieghe ed orecchie) con acqua tiepida per 15min o con acqua e sapone (in caso di intossicazione da polifenoli aggiunta di glicerolo). Inoltre vi è la possibilità di inattivare la sostanza tossica che in alcuni casi sarebbe assorbita per via cutanea, ad esempio l uso di pomate contenenti Calcio gluconato è indicato nell intossicazione per contatto cutaneo da Ac. Fluoridrico che determina gravissime conseguenze locali, con esiti invalidanti, come pure l uso di preparati al Permanganato di potassio per avvelenamenti da fosforo giallo o di somministrazione locale di Acido acetico per lesioni da contatto con medusa. Altra frequente condizione è il contatto oculare con sostanze tossiche che si giova di tecniche di decontaminazione. Il lavaggio oculare immediato è utile per lesioni da acidi e va protratto per 15 minuti, mentre nelle lesioni da alcali per 30 minuti e ciclicamente ripetuto sino alla visita oculistica. Naturalmente molte intossicazioni possono essere risolte da un trattamento antitodico, soprattutto se già assorbite o se controindicate le tecniche di decontaminazione. Gli antidoti sono sostanze che con meccanismo specifico o aspecifico hanno un ruolo centrale nel trattamento del bambino intossicato e vengono per lo più utilizzati contestualmente alle tecniche di decontaminazione ed alle terapie aspecifiche di supporto delle funzioni vitali. L indicazione all uso di un antidoto, dipende naturalmente in primo luogo dalla sostanza che determina intossicazione, ma anche dalle condizioni cliniche e dalla sicurezza dello stesso antidoto. Spesso il trattamento antidotico può essere effettuato solo sulla scorta del dato anamnestico, altre volte invece sulla concordanza del dato anamnestico con il quadro clinico e con il supporto degli esami laboratoristici. Alcuni antidoti sono di provata efficacia e risolvono rapidamente il quadro sintomatologico, come ad esempio accade per il naloxone ed il flumazenil, che sono utilizzati rispettivamente per le intossicazioni da oppiacei e da benzodiazepine. Alcuni antidoti sono considerati dei veri e propri farmaci salvavita, e risultano essere l unico intervento terapeutico in grado di risolvere l intossicazione, ne sono esempio i Fab-antidigitalici e l idrossicobalamina nell intossicazione da cianuri. Anche nel trattamento antidotico, la tempistica della somministrazione è fondamentale, infatti la somministrazione tardiva può condizionare la restitutio ad integrum, è il caso ad esempio della somministrazione di naloxone, che spiazza dal recettore il legame degli oppiacei, e se effettuata tardivamente non risolve l ipossia cerebrale già instauratasi. Il trattamento antidotico quindi non può prescindere oltre che dalla conoscenza degli effetti dello stesso antidoto, anche dalla conoscenza del corretto momento d impiego. Pertanto gli antidoti, in base alla priorità di impiego, possono essere suddivisi in tre categorie: antidoti di impiego immediato (entro 30 minuti), antidoti disponibili entro 2 ore ed antidoti disponibili entro 6 ore. Naturalmente non tutti gli antidoti sono disponibili presso qualsiasi dipartimento d emergenza, ma i centri antiveleno sul territorio nazionale provvedono a verificarne disponibilità, allocazione delle scorte e ne permettono l approvvigionamento anche con trasporti speciali d urgenza.
6 In ogni caso la disponibilità della consulenza telefonica con i centri antiveleno territoriali, che offrono assistenza telefonica sulle 24 ore permette agli operatori dei dipartimenti di emergenza pediatrici il counseling tossicologico. Il pediatra che vi si rivolge deve riferire le seguenti fondamentali informazioni: età e peso dell intossicato, tempo trascorso dall esposizione al tossico, nome del prodotto (in caso di farmaci o simili tenere a portata di mano la confezione),modalità di esposizione: ingestione, inalazione, contatto cutaneo, quantità approssimativa di tossico assunta, sintomi presentati dall intossicato (ad esempio: pianto, bocca sporca di prodotto o arrossata, alitosi, vestiti sporchi etc.). In conclusione quindi, la diffusione della cultura tossicologica, la conoscenza del grado di tossicità delle sostanze con cui più comunemente il bambino entra in contatto, il corretto approccio anamnestico e terapeutico e la sua tempestività, la correttezza del contatto con i centri antiveleno, possono e devono determinare la riduzione della frequenza con cui si realizzano le intossicazioni, delle complicanze che ne derivano, determinando altresì il decremento dell ospedalizzazione dei piccoli pazienti in termini di quantità e durata.
GLI AVVELENAMENTI ACUTI NELL INFANZIA
 Ogni anno: 2 milioni di bambini < 5 a ricorrono alle cure del Pediatra USA: quarta causa di morte EU : sesta causa di morte per eventi accidentali Ogni anno in EU: 170.000 bambini sono vittime di avvelenamenti
Ogni anno: 2 milioni di bambini < 5 a ricorrono alle cure del Pediatra USA: quarta causa di morte EU : sesta causa di morte per eventi accidentali Ogni anno in EU: 170.000 bambini sono vittime di avvelenamenti
La casa dei veleni. Come proteggere i bambini dalle intossicazioni domestiche. Campagna di prevenzione delle intossicazioni acute in età pediatrica
 La casa dei veleni Come proteggere i bambini dalle intossicazioni domestiche Campagna di prevenzione delle intossicazioni acute in età pediatrica 2003-2004 U.O. Prevenzione, Direzione Generale Sanità -
La casa dei veleni Come proteggere i bambini dalle intossicazioni domestiche Campagna di prevenzione delle intossicazioni acute in età pediatrica 2003-2004 U.O. Prevenzione, Direzione Generale Sanità -
AVVELENAMENTO NEL BAMBINO
 www.slidetube.it AVVELENAMENTO NEL BAMBINO COS É UN VELENO Tutte le sostanze sono veleni e nessuna è innocua solo la dose determina l avvelenamento. COS É UN VELENO Si definisce veleno qualunque sostanza
www.slidetube.it AVVELENAMENTO NEL BAMBINO COS É UN VELENO Tutte le sostanze sono veleni e nessuna è innocua solo la dose determina l avvelenamento. COS É UN VELENO Si definisce veleno qualunque sostanza
Sostanze d abuso EDUARDO PONTICIELLO
 Sostanze d abuso EDUARDO PONTICIELLO Cocaina L esposizione accidentale si può realizzare in diversi modi: 1. Attraverso il latte materno 2. Inalazione di vapori di droghe 3. Ingestione o contatto della
Sostanze d abuso EDUARDO PONTICIELLO Cocaina L esposizione accidentale si può realizzare in diversi modi: 1. Attraverso il latte materno 2. Inalazione di vapori di droghe 3. Ingestione o contatto della
LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA
 LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA IL RISCHIO CHIMICO protocollo d intesa 5 febbraio 2015 ASL Brescia ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro Ufficio Scolastico
LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA IL RISCHIO CHIMICO protocollo d intesa 5 febbraio 2015 ASL Brescia ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro Ufficio Scolastico
ANALISI EPIDEMIOLOGICA DELLE INTOSSICAZIONI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NEL QUINQUENNIO
 Dipartimento Farmaceutico Interaziendale ANALISI EPIDEMIOLOGICA DELLE INTOSSICAZIONI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NEL QUINQUENNIO 2005- Dotazione, Disponibilità e uso degli antidoti nella Regione Emilia
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale ANALISI EPIDEMIOLOGICA DELLE INTOSSICAZIONI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA NEL QUINQUENNIO 2005- Dotazione, Disponibilità e uso degli antidoti nella Regione Emilia
Campagna di prevenzione degli infortuni domestici. Servizio Medicina Preventiva delle Comunità gennaio 2003
 Campagna di prevenzione degli infortuni domestici Servizio Medicina Preventiva delle Comunità gennaio 2003 Epidemiologia Circa un terzo di tutte le morti accidentali circa 6000 persone/anno muoiono per
Campagna di prevenzione degli infortuni domestici Servizio Medicina Preventiva delle Comunità gennaio 2003 Epidemiologia Circa un terzo di tutte le morti accidentali circa 6000 persone/anno muoiono per
Incontro con la Polizia Locale di Milano. Gestione del soccorso in animali avvelenati
 Incontro con la Polizia Locale di Milano Gestione del soccorso in animali avvelenati Milano, 28 aprile 2016 INTRODUZIONE Per sostanza tossica si intende ogni componente chimico o miscela di più componenti
Incontro con la Polizia Locale di Milano Gestione del soccorso in animali avvelenati Milano, 28 aprile 2016 INTRODUZIONE Per sostanza tossica si intende ogni componente chimico o miscela di più componenti
SIMEUP TOSSICOLOGIA CLINICA. Piano Formativo Nazionale SIMEUP 2015
 SIMEUP Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica Piano Formativo Nazionale SIMEUP 2015 TOSSICOLOGIA CLINICA Direttore del corso: Eduardo PONTICIELLO (Napoli) NAPOLI, 12 giugno 2015 Direzione
SIMEUP Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica Piano Formativo Nazionale SIMEUP 2015 TOSSICOLOGIA CLINICA Direttore del corso: Eduardo PONTICIELLO (Napoli) NAPOLI, 12 giugno 2015 Direzione
Il veleno è una sostanza che introdotta nell organismo, in quantità sufficiente, provoca danni temporanei o permanenti
 AVVELENAMENTI Il veleno è una sostanza che introdotta nell organismo, in quantità sufficiente, provoca danni temporanei o permanenti Vie di penetrazione Le sostanze tossiche possono penetrare attraverso
AVVELENAMENTI Il veleno è una sostanza che introdotta nell organismo, in quantità sufficiente, provoca danni temporanei o permanenti Vie di penetrazione Le sostanze tossiche possono penetrare attraverso
PERICOLI E RISCHI ASSOCIATI AI PRODOTTI FITOSANITARI IL RISCHIO BIOLOGICO
 Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 misura 111 informazione (DGR n. 762 del 28/06/2013) Domanda di aiuto n 94752283427: norme obbligatorie in materia di sicurezza del lavoro PERICOLI E RISCHI
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 misura 111 informazione (DGR n. 762 del 28/06/2013) Domanda di aiuto n 94752283427: norme obbligatorie in materia di sicurezza del lavoro PERICOLI E RISCHI
PRODOTTI DOMESTICI. Francesca Assisi
 PRODOTTI DOMESTICI Francesca Assisi Agenti domestici per il cane da SATV 96-2003 glicole etil 25% ipoclorito 34% naftalina 25% Canfora 9% canfora gasolio 7% PRODOTTI DOMESTICI modalità di intossicazione
PRODOTTI DOMESTICI Francesca Assisi Agenti domestici per il cane da SATV 96-2003 glicole etil 25% ipoclorito 34% naftalina 25% Canfora 9% canfora gasolio 7% PRODOTTI DOMESTICI modalità di intossicazione
PROCEDURE HEMS ASSOCIATION VIE DI SOMMINISTRAZIONE ALTERNATIVE DEI FARMACI. Dott. Andrea Paoli Dott. Giovanni Cipolotti
 PROCEDURE HEMS ASSOCIATION VIE DI SOMMINISTRAZIONE ALTERNATIVE DEI FARMACI Dott. Andrea Paoli Dott. Giovanni Cipolotti Vie di somministrazione INTRANASALE INTRAOSSEA Via Intranasale Offre numerosi vantaggi,
PROCEDURE HEMS ASSOCIATION VIE DI SOMMINISTRAZIONE ALTERNATIVE DEI FARMACI Dott. Andrea Paoli Dott. Giovanni Cipolotti Vie di somministrazione INTRANASALE INTRAOSSEA Via Intranasale Offre numerosi vantaggi,
Scheda di sicurezza materiale
 Pag. 1/5 1. Identificazione prodotto e nome della società Nome commerciale: Fabbricante: STONE P STONE P FREE SWEDEN & MARTINA SPA Via Veneto 10 35020 DUE CARRARE (pd9 Informazioni d emergenza: 049 9124300
Pag. 1/5 1. Identificazione prodotto e nome della società Nome commerciale: Fabbricante: STONE P STONE P FREE SWEDEN & MARTINA SPA Via Veneto 10 35020 DUE CARRARE (pd9 Informazioni d emergenza: 049 9124300
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO E DEL FABBRICANTE
 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO E DEL FABBRICANTE PRODOTTO: NEW PROSEPT SPRAY FABBRICANTE: DEI ITALIA S.r.l. Via Torino 765 21020 Mercallo ( Varese ) Tel. 0331 / 969270 Fax 0331 / 969271 e.mail:
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO E DEL FABBRICANTE PRODOTTO: NEW PROSEPT SPRAY FABBRICANTE: DEI ITALIA S.r.l. Via Torino 765 21020 Mercallo ( Varese ) Tel. 0331 / 969270 Fax 0331 / 969271 e.mail:
MOLLUSCHICIDI. solfato di rame sali di zinco sali di stagno organici calciocianamide trilmorfolina niclosamide. metaldeide methiocarb
 MOLLUSCHICIDI FITOFARMACI IMPIEGATI CONTRO MOLLUSCHI NOCIVI PER LE COLTURE E CONTRO QUELLI CHE FUNGONO DA OSPITE INTERMEDIO PER ELMINTI solfato di rame sali di zinco sali di stagno organici calciocianamide
MOLLUSCHICIDI FITOFARMACI IMPIEGATI CONTRO MOLLUSCHI NOCIVI PER LE COLTURE E CONTRO QUELLI CHE FUNGONO DA OSPITE INTERMEDIO PER ELMINTI solfato di rame sali di zinco sali di stagno organici calciocianamide
INTERAZIONI FARMACOLOGICHE
 INTERAZIONI FARMACOLOGICHE Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze B. B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria Del Zompo INTERAZIONI
INTERAZIONI FARMACOLOGICHE Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze B. B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria Del Zompo INTERAZIONI
Il Triage. Il triage non serve a diminuire i tempi d attesa ma a ridistribuire i pazienti in favore di chi è più grave LE FASI DEL PROCESSO DI TRIAGE
 Il Triage Roberto Caronna Dipartimento di Scienze Chirurgiche UOC Chirurgia Generale N Il triage non serve a diminuire i tempi d attesa ma a ridistribuire i pazienti in favore di chi è più grave roberto.caronna@uniroma1.it
Il Triage Roberto Caronna Dipartimento di Scienze Chirurgiche UOC Chirurgia Generale N Il triage non serve a diminuire i tempi d attesa ma a ridistribuire i pazienti in favore di chi è più grave roberto.caronna@uniroma1.it
SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA
 SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA (DIRETTIVE CEE 88/379-93/112-D.M. SANITA' 28-1-92) 1. - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' RESPONSABILE DELL' IMMISSIONE IN COMMERCIO : Nome del
SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA (DIRETTIVE CEE 88/379-93/112-D.M. SANITA' 28-1-92) 1. - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' RESPONSABILE DELL' IMMISSIONE IN COMMERCIO : Nome del
SMAC SCIOGLICALCARE GEL
 SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA Conforme a 91/155 CEE 1.-IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' Nome del prodotto : Tipo di prodotto e impiego :Disincrostante acido per l'eliminazione dei depositi di
SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA Conforme a 91/155 CEE 1.-IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' Nome del prodotto : Tipo di prodotto e impiego :Disincrostante acido per l'eliminazione dei depositi di
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Acido L(+)-Lattico 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Acido L(+)-Lattico 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
Ammonio Carbonato PA-ACS 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Ammonio Carbonato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Ammonio Carbonato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA E DEI DISTURBI CORRELATI AGLI OPPIOIDI
 Dipartimento delle Dipendenze TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA E DEI DISTURBI CORRELATI AGLI OPPIOIDI Ambiti di Intervento Trattamenti in fase acuta Intossicazione Acuta Sindrome di Astinenza Trattamenti in
Dipartimento delle Dipendenze TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA E DEI DISTURBI CORRELATI AGLI OPPIOIDI Ambiti di Intervento Trattamenti in fase acuta Intossicazione Acuta Sindrome di Astinenza Trattamenti in
SAPONE NEVE MARSIGLIA
 Sapone Neve Marsiglia Aggiornamento del 20-02-2008 SCHEDA TECNICA SAPONE NEVE MARSIGLIA. Aspetto: solido compatto;. Forma : parallelepipedo rettangolare;. Colore : bianco;. Profumo : di composizione profumata
Sapone Neve Marsiglia Aggiornamento del 20-02-2008 SCHEDA TECNICA SAPONE NEVE MARSIGLIA. Aspetto: solido compatto;. Forma : parallelepipedo rettangolare;. Colore : bianco;. Profumo : di composizione profumata
L Ambulatorio Pediatrico OnLine
 AVVELENAMENTI Per avvelenamento s'intende l'assorbimento per ingestione, inalazione o per contatto cutaneo di sostanze nocive per l'organismo umano. La gravità è spesso in funzione della dose assorbita.
AVVELENAMENTI Per avvelenamento s'intende l'assorbimento per ingestione, inalazione o per contatto cutaneo di sostanze nocive per l'organismo umano. La gravità è spesso in funzione della dose assorbita.
CAPITOLO K_2 SECONDO MODULO
 CAPITOLO K_2 SECONDO MODULO 2 OBIETTIVI ALTRE PATOLOGIE MEDICHE DIABETE MALATTIA CRONICA CARATTERIZZATA DA ALTERAZIONI DEL METABOLISMO ED ASSORBIMENTO DEGLI ZUCCHERI DOVUTA AD ALTERATO MECCANISMO ORMONALE
CAPITOLO K_2 SECONDO MODULO 2 OBIETTIVI ALTRE PATOLOGIE MEDICHE DIABETE MALATTIA CRONICA CARATTERIZZATA DA ALTERAZIONI DEL METABOLISMO ED ASSORBIMENTO DEGLI ZUCCHERI DOVUTA AD ALTERATO MECCANISMO ORMONALE
DIPARTIMENTO CHIRURGICO GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. PEG Gastrostomia. Endoscopica Percutanea
 DIPARTIMENTO CHIRURGICO GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEG Gastrostomia Endoscopica Percutanea Che cosa è? La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è una procedura che comporta il posizionamento
DIPARTIMENTO CHIRURGICO GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEG Gastrostomia Endoscopica Percutanea Che cosa è? La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è una procedura che comporta il posizionamento
Alcol e guida. di Giuseppe Balducci
 Alcol e guida di Giuseppe Balducci Alcol Etilico: formula e struttura L ALCOL ETILICO (ETANOLO) È UNA MOLECOLA ASSAI SEMPLICE ESSENDO COMPOSTA DI 2 SOLI ATOMI DI CARBONIO (C), 1 ATOMO DI OSSIGENO (O) E
Alcol e guida di Giuseppe Balducci Alcol Etilico: formula e struttura L ALCOL ETILICO (ETANOLO) È UNA MOLECOLA ASSAI SEMPLICE ESSENDO COMPOSTA DI 2 SOLI ATOMI DI CARBONIO (C), 1 ATOMO DI OSSIGENO (O) E
Convulsione febbrile Edizione 2010
 Convulsione febbrile Edizione 2010 Tra i pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria, in un anno, il 22 % circa risulta afferire per problematiche neurologiche. Tra questi: 1. Traumi cranici: 6.4
Convulsione febbrile Edizione 2010 Tra i pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria, in un anno, il 22 % circa risulta afferire per problematiche neurologiche. Tra questi: 1. Traumi cranici: 6.4
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Ferro metallo 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Ferro metallo 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
PIERREL FARMACEUTICI S.P.A. SCHEDA DI SICUREZZA: ALFA PIERREL
 PIERREL FARMACEUTICI S.P.A. SCHEDA DI SICUREZZA: ALFA PIERREL ISTRUZIONE OPERATIVA SICUREZZA DATA DI EMISSIONE: NOVEMBRE 2001 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 1.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI
PIERREL FARMACEUTICI S.P.A. SCHEDA DI SICUREZZA: ALFA PIERREL ISTRUZIONE OPERATIVA SICUREZZA DATA DI EMISSIONE: NOVEMBRE 2001 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 1.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI
Intossicazione da Monossido di Carbonio Gestione della fase extraospedaliera e casi clinici
 Intossicazione da Monossido di Carbonio Gestione della fase extraospedaliera e casi clinici Auditorium di Rescaldina (MI) --- 23 gennaio 2008 Davide Dell'Acqua --- dellacquadavide@alice.it L intossicazione
Intossicazione da Monossido di Carbonio Gestione della fase extraospedaliera e casi clinici Auditorium di Rescaldina (MI) --- 23 gennaio 2008 Davide Dell'Acqua --- dellacquadavide@alice.it L intossicazione
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Zinco Solfato 7-idrato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Zinco Solfato 7-idrato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA
 SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA (DIRETTIVE CEE 88/379-93/112-D.M. SANITA' 28-1-92) 1. - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' RESPONSABILE DELL' IMMISSIONE IN COMMERCIO : Nome del
SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA (DIRETTIVE CEE 88/379-93/112-D.M. SANITA' 28-1-92) 1. - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' RESPONSABILE DELL' IMMISSIONE IN COMMERCIO : Nome del
TERAPIA CON DUODOPA. Biella, Ottobre D.S.Russo Mariangela Struttura Complessa di Neurologia
 TERAPIA CON DUODOPA Biella, Ottobre 2013 D.S.Russo Mariangela Struttura Complessa di Neurologia Terapia con DUODOPA Fase iniziale: terapia farmacologica convenzionale (L-Dopa in compresse) Fase avanzata:indicazione
TERAPIA CON DUODOPA Biella, Ottobre 2013 D.S.Russo Mariangela Struttura Complessa di Neurologia Terapia con DUODOPA Fase iniziale: terapia farmacologica convenzionale (L-Dopa in compresse) Fase avanzata:indicazione
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Sodio Carbonato anhidro 1.2 Nome della societá
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Sodio Carbonato anhidro 1.2 Nome della societá
I test per la trombofilia: quali no!
 I test per la trombofilia: quali no! Benedetto Morelli Laboratorio e Trombofilia congenita ed acquisita: quali test, a chi, quando, perché? Bari, 9 aprile 2016 ROAD MAP Importanza della appropriatezza
I test per la trombofilia: quali no! Benedetto Morelli Laboratorio e Trombofilia congenita ed acquisita: quali test, a chi, quando, perché? Bari, 9 aprile 2016 ROAD MAP Importanza della appropriatezza
Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una
 1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.
1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.
RUOLO DEL MEDICO DI M.G. NELLA GESTIONE DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI. DOTT Pesola
 RUOLO DEL MEDICO DI M.G. NELLA GESTIONE DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI DOTT Pesola Ambito delle cure primarie Ospedale Specialistica Medicina di Famiglia Pazienti sintomatici esordio MALATTIA e MALATTIA
RUOLO DEL MEDICO DI M.G. NELLA GESTIONE DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI DOTT Pesola Ambito delle cure primarie Ospedale Specialistica Medicina di Famiglia Pazienti sintomatici esordio MALATTIA e MALATTIA
SCHEDA DI SICUREZZA ART COLLECTION
 SCHEDA DI SICUREZZA ART COLLECTION 1 REAL BLOND SHAMPOO (Cod. A208) 1. Identificazione del prodotto e del produttore e responsabile dell'immissione sul mercato Dati relativi al prodotto Nome commerciale
SCHEDA DI SICUREZZA ART COLLECTION 1 REAL BLOND SHAMPOO (Cod. A208) 1. Identificazione del prodotto e del produttore e responsabile dell'immissione sul mercato Dati relativi al prodotto Nome commerciale
Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento.
 1 2 Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento. 3 Per quanto la classe dei FANS sia molto ampia e articolata, come si evince da questa tabella, il loro
1 2 Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento. 3 Per quanto la classe dei FANS sia molto ampia e articolata, come si evince da questa tabella, il loro
Osservazione Breve Intensiva
 Osservazione Breve Intensiva E. Piccotti - S. Costabel DEA Pediatrico I.R.C.C.S. G. Gaslini Genova Documenti/Leggi di riferimento Consiglio Superiore Sanità Febbraio 1992 Servizio di osservazione e trattamenti
Osservazione Breve Intensiva E. Piccotti - S. Costabel DEA Pediatrico I.R.C.C.S. G. Gaslini Genova Documenti/Leggi di riferimento Consiglio Superiore Sanità Febbraio 1992 Servizio di osservazione e trattamenti
regole d oro per la prevenzione della calcolosi renale
 10 regole d oro per la prevenzione della calcolosi renale La calcolosi renale è una patologia frequente, ricorrente e potenzialmente pericolosa se non adeguatamente inquadrata, prevenuta e trattata. Se
10 regole d oro per la prevenzione della calcolosi renale La calcolosi renale è una patologia frequente, ricorrente e potenzialmente pericolosa se non adeguatamente inquadrata, prevenuta e trattata. Se
ANALISI DELLE SCORTE ANTIDOTI NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
 Dipartimento Farmaceutico Interaziendale ANALISI DELLE SCORTE ANTIDOTI NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Dotazione, Disponibilità e uso degli antidoti nella Regione Emilia Romagna Bologna,
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale ANALISI DELLE SCORTE ANTIDOTI NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Dotazione, Disponibilità e uso degli antidoti nella Regione Emilia Romagna Bologna,
Data: Feb. 97/Rev ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA. Specifica del prodotto: Principio attivo. Nome depositato Collagene (ANTEMA )
 Data: Feb. 97/Rev. 001 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA Specifica del prodotto: Principio attivo Nome depositato Collagene (ANTEMA ) Produttore/Fornitore OPOCRIN S.p.A. Via Pacinotti, 3 41040
Data: Feb. 97/Rev. 001 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA Specifica del prodotto: Principio attivo Nome depositato Collagene (ANTEMA ) Produttore/Fornitore OPOCRIN S.p.A. Via Pacinotti, 3 41040
IldocumentoGOLD completo(w ORKSHOPREPORTS)èconsultabilesulsitowww.goldcopd.it
 GUIDA RAPIDA PER LA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA BPCO Basatasuprogettoglobaleperladiagnosi,gestionee prevenzionebpco (Aggiornamento2007) IldocumentoGOLD completo(w ORKSHOPREPORTS)èconsultabilesulsitowww.goldcopd.it
GUIDA RAPIDA PER LA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA BPCO Basatasuprogettoglobaleperladiagnosi,gestionee prevenzionebpco (Aggiornamento2007) IldocumentoGOLD completo(w ORKSHOPREPORTS)èconsultabilesulsitowww.goldcopd.it
SCHEDA DI SICUREZZA ZANZA BREAK CANDELA INSETTICIDA PROFUMATA ALLA CITRONELLA. Data: Maggio 2009
 1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA 1.1 Identificazione del preparato : ZANZA BREAK CANDELA INSETTICIDA Candela zanzaricida per uso domestico al profumo di citronella PMC Reg. N 19469 del
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA 1.1 Identificazione del preparato : ZANZA BREAK CANDELA INSETTICIDA Candela zanzaricida per uso domestico al profumo di citronella PMC Reg. N 19469 del
CENTRO ANTIVELENI I SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE LA GESTIONE DELL INTOSSICAZIONE ACUTA IN PRONTO SOCCORSO
 DIPARTIMENTO DI EMERGENZA AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA GRANDA CENTRO ANTIVELENI I SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE Direttore Prof. Emma Pannacciulli LA GESTIONE DELL INTOSSICAZIONE ACUTA IN PRONTO
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA GRANDA CENTRO ANTIVELENI I SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE Direttore Prof. Emma Pannacciulli LA GESTIONE DELL INTOSSICAZIONE ACUTA IN PRONTO
Uso dei farmaci e allattamento al seno
 Uso dei farmaci e allattamento al seno Serve un attitudine positiva da parte degli operatori sanitari R&P 2015; 31: 171-187 La Società Italiana di Medicina Perinatale ha elaborato un consensus statement
Uso dei farmaci e allattamento al seno Serve un attitudine positiva da parte degli operatori sanitari R&P 2015; 31: 171-187 La Società Italiana di Medicina Perinatale ha elaborato un consensus statement
IL POSIZIONAMENTO DEL SNG. Assistenza
 IL POSIZIONAMENTO DEL SNG Applicazione Gestione Assistenza Indicazioni Il posizionamento del SNG può essere utilizzato per molteplici scopi: Svuotare lo stomaco da sostanze tossiche ingerite Drenare, monitorare
IL POSIZIONAMENTO DEL SNG Applicazione Gestione Assistenza Indicazioni Il posizionamento del SNG può essere utilizzato per molteplici scopi: Svuotare lo stomaco da sostanze tossiche ingerite Drenare, monitorare
Corso per volontari del soccorso
 Corso per volontari del soccorso Presta 27 Ottobre2009 Programma Introduzione al corso: introduzione al Soccorso Anatomia e Fisiologia Check list il mezzo - la guida Valutazione dell infortunato Principali
Corso per volontari del soccorso Presta 27 Ottobre2009 Programma Introduzione al corso: introduzione al Soccorso Anatomia e Fisiologia Check list il mezzo - la guida Valutazione dell infortunato Principali
PLACEBO Aspetti etici e scientifici
 Aspetti etici e scientifici Definizione Placebo (dal latino, letteralmente piacerò) può essere definito ogni trattamento, o parte di esso, che viene deliberatamente impiegato per determinare un effetto
Aspetti etici e scientifici Definizione Placebo (dal latino, letteralmente piacerò) può essere definito ogni trattamento, o parte di esso, che viene deliberatamente impiegato per determinare un effetto
MODELLO INFORMATIVO. Informazioni relative all esame diagnostico HEAD-UP TILT TEST
 MODELLO INFORMATIVO Informazioni relative all esame diagnostico HEAD-UP TILT TEST Io sottoscritto/a nato/a. il. dichiaro di essere stato/a informato/a in data dal dr.. DI ESSERE AFFETTO DALLA SEGUENTE
MODELLO INFORMATIVO Informazioni relative all esame diagnostico HEAD-UP TILT TEST Io sottoscritto/a nato/a. il. dichiaro di essere stato/a informato/a in data dal dr.. DI ESSERE AFFETTO DALLA SEGUENTE
Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali. Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche
 A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it
A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it
Zinco Ossido PRS 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Zinco Ossido 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Zinco Ossido 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
S.V.T. Supporto vitale di base nel paziente traumatizzato
 S.V.T. Supporto vitale di base nel paziente traumatizzato OBIETTIVO DEL CORSO Acquisire conoscenze teoriche e abilità pratiche per trattare l evento traumatico secondo linee Guida della Regione Toscana
S.V.T. Supporto vitale di base nel paziente traumatizzato OBIETTIVO DEL CORSO Acquisire conoscenze teoriche e abilità pratiche per trattare l evento traumatico secondo linee Guida della Regione Toscana
Le misure di controllo in ambiente ospedaliero
 La pandemia influenzale H1N1 2009 Parma, 12 settembre 2009 Le misure di controllo in ambiente ospedaliero G.L. Giovanardi Azienda USL di Parma La pandemia influenzale H1N1 2009 Parma, 12 settembre 2009
La pandemia influenzale H1N1 2009 Parma, 12 settembre 2009 Le misure di controllo in ambiente ospedaliero G.L. Giovanardi Azienda USL di Parma La pandemia influenzale H1N1 2009 Parma, 12 settembre 2009
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Potassio Carbonato-Sodio Carbonato anidro 1.2 Nome della societá o
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Potassio Carbonato-Sodio Carbonato anidro 1.2 Nome della societá o
PANCREATITE ACUTA DA FARMACI
 SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, CORSO 2010/2013. PATOLOGIA DEL PANCREAS PANCREATITE ACUTA DA FARMACI Elisabetta Ascari Fabio Bassi Medicina III Gastroenterologia Azienda
SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, CORSO 2010/2013. PATOLOGIA DEL PANCREAS PANCREATITE ACUTA DA FARMACI Elisabetta Ascari Fabio Bassi Medicina III Gastroenterologia Azienda
1. Elementi d identificazione della sostanza o del preparato e della società /impresa produttrice
 Pagina 1 di 9 SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA Yotuel Dental Office 10 Minute kit (carbamide perossido 30%) with accelerator Secondo 93/42/CEE 1. Elementi d identificazione della sostanza o del preparato e
Pagina 1 di 9 SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA Yotuel Dental Office 10 Minute kit (carbamide perossido 30%) with accelerator Secondo 93/42/CEE 1. Elementi d identificazione della sostanza o del preparato e
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Acido 3,5-Dinitrosalicilico 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Acido 3,5-Dinitrosalicilico 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC
FARMACOCINETICA 1. Farmacologia generale FARMACOCINETICA FARMACOLOGIA FARMACODINAMICA
 FARMACOCINETICA 1 Farmacologia generale FARMACOCINETICA FARMACOLOGIA FARMACODINAMICA 1 ASSORBIMENTO DEI FARMACI cioè il processo per mezzo del quale un farmaco passa dal sito di somministrazione al plasma
FARMACOCINETICA 1 Farmacologia generale FARMACOCINETICA FARMACOLOGIA FARMACODINAMICA 1 ASSORBIMENTO DEI FARMACI cioè il processo per mezzo del quale un farmaco passa dal sito di somministrazione al plasma
DIFFERENZE DI GENERE NELL ITER DIAGNOSTICO E SINDROMI CORONARICHE ACUTE IL PUNTO DI VISTA DEL DEU
 DIFFERENZE DI GENERE NELL ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO DELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE IL PUNTO DI VISTA DEL DEU Infermiera Maria Chiara Sabatini 118 CU Pistoia-Empoli DAL SINTOMO ALL EMODINAMICA IL
DIFFERENZE DI GENERE NELL ITER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO DELLE SINDROMI CORONARICHE ACUTE IL PUNTO DI VISTA DEL DEU Infermiera Maria Chiara Sabatini 118 CU Pistoia-Empoli DAL SINTOMO ALL EMODINAMICA IL
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Litio Carbonato 1.2 Nome della societá o ditta:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Litio Carbonato 1.2 Nome della societá o ditta:
COLLANTE RASANTE PER CAPPOTTO CR60
 COLLANTE RASANTE PER CAPPOTTO CR60 NUOVA SIGA COLLANTI E RASANTI IN POLVERE A BASE CEMENTO PER INTERNI E PER ESTERNI A BASSO SPESSORE ED ELEVATA LAVORABILITA 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA
COLLANTE RASANTE PER CAPPOTTO CR60 NUOVA SIGA COLLANTI E RASANTI IN POLVERE A BASE CEMENTO PER INTERNI E PER ESTERNI A BASSO SPESSORE ED ELEVATA LAVORABILITA 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Magnesio metal, limaduras 1.2 Nome della societá
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Magnesio metal, limaduras 1.2 Nome della societá
Intossicazioni ed avvelenamenti
 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI ROMA Intossicazioni ed avvelenamenti CROCE ROSSA ITALIANA - a cura del Capo Monitore V.d.S. Iannozzi Emanuela INTOSSICAZIONI Si realizza quando il livello di
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI ROMA Intossicazioni ed avvelenamenti CROCE ROSSA ITALIANA - a cura del Capo Monitore V.d.S. Iannozzi Emanuela INTOSSICAZIONI Si realizza quando il livello di
Convulsioni febbrili. Quale terapia preventiva? Quando approfondire?
 Convulsioni febbrili. Quale terapia preventiva? Quando approfondire? Dr Fabio M. Corsi UOC Neurologia e Neurofisiopatologia A.O. San Camillo Forlanini DEFINIZIONI Convulsione febbrile semplice (CFS) Una
Convulsioni febbrili. Quale terapia preventiva? Quando approfondire? Dr Fabio M. Corsi UOC Neurologia e Neurofisiopatologia A.O. San Camillo Forlanini DEFINIZIONI Convulsione febbrile semplice (CFS) Una
IL BLS E LA VALUTAZIONE PRIMARIA
 IL BLS E LA VALUTAZIONE PRIMARIA ROVATO SOCCORSO - corso di primo soccorso 2010/2011 lunedì 08 novembre 2010 Dott. BONETTI STEFANO OBIETTIVI DELLA LEZIONE comprendere l importanza della valutazione del
IL BLS E LA VALUTAZIONE PRIMARIA ROVATO SOCCORSO - corso di primo soccorso 2010/2011 lunedì 08 novembre 2010 Dott. BONETTI STEFANO OBIETTIVI DELLA LEZIONE comprendere l importanza della valutazione del
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE. 2. Composizione/Informazione dei componenti
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Alluminio soluzione modello Al=1,000±0,002 g/l 1.2 Nome della societá
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Alluminio soluzione modello Al=1,000±0,002 g/l 1.2 Nome della societá
FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA.
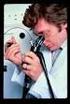 FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA. Gentile Paziente, La gastroscopia è un esame endoscopico che permette la visualizzazione della mucosa dell esofago, dello
FOGLIO INFORMATIVO E CONSENSO INFORMATO PER GASTROSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA. Gentile Paziente, La gastroscopia è un esame endoscopico che permette la visualizzazione della mucosa dell esofago, dello
Modulo 4. Manifestazioni cliniche e possibili complicanze dell'asma allergico
 Modulo 4 Manifestazioni cliniche e possibili complicanze dell'asma allergico Classificazione di gravità prima dell inizio del trattamento STEP 4 Grave persistente STEP 3 Moderato persistente STEP 2 Lieve
Modulo 4 Manifestazioni cliniche e possibili complicanze dell'asma allergico Classificazione di gravità prima dell inizio del trattamento STEP 4 Grave persistente STEP 3 Moderato persistente STEP 2 Lieve
TERAPIA AMBULATORIALE DEL BAMBIN0 CON FEBBRE E DOLORE SIMERI 11 GIUGNO 2003
 TERAPIA AMBULATORIALE DEL BAMBIN0 CON FEBBRE E DOLORE SIMERI 11 GIUGNO 2003 Dott. Luigi Nigri - Bisceglie (BA) La terapia ambulatoriale del bambino con febbre e dolore non è solo strettamente farmacologica
TERAPIA AMBULATORIALE DEL BAMBIN0 CON FEBBRE E DOLORE SIMERI 11 GIUGNO 2003 Dott. Luigi Nigri - Bisceglie (BA) La terapia ambulatoriale del bambino con febbre e dolore non è solo strettamente farmacologica
Redatto in conformità all allegato 2 del regolamento REACH n 1907/2006 e del regolamento CLP n 1272/2008 HELMET FRESH
 Data ultima revision: 27/08/2013 Versione: 2 HELMET FRESH 1) SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA 1.1 Identificazione del prodotto: HELMET FRESH (Disinfettante per casco da sci), art.
Data ultima revision: 27/08/2013 Versione: 2 HELMET FRESH 1) SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA 1.1 Identificazione del prodotto: HELMET FRESH (Disinfettante per casco da sci), art.
Industrie Chimiche Barbini S.p.A. Capitale L i.v.
 TUNGSTENO METALLO POLVERE M-0717 Pag. 1/5 1. ELEMENTI IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA. 1.1. Elementi identificatori della sostanza o del preparato Forma commerciale
TUNGSTENO METALLO POLVERE M-0717 Pag. 1/5 1. ELEMENTI IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA. 1.1. Elementi identificatori della sostanza o del preparato Forma commerciale
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Compuestos de Antimonio 1.2 Nome della societá
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: Compuestos de Antimonio 1.2 Nome della societá
DEFINIRE LO SCOPO DELLA VALUTAZIONE PRIMARIA ACQUISIRE LO SCHEMA DI COMPORTAMENTO PER LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO
 CAPITOLO 4_c OBIETTIVI DEFINIRE LO SCOPO DELLA VALUTAZIONE PRIMARIA ACQUISIRE LO SCHEMA DI COMPORTAMENTO PER LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO 2 VALUTAZIONE PRIMARIA SCOPO Identificare
CAPITOLO 4_c OBIETTIVI DEFINIRE LO SCOPO DELLA VALUTAZIONE PRIMARIA ACQUISIRE LO SCHEMA DI COMPORTAMENTO PER LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO 2 VALUTAZIONE PRIMARIA SCOPO Identificare
UN VIAGGIO DI AGGIORNAMENTO...in Calabria
 S.I.P. SOCIETA ITALIANA DI PEDIATRIA S.I.M.E.U.P. SOCIETA ITALIANA EMERGENZA ED URGENZA PEDIATRICA F.I.M.P. FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI PATROCINIO RICHIESTO UN VIAGGIO DI AGGIORNAMENTO......in
S.I.P. SOCIETA ITALIANA DI PEDIATRIA S.I.M.E.U.P. SOCIETA ITALIANA EMERGENZA ED URGENZA PEDIATRICA F.I.M.P. FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI PATROCINIO RICHIESTO UN VIAGGIO DI AGGIORNAMENTO......in
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Sodio Ipobromito soluzione B (sol. de sodio ipoclorito alcalino) 1.2
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Sodio Ipobromito soluzione B (sol. de sodio ipoclorito alcalino) 1.2
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA. 1.4.Numero telefonico di emergenza Ospedale Niguarda di Milano-Centro antiveleni numero di emergenza
 1.Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1.Identificatore del prodotto DEI Sinergy spray 1.2.Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela Disinfettante per dispositivi
1.Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1.Identificatore del prodotto DEI Sinergy spray 1.2.Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela Disinfettante per dispositivi
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Gel di Silice 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Gel di Silice 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
Datura stramonium. Disturbi neuropsichiatrici a impronta anticolinergica
 Datura stramonium Disturbi neuropsichiatrici a impronta anticolinergica Cantani, 1887 il principio attivo dello stramonio è la daturina, la quale presenta una composizione elementare identica a quella
Datura stramonium Disturbi neuropsichiatrici a impronta anticolinergica Cantani, 1887 il principio attivo dello stramonio è la daturina, la quale presenta una composizione elementare identica a quella
Scheda di Sicurezza BRADOPHEN 100 M. 1. Identificazione della Sostanza / Preparazione e del Produttore / Distributore
 1. Identificazione della Sostanza / Preparazione e del Produttore / Distributore Identificazione della sostanza o preparazione Nome del Prodotto Bradophen 100 M N Riferimento 1218920 Settore di impiego
1. Identificazione della Sostanza / Preparazione e del Produttore / Distributore Identificazione della sostanza o preparazione Nome del Prodotto Bradophen 100 M N Riferimento 1218920 Settore di impiego
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DELLA SALA RISVEGLIO Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo
 Dott. NICOLA TORINA Coordinatore Infermieristico - UTIR Ospedale Buccheri La Ferla FBF Palermo REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DELLA SALA RISVEGLIO Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo 1 Secondo
Dott. NICOLA TORINA Coordinatore Infermieristico - UTIR Ospedale Buccheri La Ferla FBF Palermo REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DELLA SALA RISVEGLIO Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo 1 Secondo
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Alluminio Potassio Solfato 12-idrato 1.2 Nome della societá o ditta:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Alluminio Potassio Solfato 12-idrato 1.2 Nome della societá o ditta:
PERCORSO ECM NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI TOSSICOLOGIA CONGRESSO
 PERCORSO ECM ACCREDITAMENTO ECM I corsi Educazionali fanno parte del percorso formativo accreditato 18 19 INFORMAZIONI ecm CONGRESSO La Società SITOX (Provider ECM Standard n. 621) ha effettuato la richiesta
PERCORSO ECM ACCREDITAMENTO ECM I corsi Educazionali fanno parte del percorso formativo accreditato 18 19 INFORMAZIONI ecm CONGRESSO La Società SITOX (Provider ECM Standard n. 621) ha effettuato la richiesta
Fattori predittivi del comportamento violento
 Fattori predittivi del comportamento violento Sesso maschile Età giovanile Storia di abusi nell infanzia Abuso di alcool e sostanze Primo episodio psicotico Non compliance per l assunzione della terapia
Fattori predittivi del comportamento violento Sesso maschile Età giovanile Storia di abusi nell infanzia Abuso di alcool e sostanze Primo episodio psicotico Non compliance per l assunzione della terapia
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Carbone Vegetale pezzi 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Carbone Vegetale pezzi 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
Corso di Laurea in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE
 Corso di Laurea in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA Disciplina: SCIENZE INFERMIERISTICHE Docente: Prof.ssa Valeria GHIRINGHELLI Acquisire conoscenze riguardo le modalità di lavaggio delle
Corso di Laurea in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA Disciplina: SCIENZE INFERMIERISTICHE Docente: Prof.ssa Valeria GHIRINGHELLI Acquisire conoscenze riguardo le modalità di lavaggio delle
Intossicazione da piridostigmina e venlafaxina
 La Rete Regionale per la Gestione degli Antidoti Intossicazione da piridostigmina e venlafaxina Dott. Lorenzo Mantovani U.O. di Medicina d Emergenza-Urgenza AUSL Ravenna Direttore Dott. ssa M. Pazzaglia
La Rete Regionale per la Gestione degli Antidoti Intossicazione da piridostigmina e venlafaxina Dott. Lorenzo Mantovani U.O. di Medicina d Emergenza-Urgenza AUSL Ravenna Direttore Dott. ssa M. Pazzaglia
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI. A cura di: Danilo Monarca
 CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI A cura di: Danilo Monarca DEFINIZIONI
CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI A cura di: Danilo Monarca DEFINIZIONI
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Stagno II Cloruro 2-idrato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Stagno II Cloruro 2-idrato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Ammonio Solfato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Ammonio Solfato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA, S.A.
SCHEDA DI SICUREZZA ART COLLECTION
 SCHEDA DI SICUREZZA ART COLLECTION 1 LUMINACOLOR TINTA (Cod. A600) 1. Identificazione del prodotto e del produttore e responsabile dell'immissione sul mercato Dati relativi al prodotto Nome commerciale
SCHEDA DI SICUREZZA ART COLLECTION 1 LUMINACOLOR TINTA (Cod. A600) 1. Identificazione del prodotto e del produttore e responsabile dell'immissione sul mercato Dati relativi al prodotto Nome commerciale
SCHEDA DI SICUREZZA CLP-Y660A, CLP-Y660B
 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA pag. 1/2 Data emissione 16 agosto 2007 SCHEDA DI SICUREZZA [1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO E DELLA SOCIETÀ] NOME DEL PRODOTTO: SOCIETÀ: CLP-Y660A, CLP-Y660B Samsung
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA pag. 1/2 Data emissione 16 agosto 2007 SCHEDA DI SICUREZZA [1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO E DELLA SOCIETÀ] NOME DEL PRODOTTO: SOCIETÀ: CLP-Y660A, CLP-Y660B Samsung
Potassio Carbonato PRS 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Potassio Carbonato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione: Potassio Carbonato 1.2 Nome della societá o ditta: PANREAC QUIMICA,
DIRETTIVO SIMEU PUGLIA. Documento di indirizzo per l Osservazione Breve
 DIRETTIVO SIMEU PUGLIA Documento di indirizzo per l Osservazione Breve 1 L Osservazione Breve L O.B. è la gestione clinica protratta da parte del Pronto Soccorso di pazienti ai fini di un corretto inquadramento
DIRETTIVO SIMEU PUGLIA Documento di indirizzo per l Osservazione Breve 1 L Osservazione Breve L O.B. è la gestione clinica protratta da parte del Pronto Soccorso di pazienti ai fini di un corretto inquadramento
SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE SINISTRI, MODALITA DEI CONTROLLI PER STUPEFACENTI (art. 187 c.d.s.) RELATORE:
 SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE SINISTRI, MODALITA DEI CONTROLLI PER STUPEFACENTI (art. 187 c.d.s.) RELATORE: Dirigente Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Bergamo Medico Capo della Polizia
SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE SINISTRI, MODALITA DEI CONTROLLI PER STUPEFACENTI (art. 187 c.d.s.) RELATORE: Dirigente Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Bergamo Medico Capo della Polizia
Scheda dei Dati di Sicurezza Secondo le Direttive 91/155/CEE
 1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: 1,2,3-Bencenotriol 1.2 Nome della societá o ditta:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della societá o ditta 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Denominazione secondo l allegato I: 1,2,3-Bencenotriol 1.2 Nome della societá o ditta:
SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI EVENTI AVVERSI DOPO VACCINAZIONE ANTI-HPV SCHEDA CLINICA INDIVIDUALE
 ALLEGATO 1 SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI EVENTI AVVERSI DOPO VACCINAZIONE ANTI-HPV SCHEDA CLINICA INDIVIDUALE Cognome Nome Regione Comune ASL Codice fiscale Data di Nascita DATI ANAGRAFICI ED INFORMAZIONI
ALLEGATO 1 SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI EVENTI AVVERSI DOPO VACCINAZIONE ANTI-HPV SCHEDA CLINICA INDIVIDUALE Cognome Nome Regione Comune ASL Codice fiscale Data di Nascita DATI ANAGRAFICI ED INFORMAZIONI
