OSVALDO MURDOCCA. TEMA Sintesi del libro I CONCILI DELLA CHIESA di Norman P.Tanner
|
|
|
- Giorgia Marrone
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA ISTITUTO DI SPIRITUALITA OSVALDO MURDOCCA TEMA Sintesi del libro I CONCILI DELLA CHIESA di Norman P.Tanner Moderatore: Prof. Norman P. Tanner Roma, 2009
2 Il tema indicato verrà sviluppato trattando, nell ordine, i seguenti argomenti: 1. I concili ecumenici della Chiesa antica. 2. I concili medioevali: dal Laterano I al Laterano V. 3. I concili dell era moderna. 1. I concili ecumenici della Chiesa antica. 1 ELENCO DEI CONCILI ECUMENICI Sono indicati di seguito i sette concili ecumenici, considerati tali da entrambe le Chiese, occidentale e orientale; tali concili ebbero luogo prima dello scisma delle due Chiese, avvenuto nell XI secolo: 1. Nicea I, nel 325; 2. Costantinopoli I, nel 381; 3. Concilio di Efeso, nel 431; 4. Concilio di Calcedonia, nel 451; 5. Costantinopoli II, nel 553; 6. Costantinopoli III, nel ; 7. Niceno II, nel 787. L evento che rese possibile un concilio ecumenico fu la pace portata alla Chiesa dalla conversione alla cristianità dell imperatore Costantino. Lo stabilirsi della cristianità come religione favorita dall Impero Romano significò che i vescovi poterono radunarsi anche se provenienti da molto lontano. Fu lo stesso Costantino che radunò il concilio di Nicea. Il momento decisivo nello stabilire l elenco dei concili ecumenici avvenne nel concilio di Calcedonia nel 451, che si definiva sacro e grande concilio ecumenico, dove sacro e grande era la definizione del concilio di Nicea I, a cui si aggiungeva il termine ecumenico che comincio a distinguere quei concili che rappresentavano l intera Chiesa da altri di minore autorità. PARTECIPANTI E PROCEDURE Nicea I (325) I partecipanti furono 318, ma probabilmente è un numero simbolico; in realtà furono tra i 250 e 300 partecipanti, provenienti in massima parte dalla Chiesa orientale di lingua greca e in minima parte dall Occidente e dall Africa. Costantinopoli I (381) I partecipanti furono 150 e, probabilmente, tutti appartenenti alle Chiese orientali. 1 Cfr. NORMAN P.TANNER, I concili della Chiesa, Editoriale Jaca Book SpA, Milano 1999, p.19. 1
3 Efeso (431) I partecipanti vennero dalle Chiese d Oriente e d Africa. Gli occidentali erano rappresentati da due legati papali. Calcedonia (451) In questo concilio vennero 500/600 partecipanti, tutti orientali, tranne due legati papali e due vescovi dell Africa. Costantinopoli II (553), Costantinopoli III ( ), Nicea II (787) A tali concili parteciparono in maggioranza orientali. Quindi il contributo maggiore, in fatto di partecipanti, venne dagli orientali: prevedibile, perché i sette concili vennero celebrati nella regione dell Impero d Oriente. Il secondo contributo più importante venne dalla Chiesa africana, con centro in Alessandria. Il contributo della Chiesa occidentale fu minimo, almeno fino al concilio di Calcedonia. Per quanto riguarda la lingua, quella della Chiesa orientale e del Nord Africa era greca, e tale era la lingua dei decreti. Il latino era la lingua dell Occidente e della parte occidentale del Nord Africa. Il nucleo dei membri dei concili ecumenici è sempre costituito da vescovi e altre persone, in minima parte: per esempio, Ario che partecipò a Nicea I, era prete. Anche gli imperatori orientali presero parte ai concili e alcune donne: - l imperatrice Pulcheria, fu l organizzatrice principale del concilio di Calcedonia; - l imperatrice Irene, fu l organizzatrice principale del concilio di Nicea II. Tra i membri del concilio, alcuni avevano diritto di voto e altri no. C era il principio dell unanimità o della quasi-unanimità: cioè, perché un decreto fosse approvato, il consenso doveva essere unanime e normalmente avveniva per acclamazione. In questo modo venne mantenuta unita la Chiesa durante il suo primo millennio. Il principio è stato mantenuto fino ad oggi. Gli imperatori orientali presiedevano i concili e successivamente promulgarono i decreti di tutti i primi sette concili ecumenici. In accordo con l attuale legge canonica della Chiesa cattolica romana, solo il Papa, vescovo di Roma, ha il diritto di convocare, presiedere ed approvare i decreti di un concilio ecumenico (Codice di Diritto Canonico, 1983). DECRETI DOTTRINALI: dal NICEA I al CALCEDONIA I tre decreti più importanti dei primi quattro concili ecumenici sono: - il Credo di Nicea I; - il Credo di Costantinopoli I (che è uno sviluppo del Credo di Nicea I); - la definizione del concilio di Calcedonia. Il Credo di Costantinopoli I rimane a tutt oggi il Credo fondamentale della maggioranza delle Chiese cristiane. Il Credo di Nicea I emerge dalla controversia ariana relativa alla divinità del Figlio di Dio: Ario attribuiva una divinità indebolita al Figlio di Dio. La base del Credo sembra essere la confessione di fede usata nel rito del battesimo da una particolare Chiesa locale Gerusalemme o qualche luogo della 2
4 Siria o della Palestina cui vennero aggiunte varie parole anti-ariane e clausole, inclusa la parola greca omousios, tradotta consostanziale o dello stesso essere, per descrivere la relazione del Figlio con il Padre. Il Credo di Nicea I dimostrò il suo valore per più di un secolo. Il concilio di Efeso nel 431 ne proibì ogni mutamento. Il concilio di Calcedonia nel 451, tuttavia, non voleva procedere oltre il Credo di Nicea I. D altra parte il Credo di Nicea I non sembrava adeguato alla situazione. A questo punto l arcidiacono di Costantinopoli suggerì il Credo proclamato dal concilio di Costantinopoli celebrato nel 381. Il concilio di Calcedonia procedette adottando il Credo del 381 che venne considerato come un miglioramento di quello del 325. Il testo non presenta gli anatemi anti-ariani. Il Credo del 381 è chiamato il Credo niceno-costantinopolitano, mentre il Credo del 325 è chiamato il Credo di Nicea. Ma nel Credo del 381 è stata inserita un eccezione: l aggiunta della clausola del Filioque. Cioè, alle parole e nello Spirito Santo che procede dal Padre, la Chiesa occidentale successivamente aggiunse e dal Figlio (in latino Filioque), così che lo Spirito procede dal Figlio come pure dal Padre. A questa aggiunta si oppose con vigore la Chiesa orientale poiché infrangeva la proibizione del concilio di Efeso, contro i cambiamenti del Credo. Fu questa la ragione principale dello scisma fra le due Chiese nel sec.xi ed è rimasto l ostacolo maggiore alla riconciliazione fino ad oggi. Per quanto riguarda la definizione del concilio di Calcedonia, contenuta nel terzo decreto, questa inizia così: Il santo e grande concilio ecumenico, riunito per grazia di Dio e per volontà dei nostri piissimi e cristianissimi imperatori Valentiano e Marciano. La definizione evidenzia il ruolo degli imperatori, anche se l imperatrice Pulcheria, l organizzatrice principale del concilio, avrebbe potuto essere inserita proprio accanto al marito Marciano. Il decreto procede nei toni di difesa dell ortodossia respingendo le false dottrine, e aggiungendo al Credo del concilio di Nicea I quello di Costantinopoli I, aggirando in questo modo la proibizione di Efeso contro i mutamenti di Nicea. Lo stesso decreto contiene l approvazione del concilio di Efeso del 431, che si era occupato del titolo di madre di Dio di Maria. L approvazione significò non solo il riconoscimento del concilio di Efeso del 431 ma anche il rifiuto del secondo concilio di Efeso avvenuto nel 449, che tentò di rovesciare le decisioni del primo concilio di Efeso, e che fu definito Latrocinium dal papa Leone I. Il decreto, infine, affronta il tema specifico per il quale è stato convocato il concilio: l insegnamento di Eutiche sulla relazione fra la divinità e l umanità in Gesù Cristo. Eutiche, un monaco di Costantinopoli, sostenne che, dopo l incarnazione, la singola persona del Dio-uomo, Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio di Maria, corrispondeva a una sola natura (quindi monofisita) che includeva sia quella divina che quella umana. Il concilio rifiutava il monofisismo di Eutiche proponendo la sua propria soluzione di una persona in due nature. 3
5 DECRETI DOTTRINALI: COSTANTINOPOLI II e NICEA II I concili Costantinopoli II nel 553 e Costantinopoli III nel possono essere considerati come complemento del lavoro dei primi quattro concili, specialmente Calcedonia; il concilio Nicea II nel 787 si rivolse al problema dell iconoclastia. Il concilio Costantinopoli II emise un solo decreto che condannava vari scritti di tre seguaci di Nestorio che, ricordiamo, affermava due nature e due persone distinte in Cristo. Il concilio Costantinopoli III affermava una dualità di volontà e di principi d azione in Cristo, uno per la sua natura divina e un altro per quella umana. Infatti, il relativo decreto afferma: ciascuna natura agisce in comunione con l altra secondo ciò che le è proprio. Uno dei condannati dal concilio per aver conservato credenze monotelite ( una volontà ) fu papa Onorio, vescovo di Roma dal 625 al 638, che aveva proposto idee non ortodosse in due lettere dirette a Sergio, patriarca di Costantinopoli. La sua condanna venne confermata nel successivo concilio ecumenico Nicea II. Differente fu l argomento principale di Nicea II, concilio tenuto nel 787: le immagini. Ci fu un forte dibattito, fin dall inizio del secolo VIII, soprattutto nel mondo bizantino. Dalla parte degli iconoclasti (coloro che si opponevano alle immagini) c era la proibizione dell Antico Testamento di fabbricare immagini. Ma d altra parte, esisteva una tradizione fin dalla Chiesa antica di rappresentare Cristo e i santi in varie forme di immagini. Il concilio appoggiò l uso delle immagini, indicando anche il tipo di reverenza da attribuire loro, distinguendo fra culto, che si sarebbe dovuto attribuire solo al divino e in nessun modo alle immagini, e venerazione o reverenza, da attribuirsi ad un immagine in quanto rappresentava una o più persone. E da ricordare l imperatrice Irene, reggente per il figlio bambino, che convocò il concilio, ne ottenne l appoggio papale e condusse il concilio a una conclusione di successo. I CANONI PER L ORDINAMENTO DELLA CHIESA Tali canoni sono detti talvolta decreti disciplinari. Emanarono una serie di questo tipo i seguenti concili: Nicea I, Costantinopoli I, Calcedonia e Nicea II. Nel concilio Nicea I ci furono 20 canoni. Il primo canone riguarda quelli che si mutilano o permettono ad altri di farlo su di loro. Il canone richiede rispetto per la creazione di Dio, includendovi i nostri corpi. Il caso più famoso di automutilazione fu quello di Origene, celebre teologo di Alessandria, avvenuto un secolo prima. Il secondo canone ammonisce contro la promozione ad essere preti o vescovi subito dopo il battesimo: Non sia un neofita, perché non gli accada di montare di superbia e di cadere nella stessa condanna del diavolo. Un esempio si ebbe nel con la proclamazione di Ambrogio a vescovo di Milano, mentre era 4
6 catecumeno e fu ordinato immediatamente dopo il battesimo, in evidente conflitto con il canone. Il canone 3 riguarda le donne che vivono con il clero: Questo grande sinodo proibisce assolutamente ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi e in genere a qualsiasi membro del clero di avere con sé una donna, a meno che non si tratti della propria madre, di una sorella o zia, o di persona che sia al di sopra di ogni sospetto. Un caso noto riguardò Paolo di Samosata, vescovo di Antiochia nel III secolo, condannato per aver tenuto come discepole delle giovani vergini nella sua casa. I canoni 4, 5, 6, 7 riguardano l episcopato. Il canone 4 ribadisce che, prima che il vescovo sia ordinato, tutti i vescovi già esistenti della provincia debbono dare il loro consenso scritto e preferibilmente tutti, o almeno tre di loro, debbono essere presenti all ordinazione. Il canone 5 riguarda le scomuniche comminate dai vescovi e i loro concili locali celebrati due volte all anno in ciascuna provincia. I canoni 6 e 7 concernono una gerarchia tripartita all interno dell episcopato: vescovi, metropoliti e al vertice le grandi sedi di Roma, Alessandria e Antiochia, con l aggiunta dei patriarcati di Costantinopoli e Gerusalemme. La maggioranza dei successivi sette canoni, dall 8 al 14, concernono le persone che durante la persecuzione hanno rinnegato la fede. Questi canoni rivelano maggiore severità verso il clero che aveva rinnegato la fede, piuttosto che verso i laici. I canoni 15 e 16 concernono la stabilità del clero. Essi proibiscono ai vescovi, ai preti e ai diaconi di trasferirsi da una città e diocesi ad un altra e proibiscono ai vescovi di procurarsi clero da altra diocesi. Il canone 17 proibisce al clero di prestare ad usura e il canone 18 ricorda ai diaconi che il loro rango liturgico è inferiore a quello dei vescovi e dei preti. Il canone 19 è interessante per la grande importanza data alla dottrina sulla Trinità e perché menziona le diaconesse, che devono essere considerate laiche. Infine il canone 20 proibisce di inginocchiarsi di domenica e durante il tempo di Pentecoste e chiede ai cristiani che in questo periodo le preghiere a Dio si facciano in piedi. ALTRI CONCILI Consideriamo ora altri due concili: Trullo e Costantinopoli IV. Il concilio trullano, detto anche sinodo trullano o concilio in Trullo, si riunì nella sala a volta (dal greco trullos) del palazzo dell imperatore Giustiniano II a Costantinopoli nel 692. In tale concilio vennero promulgati 102 canoni. In Oriente tale concilio viene considerato la continuazione del sesto concilio ecumenico, Costantinopoli III del , o completamento del quinto (Costantinopoli II del 553) e del sesto concilio, per cui viene denominato Quinisext (o Quinisesto), perché esso fornì i canoni disciplinari carenti in quei due concili. Diversi canoni causarono problemi a Roma, perché critici verso varie prassi della Chiesa romana. Tale concilio si considerava ecumenico e godeva di un certo grado di accettazione come tale in 5
7 Occidente. Ma successivamente venne omesso dall elenco dei concili ecumenici in Occidente. Il Costantinopoli IV subì una sorte opposta, cioè venne accettato come un concilio ecumenico in Occidente ma rifiutato come tale in Oriente. Tale concilio si riunì nel periodo per confermare la deposizione di Fozio, patriarca di Costantinopoli, intrapresa dagli imperatori orientali e approvata dal papa poco prima. La deposizione di Fozio era confermata in quanto egli venne eletto patriarca irregolarmente da un vescovo scomunicato. Fozio, più tardi, fu riabilitato come patriarca e venerato santo nella Chiesa orientale. In anni recenti, gli studiosi occidentali ritengono che tale concilio non debba essere considerato ecumenico. Oggi è il momento per la Chiesa cattolica romana di riconoscere il suo errore più ufficialmente, e perciò di eliminare l offesa avvertita dalla Chiesa orientale per la lunga accettazione da parte della Chiesa occidentale del concilio come ecumenico. 2. Concili medioevali: dal Laterano I al Laterano V 2 INTRODUZIONE Nel periodo che va dallo scisma tra le Chiese orientali e occidentali (inizio secolo XI) e le successive divisioni all interno alla Chiesa occidentale dovute alla Riforma (secolo XVI), si sono verificati i seguenti concili (detti concili medioevali): - Laterano I (1123); - Laterano II (1139); - Laterano III (1179); - Laterano IV (1215); - Lione I (1245); - Lione II (1271); - Vienne ( ); - Costanza ( ); - Basilea-Firenze ( ); - Laterano V ( ). Lo scisma avvenne nel 1054, quando vennero scambiate le scomuniche fra Roma e Costantinopoli. Non fu possibile sanare tale scisma ma anzi si acuì con la devastazione di Costantinopoli da parte dei crociati occidentali nel Di conseguenza, mentre i sette concili ecumenici vennero celebrati all interno della Chiesa orientale, tutti quelli compresi tra il Laterano I del 1123 e il Laterano V del , vennero celebrati nell Europa occidentale: i cinque concili lateranensi nel palazzo o basilica del Laterano a Roma, due concili a Lione in Francia, uno a Vienne 2 Cfr. ivi, p.55. 6
8 nella Francia meridionale, uno a Costanza nella Germania meridionale, uno in parte a Basilea in Svizzera e in parte a Firenze in Italia. Quelli sopraindicati hanno avuto partecipanti che provenivano per la maggior parte dalla Chiesa occidentale. A causa dello scisma, solo una piccola delegazione della Chiesa orientale partecipò al concilio di Lione II e al concilio di Firenze, ma questa volta si presentò una delegazione piuttosto grande. La lingua principale dei concili passò dal greco al latino. Ora è il papa che convoca il concilio e non più l imperatore d Oriente e inoltre, nei concili medioevali l importanza maggiore viene data ai decreti disciplinari rispetto ai decreti dottrinali, mentre nei concili dell antichità avveniva il contrario. La Chiesa ortodossa considera ecumenici solo i primi sette concili ai quali ha partecipato, mentre non ha partecipato ai successivi concili. Il tentativo di promuovere i concili medioevali al livello di concili ecumenici avvenne durante la Controriforma. Il card.roberto Bellarmino, gesuita e il card.cesare Baronio influirono sull elaborazione e pubblicazione della Edizione Romana dei concili. L edizione conferiva ai concili medioevali lo stesso carattere di quelli della Chiesa antica, chiamandoli tutti ecumenici nella parte greca del titolo del libro e generali in quella latina. Essa stese un elenco di 19 concili, così distribuiti: - i sette concili ecumenici, da Nicea I a Nicea II; - il Costantinopoli IV; - i dieci concili medioevali, dal Laterano I al Laterano V (escludendo la parte di Basilea del Basilea-Firenze); - il concilio di Trento. L elenco fu ampiamente accettato all interno della Chiesa cattolico-romana e tutti i concili vennero detti ecumenici. Ci furono due interventi importanti: del teologo domenicano Yves Congar e di Paolo VI che mettevano in discussione l elenco dei 21 concili ecumenici (1 19 sopraindicati più il Vaticano I e il Vaticano II). Paolo VI considerava il concilio Lione II e gli antichi concili medioevali come concili generali d Occidente, C è stata, fin dal 1974, una tendenza generale perfino all interno della comunione cattolico-romana nel seguire l indicazione di Paolo VI di denominare i concili medioevali concili generali della Chiesa occidentale piuttosto che nell attribuire loro il titolo di ecumenici. I dieci concili medioevali furono i concili più autorevoli nella cristianità occidentale che comprendeva la maggioranza dei cristiani. I successivi concili generali della Chiesa cattolico-romana, cioè Trento, il Vaticano I e il Vaticano II si considerano in continuità con i concili medioevali della Chiesa d Occidente. Malgrado lo scisma tra Oriente e Occidente del 1054, si potrebbe asserire che la corrente principale della vita e dello sviluppo nella Chiesa passò gradualmente e per molti secoli alla cristianità occidentale e i concili dal Laterano I al Laterano V formarono il nucleo centrale dello sviluppo conciliare durante la prima metà del periodo occidentale. 7
9 I CONCILI PAPALI: DAL LATERANO I AL VIENNE I primi sette concili generali, dal Laterano I nel 1123 al concilio di Vienne nel sono detti concili papali perché la convocazione, la presidenza e la promulgazione dei decreti era opera del papa in persona o attraverso suoi delegati. Il concilio Laterano IV del 1215 fu il più importante dei sette concili generali. Venne convocato nel 1215 da papa Innocenzo III con il proposito di eliminare le eresie, riformare i costumi e rafforzare la fede.vi parteciparono più di 400 vescovi da tutta la cristianità occidentale e vennero approvati 71 documenti del concilio. Di seguito sono esaminati quei documenti che, a mio giudizio, meritano una maggiore attenzione. Va notato che solo i documenti 1 e 2 riguardano la dottrina e la teologia, tutti gli altri sono di natura disciplinare. Pur essendo esigua la dottrina, questa veniva però espressa in altri ambiti, specialmente nelle università. La prima costituzione è un Credo, diretto principalmente contro i catari, un eresia dualista che considerava diabolico il mondo materiale e costituiva una seria minaccia alla cristianità ortodossa di allora. Tale costituzione contiene la prima menzione della transustanziazione. Il terzo decreto è una condanna di tutti gli eretici sotto qualunque nome si presentino. I decreti 5, 6 e 9 riguardano l organizzazione della Chiesa dell antichità. Erano conservati i cinque patriarcati di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Ma Alessandria, Antiochia e Gerusalemme erano in mano dell Islam e Roma non aveva alcuna autorità sugli altri patriarcati. La Chiesa medioevale fu per molti aspetti più democratica e pluralista della Chiesa cattolico-romana oggi. I temi dei restanti decreti possono essere divisi come segue: - il clero e gli ordini religiosi; - i laici; - i non cristiani. Molti decreti riguardano lo stile di vita del clero (dal decreto 10 sino al decreto 20): castità, cibo, bevande, vesti, occupazioni proibite, l educazione, la preparazione, ecc. Dei decreti che più direttamente riguardano i laici,influente fu il 21 sulla confessione e comunione annuale ( dovere di comunicarsi almeno a Pasqua ). Un decreto interessante è il 22: Gli infermi provvedano prima all anima poi al corpo. Il matrimonio è l argomento trattato nei decreti Inoltre altri decreti trattano i seguenti argomenti: - relazioni tra i laici e il clero; - relazioni con il mondo non cristiano; - sulla crociata in Terra Santa. 8
10 Nel concilio Laterano IV sono presenti: parole dure contro gli eretici, il trattamento degli ebrei, l incoraggiamento alla guerra, la repressione dello Spirito con la proibizione di nuovi ordini religiosi e altre proliferazioni ma anche un appassionato impegno per la verità, perché gli esseri umani raggiungano il loro destino divino, e una grande attenzione ai mezzi per questo fine. In complesso tale concilio emanò decreti di un certo rilievo in quasi tutte le aree della vita cristiana e tutto questo in un periodo in cui ci furono grandi santi (S.Francesco e S.Chiara d Assisi), quattro ordini di frati (Francescani, Domenicani, Carmelitani e Agostiniani), le università (Bologna, Parigi e Oxford), grandi teologi (Tommaso d Aquino, Duns Scoto), chiese parrocchiali e cattedrali, l Inquisizione, le crociate e lo scisma con la Chiesa orientale. Il concilio Laterano IV non produsse tutto questo ma ne fu almeno una guida. COSTANZA, BASILEA-FIRENZE e LATERANO V I concili di Costanza e di Basilea-Firenze testimoniano una grande crisi costituzionale nella Chiesa. Nel 1377, il papa Gregorio XI muore a Roma, dopo qualche mese dal ritorno a Roma, dopo un periodo di permanenza ad Avignone. Quindi viene eletto papa Urbano VI, ma la sua elezione viene contestata dalla popolazione romana. I cardinali lo deposero eleggendo al suo posto Clemente VII, che preferì trasferirsi ad Avignone, mentre Urbano VI rimase a Roma. I due papi Urbano VI e Clemente VII stabilirono, ciascuno, la propria corte papale e il proprio collegio di cardinali. Lo scisma durò per circa quarant anni. Per risolvere la crisi venne convocato nel 1409 il concilio di Pisa che depose i due papi ed elesse Alessandro V,che morì l anno successivo e a cui succedette Giovanni XXII. Poiché i due papi deposti raccoglievano un certo appoggio, l esito fu l addizione di un terzo papa piuttosto che la fine dello scisma. Viene convocato il concilio di Costanza nel 1414 da Giovanni XXII. Quando questi si accorse che il concilio non voleva confermarlo nella sua posizione, si spaventò e fuggì da Costanza. Mentre si trovava in esilio, l assemblea emanò il famoso decreto sulla superiorità del concilio sul papa. Viene abitualmente detto il decreto Haec sancta, in accordo con le prime due parole latine di apertura dell invocazione alla Trinità Questa santa. Il concilio riuscì a deporre Giovanni XXII. Il concilio emanò due decreti Frequens e Quanto romanus pontifex. Il decreto Frequens stabilisce che un altro concilio generale si sarebbe dovuto indire cinque anni immediatamente dopo la fine dell attuale, un secondo sette anni dopo e successivamente ce ne sarebbe dovuto essere uno ogni dieci anni, per sempre. Il decreto, inoltre, stabiliva un meccanismo per assicurare che i concili fossero indetti qualora il papa avesse rifiutato di cooperare nel convocarli. L altro decreto, Quanto romanus pontifex, prevede un giuramento che il successivo papa è obbligato a pronunciare e presenta una buona immagine dei controlli costituzionali sul papato predisposti dal concilio. Il concilio era esausto a causa degli sforzi per sanare lo scisma, convocato per tre anni prima che eleggesse il 9
11 nuovo papa, Martino V, così potè occuparsi ben poco della riforma della Chiesa, il suo secondo scopo principale, prima di prendere la decisione di sciogliersi e di rimandare la riforma al prossimo concilio. L importanza del concilio di Costanza è legata ai decreti Haec sancta, Frequens e Quanto romanus pontifex, ma il carattere dei tre decreti è vivacemente dibattuto fra gli studiosi cattolico-romani. Il dibattito verteva sulla considerazione se i decreti dovevano ritenersi autentici di un concilio ecumenico e generale. Riserve sui decreti vennero espresse da Martino V e più energicamente da Eugenio IV, i papi successivi alla fine dello scisma. Inoltre, al tempo della Controriforma e più tardi ci furono vari tentativi di escludere il concilio di Costanza dall elenco dei concili ecumenici o generali. D altra parte, Costanza all interno della cristianità occidentale fu ampiamente accettato come legittimo con i tre decreti in questione correttamente promulgati. Il papato, inoltre, non rigettò mai i decreti di Costanza in modo esplicito e ufficiale e ne stabilì diverse conferme. L opinione del Prof. Tanner, autore del libro oggetto del tema, è che il concilio di Costanza, e i suoi tre più importanti decreti, dovrebbero essere considerati autentici decreti di un concilio generale della Chiesa occidentale. Rimane il problema di come conciliarli con i decreti del Vaticano I sull ufficio papale. In breve tempo però, il movimento conciliare fallì. Cinque anni dopo la fine del concilio di Costanza, un concilio si radunò a Pavia nel 1423, più tardi si spostò a Siena ma non ebbe molto successo. Il successivo concilio si radunò a Basilea nel 1431; ma, poco dopo la sua apertura, si scontrò con il papa Eugenio IV, succeduto a Martino V. Fu raggiunto un compromesso e nel 1438 Eugenio IV, contro la maggioranza che preferì rimanere a Basilea, trasferì il concilio prima a Ferrara e poi a Firenze. La maggioranza, rimasta a Basilea, rifiutò di riconoscere il concilio di Ferrara-Firenze e depose Eugenio IV da papa, eleggendo al suo posto il duca di Savoia che assunse il nome di Felice V. Eugenio IV di fatto prevalse e il concilio di Basilea, trasferitosi a Losanna, si dissolse nel 1449, perché non si riprese mai e gradualmente perse l appoggio all interno della cristianità occidentale. Un fattore preponderante nella vittoria di Eugenio IV fu la sua negoziazione con la Chiesa greca per la riunione. Gli riuscì nel persuadere la delegazione di spostarsi da Costantinopoli a Firenze e il conseguente accordo sulla riunione. La delegazione orientale venne guidata dall imperatore Giovanni VIII Paleologo e dal patriarca Giuseppe di Costantinopoli. C era il desiderio di un accordo tra l imperatore e il papa. I greci accettarono la legittimità della clausola Filioque ma senza l obbligo di includerla nel loro Credo. Venne accettata una diversità di prassi per il pane lievitato o azzimo nell eucaristia. Sul purgatorio fu raggiunta una formula di compromesso. Infine al papato viene riconosciuto il pieno potere di pascere, reggere e governare la Chiesa universale. Ma non ci fu accordo con la delegazione 10
12 orientale. Il concilio di Firenze raggiunse accordi con gli Armeni, Copti, Siriaci e altre Chiese. Il Lateranense V, l ultimo dei concili prima della Riforma, venne convocato dal papa Giulio II, soprattutto per godere del diritto di precedenza sul concilio di Pisa radunato da diversi cardinali ostili a Giulio II e appoggiati dal re di Francia, Luigi XII. Tale concilio dedicò molto del suo tempo nel promulgare decreti contro il concilio di Pisa. Il Laterano V discusse la riforma della Chiesa ma attuò ben poco. Si concluse nel marzo 1517, alcuni mesi prima che Martin Lutero iniziasse la Riforma affiggendo le 95 tesi alla porta della cappella del castello di Wittenburg, quindi nel concilio c è una straordinaria carenza di consapevolezza di quanto la cristianità stava per affrontare. 3. I concili dell era moderna. 3 INTRODUZIONE I tre concili generali dell epoca moderna sono: - concilio di Trento ( ); - concilio Vaticano I ( ); - concilio Vaticano II ( ). Brevemente, si può dire che il concilio di Trento, dominato dai cambiamenti della Riforma protestante, costituì la risposta forte della Chiesa cattolico-romana, detta Controriforma. Il Vaticano I fu dominato da un unico intento, l infallibilità pontificia mentre il Vaticano II divenne consapevolmente, più di ogni altro concilio, un concilio del suo tempo. In questi tre concili non c è continuità, né di stile né di contenuto, con i precedenti concili. Ma ci sono i seguenti temi comuni ai tre concili menzionati: - la questione del loro carattere: ci fu l assenza della Chiesa orientale e la non partecipazione delle Chiese protestanti, per cui tali concili vengono meglio definiti come concili generali della Chiesa cattolico-romana, piuttosto che concili generali della Chiesa occidentale, come i concili medioevali; - i tre concili, malgrado la loro diversità, si riferirono l uno all altro; - i tre concili dominarono sia il pensiero cattolico-romano, sia la tradizione conciliare. L influenza di Trento sulla teologia cattolico-romana per diversi secoli rese gli altri concili, sia generali che locali, quasi non necessari. Il Vaticano I introdusse l autorità del papato negli insegnamenti di fede e di morale. Il Vaticano II appoggiò l approccio conciliare con il suo incoraggiamento al dialogo e alla discussione sia all interno della Chiesa sia all esterno. 3 Cfr. ivi, p
13 TRENTO Il concilio di Trento si riunì nel 1545, quasi trent anni dopo la iniziale rottura di Martin Lutero con la Chiesa romana. In questo intervallo di tempo, la Riforma protestante ebbe modo di diffondersi ampiamente, lasciando profonde ferite nella Chiesa romana. Le ragioni di questo ritardo sono diverse, e fra queste quella di decidere il luogo ove convocare il concilio: il papa preferiva una zona vicino Roma mentre l imperatore Carlo V preferiva Trento, perché anticamente parte del feudo dell imperatore e quindi da lui accettabile. Il concilio durò diciotto anni; le sessioni vennero concentrate in tre periodi: , , In diverse occasioni il futuro del concilio fu seriamente in dubbio. Per un lungo intervallo ( ), il papa regnante Paolo IV si dimostrò ostile alla sua continuazione. Il suo successore Pio IV riconvocò il concilio e durante il suo terzo ed ultimo periodo ci fu una buona presenza di oltre 200 vescovi, rappresentativi della Chiesa cattolico-romana. Il concilio produsse una notevole serie di decreti che affrontarono i molti problemi sollevati dalla Riforma. Nel suo primo decreto essenziale proclamò il Credo niceno-costantinopolitano del 381 (con l aggiunta della clausola del Filioque). Poi affermò la relazione fra la Scrittura e la tradizione come fonti dell autorità nella Chiesa e, in secondo luogo, il ruolo della fede e delle buone opere nella giustificazione: due argomenti tra i più controversi nel dibattito della Riforma. Il decreto sul peccato originale, entrato in serio dibattito con i Riformatori, stabilisce che la colpa del peccato originale è realmente rimessa con il Battesimo, non soltanto cancellato o non imputato, ma nei battezzati rimane la concupiscenza o passione. Il decreto sulla giustificazione afferma, in consonanza con i Riformatori, che ogni iniziativa proviene da Dio per mezzo di Gesù Cristo, ma asserisce che noi abbiamo un ruolo liberamente consentendo e cooperando alla stessa grazia. Inoltre lo stesso decreto afferma : Vedete che l uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede (Gc 2, 24). Ai sacramenti viene concessa una lunga trattazione. Esiste un decreto sui sacramenti in generale che difende i sette sacramenti, contro la dottrina dei due sacramenti, Battesimo ed Eucaristia, che era comune fra i Riformatori. L Eucaristia viene trattata molto dettagliatamente. La dottrina sulla transustanziazione, enunciata brevemente al concilio Lateranense IV del 1215, come già visto, ora affermato in modo più rigoroso, dimostrò di essere un grosso ostacolo per tutti i Riformatori. Altri argomenti dottrinali del dibattito con i protestanti furono oggetto di decreti, soprattutto verso la fine del concilio: il purgatorio, l intercessione dei santi, le indulgenze, l istruzione e predicazione, ordini religiosi di uomini e donne, idoneità e responsabilità delle persone investite dei benefici, inclusi gli abusi del possesso di più benefici, varie pratiche devozionali. Inoltre ci fu un decreto sui seminari che si è dimostrato molto influente. Fino ad allora la preparazione della maggior parte dei preti diocesani era relativamente 12
14 disorganizzata. Pochi studiavano all università, ma la maggior parte aveva una preparazione irregolare, parzialmente con il prete della parrocchia locale. Il decreto di Trento ordinava l istituzione di collegi diocesani per ragazzi dai dodici anni in poi, con preferenza data ai figli dei poveri, cui sarebbe stata impartita una preparazione spirituale, accademica e pratica. Inoltre il concilio di Trento prese delle misure molto importanti che sfociarono nell Index dei libri proibiti ai cattolici, nel Catechismo di Trento, e nel Messale Romano contenente i riti successivamente noti come Messa tridentina e Breviario Romano. Il concilio di Trento diede al cattolicesimo romano struttura e sicurezza, concludendo gli anni della difesa di fronte alla Riforma. VATICANO I Dopo il concilio di Trento, non si avvertiva il bisogno di un altro concilio. Ma si erano verificati diversi eventi, tra i quali ricordiamo: - la rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione industriale iniziata nel tardo secolo XVIII; - l Illuminismo nel secolo XVIII, che lanciò molte sfide intellettuali alla cristianità; - avanzamenti della scienza, con le ricerche di Darwin sull origine dell umanità. Questi ed altri eventi avevano provocato profondi cambiamenti nel clima politico, sociale ed economico specialmente del mondo occidentale. Una parte dei cristiani, i conservatori, vide con sospetto tali cambiamenti, un altra parte, invece, accettava quanto vi era di buono ed era disposta ad esaminare un eventuale riconciliazione. Il concilio venne convocato da Pio IX, eletto papa nel 1847, per discutere sull autorità della Chiesa, specialmente del ruolo del papato e della sua infallibilità. Nel 1864 Pio IX emanò un Syllabus di errori, la cui conclusione condannava chi asseriva che il pontefice doveva e poteva riconciliare e adattare se stesso al progresso, al liberalismo e alla civiltà moderna. Tuttavia il primo dei due documenti promulgati dal concilio, rappresentava un serio tentativo di dialogo con il mondo intellettuale di allora. La prima Costituzione sulla fede cattolica (con il titolo latino Dei Filium) cercò di collocarsi tra un esaltazione eccessiva dell autorità della ragione, coltivata dall Illuminismo, e un rifiuto della ragione, caratteristico del fondamentalismo religioso. Di questa Costituzione si riporta solo un estratto, a mio giudizio, molto significativo: Non solo la fede e la ragione non possono mai essere in contrasto tra di loro, ma possono darsi un aiuto scambievole: la retta ragione, infatti, dimostra i fondamenti della fede e, illuminata dalla sua luce, può coltivare la scienza delle cose divine; la fede, invece, libera e protegge la ragione dagli errori e l arricchisce di molteplici cognizioni. 13
15 Il Vaticano I è soprattutto noto per la sua seconda Costituzione sulla Chiesa di Cristo (titolo latino Pastor aeternus), e specialmente per il capitolo sull infallibilità pontificia. In questa Costituzione occorre fare attenzione su alcuni punti. Il primo: l infallibilità del papa si ha quando egli si esprime in forma solenne, ex cathedra, cioè quando, adempiendo il suo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, definisce, in virtù della sua suprema autorità apostolica, che una dottrina in materia di fede e di costumi deve essere ammessa da tutta la Chiesa. Quindi, per la sua infallibilità, il papa deve definire una dottrina in materia di fede e di costumi. Inoltre l argomento di dottrina deve essere di grande importanza o centrale per la fede da essere ammessa da tutta la Chiesa. Bisogna notare, inoltre, che il testo non dice direttamente che il papa sia infallibile. Asserisce piuttosto che, quando le suddette condizioni siano state adempiute, il papa gode di quella infallibilità, di cui il divino Redentore ha voluto fosse dotata la sua Chiesa. In conclusione, Di conseguenza queste definizioni del sommo pontefice sono irreformabili per se stesse, e non in virtù del consenso della Chiesa. Quindi l infallibilità è data al papa per il servizio della Chiesa e non per la personale gratificazione del papa. Malgrado avesse sollevato un certo numero di problemi, la Costituzione venne approvata il 13 luglio Il 18 luglio scoppiò la guerra tra Francia e Prussia e vennero allontanate da Roma le truppe francesi che avevano presidiato la città per il papa contro le truppe italiane. Il 20 settembre le truppe di Garibaldi entrarono a Roma e il concilio fu chiuso: un mese più tardi papa Pio IX formalmente ne aggiornò le sedute indefinitivamente. Al concilio erano presenti circa 700 vescovi. Le Chiese ortodosse e protestanti non erano rappresentate. Dopo questo concilio, il ruolo del papato richiese di essere completato con i ruoli degli altri membri della Chiesa, ma questo lavoro venne completato, quasi un secolo dopo, dal Vaticano II. VATICANO II Il concilio di Trento esercitava ancora una grande influenza negli anni 50 e la definizione del Vaticano I dell infallibilità del papa sembrò provvedere i mezzi per risolvere ogni futuro dibattito. Quando, invece, papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, tre mesi dopo la sua elezione, annunciò che desiderava convocare un nuovo concilio ecumenico, la sorpresa fu considerevole anche se si era parlato, sia da Pio XI che da Pio XII, di un possibile concilio per completare il lavoro del Vaticano I. Nella lettera Humanae salutis del dicembre 1961, in cui papa Giovanni XXIII ufficialmente indice il concilio per convocarlo l anno successivo, vengono indicati tre principali scopi del concilio: - il migliore ordinamento interno della Chiesa; - l unità tra i cristiani; - la promozione della pace in tutto il mondo. 14
16 Il concilio si svolse dal 1962 al 1965: Giovanni XXIII morì nel giugno 1963 e Paolo VI gli succedette come papa poche settimane dopo. Il concilio approvò sedici documenti, così distinti: Quattro costituzioni: Sacrosanctum Concilium (1963) Lumen Gentium (1964) Dei Verbum (1965) Gaudium et Spes (1965) Tre dichiarazioni : sull educazione cristiana sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane sulla libertà religiosa Nove decreti. Mi limito a dare una breve descrizione delle quattro costituzioni. Solo il 4 dicembre 1963 venne approvata la Costituzione sulla sacra liturgia (Sacrosanctum Concilium). Ci fu un consenso generale su due punti: la necessità di una partecipazione più grande alla liturgia e all eucaristia specialmente da parte dei laici e, secondariamente, la necessità di ritornare alle fonti della liturgia. Circa il cambiamento dal latino alle lingue locali, che fu un mutamento rilevante, questo può riuscire assai utile per il popolo specialmente nelle letture e in alcune preghiere. Il 21 novembre 1964 venne approvata la Costituzione dogmatica sulla Chiesa (Lumen Gentium). Nei primi due capitoli, la Chiesa viene definita in primo luogo mistero e popolo di Dio. Quindi si parla della Chiesa gerarchica del papa e dei vescovi. Seguono i capitoli sui laici e sulla chiamata di tutti i cristiani alla santità. Quindi, nei capitoli successivi, si parla degli ordini religiosi. L ultimo capitolo è dedicato a Maria, trattata all interno del contesto della Chiesa, come modello e archetipo. La Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione (Dei Verbum), approvata il 18 novembre 1965, è la più teologica tra le Costituzioni. Essa tiene conto del decreto di Trento sulla Scrittura e la Tradizione e tenta di collegarli insieme. La Costituzione, inoltre, accentua la persona di Cristo come fonte della rivelazione. L ultimo documento approvato fu la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et Spes), approvata il 7 dicembre Questa Costituzione può essere considerata sia come un compendio del lavoro del concilio e sia come un applicazione alla vita nella chiesa e fuori di essa. E il primo documento, nella storia dei concili ecumenici e generali, ad essere rivolto direttamente al mondo più vasto, a tutti indistintamente gli uomini. In generale, tuttavia, la Costituzione può essere considerata come quella che portò il concilio nelle realtà della vita. I sedici documenti vennero, di fatto, approvati a larga maggioranza, malgrado gli accesi dibattiti durante la loro preparazione. Questi documenti furono stilati in forma di saggio e di esortazione piuttosto che di definizioni dogmatiche e di canoni 15
17 disciplinari e nessuno di essi conteneva degli anatemi. Oltre duemila persone (dai ai circa) presero parte come membri del concilio. La larga maggioranza era formata da vescovi, rappresentanti quasi tutte le sedi cattolico-romane nel mondo, alcuni capi di ordini religiosi e altri, pure presenti come membri. La maggioranza dei vescovi portò uno o due teologi per assisterli e questi periti (esperti) presero parte alla stesura degli schemi preparatori, pur senza essere membri con diritto di voto al concilio. Ricordiamo alcuni di questi periti: - Hans Kung dalla Svizzera, - Karl Rahner dalla Germania - Yves Congar, Henri de Lubac e Jean Danielou dalla Francia. Inoltre, le Chiese delle tradizioni ortodosse e protestanti e altre, vennero invitate a mandare osservatori e questi pure dettero un contributo notevole al decreto sull ecumenismo. Il Vaticano II fu il concilio più ampio e più ecumenico nella storia della Chiesa, anche se fu un concilio solo della Chiesa cattolico-romana. Nell immediato dopo concilio ci fu molto entusiasmo ma i problemi emersero quando i documenti dovettero essere messi in atto, per esempio per quanto riguarda la liturgia e la riforma degli ordini religiosi. Il Vaticano II si è dimostrato un grande passo in avanti nelle relazioni ecumeniche e ha cambiato radicalmente l agire per la riunificazione. Certamente il Vaticano II è stato il più importante evento nella vita della Chiesa nel XX secolo e i suoi effetti si vedranno nel XXI secolo. 16
LA RIFORMA PROTESTANTE. 1517: le 95 TESI di MARTIN LUTERO
 LA RIFORMA PROTESTANTE 1517: le 95 TESI di MARTIN LUTERO MARTIN LUTERO CHI ERA? Un monaco agostiniano tedesco e professore di teologia a Wittenberg E il fondatore del PROTESTANTESIMO, una dottrina religiosa
LA RIFORMA PROTESTANTE 1517: le 95 TESI di MARTIN LUTERO MARTIN LUTERO CHI ERA? Un monaco agostiniano tedesco e professore di teologia a Wittenberg E il fondatore del PROTESTANTESIMO, una dottrina religiosa
Riforma protestante. scaricato da
 Riforma protestante A causa degli atteggiamenti criticabili della Chiesa cattolica in Europa, nel Cinquecento crebbe sempre di più il malcontento dei fedeli. Esso era causato da alcune consuetudini discutibili
Riforma protestante A causa degli atteggiamenti criticabili della Chiesa cattolica in Europa, nel Cinquecento crebbe sempre di più il malcontento dei fedeli. Esso era causato da alcune consuetudini discutibili
Questioni di storia della Chiesa dalle origini al Concilio di Trento
 Stefano Sodi e Maria Luisa Ceccarelli Lemut Questioni di storia della Chiesa dalle origini al Concilio di Trento Edizioni ETS www.edizioniets.com Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo
Stefano Sodi e Maria Luisa Ceccarelli Lemut Questioni di storia della Chiesa dalle origini al Concilio di Trento Edizioni ETS www.edizioniets.com Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo
Penitenza e unzione dei malati
 Angelo Maffeis Penitenza e unzione dei malati Queriniana Indice generale Introduzione.... 5 parte prima Penitenza 1. Il sacramento della penitenza tra passato e presente... 11 1. La confessione nella chiesa
Angelo Maffeis Penitenza e unzione dei malati Queriniana Indice generale Introduzione.... 5 parte prima Penitenza 1. Il sacramento della penitenza tra passato e presente... 11 1. La confessione nella chiesa
Capitolo 4 La Riforma protestante
 Capitolo 4 La Riforma protestante 1517 Pubblicazione delle 95 tesi di Lutero contro le indulgenze 1542 Istituzione da parte della Chiesa cattolica del Santo Uffizio dell inquisizione 1521 Scomunica di
Capitolo 4 La Riforma protestante 1517 Pubblicazione delle 95 tesi di Lutero contro le indulgenze 1542 Istituzione da parte della Chiesa cattolica del Santo Uffizio dell inquisizione 1521 Scomunica di
Pagine corrispondenti sul libro:
 Pagine corrispondenti sul libro: 160-169 1. LA CORRUZIONE DELLA CHIESA SIMONIA Sempre più spesso vescovi e cardinali apparivano interessati alla ricchezza e al potere politico, più che al ruolo religioso
Pagine corrispondenti sul libro: 160-169 1. LA CORRUZIONE DELLA CHIESA SIMONIA Sempre più spesso vescovi e cardinali apparivano interessati alla ricchezza e al potere politico, più che al ruolo religioso
Il Cristianesimo e la Riforma protestante. Lezioni d'autore
 Il Cristianesimo e la Riforma protestante Lezioni d'autore Il Cristianesimo è oggi la religione più diffusa al mondo con 2,1 miliardi di fedeli (33% degli abitanti del pianeta): cattolici, 1 miliardo (17,5%)
Il Cristianesimo e la Riforma protestante Lezioni d'autore Il Cristianesimo è oggi la religione più diffusa al mondo con 2,1 miliardi di fedeli (33% degli abitanti del pianeta): cattolici, 1 miliardo (17,5%)
UN TERMINE IMPORTANTE
 UN TERMINE IMPORTANTE Il termine ortodosso deriva dal greco e indica la retta opinione, la dottrina. È dunque un esempio di autoattribuzione di un etichetta che indica il giusto posizionamento: gli ortodossi
UN TERMINE IMPORTANTE Il termine ortodosso deriva dal greco e indica la retta opinione, la dottrina. È dunque un esempio di autoattribuzione di un etichetta che indica il giusto posizionamento: gli ortodossi
RIFORMA E CONTRORIFORMA
 RIFORMA E CONTRORIFORMA Nel XVI secolo la Chiesa era corrotta: i Papi, di nobili origini, erano simili a sovrani e riscuotevano pesanti tasse dalla popolazione. Praticavano il NEPOTISMO I peccatori pentiti
RIFORMA E CONTRORIFORMA Nel XVI secolo la Chiesa era corrotta: i Papi, di nobili origini, erano simili a sovrani e riscuotevano pesanti tasse dalla popolazione. Praticavano il NEPOTISMO I peccatori pentiti
CHIESA ANGLICANA. Chiesa d Inghilterra. nata dopo il distacco da Roma, nel 1534.
 CHIESA ANGLICANA Chiesa d Inghilterra. nata dopo il distacco da Roma, nel 1534. CHIESA ANGLICANA La Chiesa anglicana fu costituita nel 1534, quando Enrico VIII fece approvare dal parlamento l Atto di
CHIESA ANGLICANA Chiesa d Inghilterra. nata dopo il distacco da Roma, nel 1534. CHIESA ANGLICANA La Chiesa anglicana fu costituita nel 1534, quando Enrico VIII fece approvare dal parlamento l Atto di
Riforma protestante. pp
 Riforma protestante pp. 95-101 Stato della Chiesa: uno Stato spirituale Sutri, anno 728: con la donazione del castello di Sutri al papa Gregorio II, il re Longobardo Liutprando crea il primo nucleo dello
Riforma protestante pp. 95-101 Stato della Chiesa: uno Stato spirituale Sutri, anno 728: con la donazione del castello di Sutri al papa Gregorio II, il re Longobardo Liutprando crea il primo nucleo dello
La Chiesa cattolica romana al vaglio della Bibbia
 La Chiesa cattolica romana al vaglio della Bibbia BWHEBB, BWHEBL, BWTRANSH [Hebrew]; BWGRKL, BWGRKN, and BWGRKI [Greek] PostScript Type 1 and TrueType fonts Copyright 1994-2015 BibleWorks, LLC. All rights
La Chiesa cattolica romana al vaglio della Bibbia BWHEBB, BWHEBL, BWTRANSH [Hebrew]; BWGRKL, BWGRKN, and BWGRKI [Greek] PostScript Type 1 and TrueType fonts Copyright 1994-2015 BibleWorks, LLC. All rights
BATTESIMO E CONFERMAZIONE
 Pasquale Bua BATTESIMO E CONFERMAZIONE Queriniana Indice generale Presentazione........................................ 5 Introduzione: L iniziazione cristiana ieri e oggi............... 9 1. Il concetto
Pasquale Bua BATTESIMO E CONFERMAZIONE Queriniana Indice generale Presentazione........................................ 5 Introduzione: L iniziazione cristiana ieri e oggi............... 9 1. Il concetto
INDICE GENERALE. Prefazione degli editori dell opera parte quarta IL BASSO MEDIOEVO (Ludger Körntgen Martin Ohst)
 INDICE GENERALE Prefazione degli editori dell opera............................. 5 parte quarta IL BASSO MEDIOEVO (Ludger Körntgen Martin Ohst) INTRODUZIONE: Cambiamento e continuità, unità e molteplicità.....
INDICE GENERALE Prefazione degli editori dell opera............................. 5 parte quarta IL BASSO MEDIOEVO (Ludger Körntgen Martin Ohst) INTRODUZIONE: Cambiamento e continuità, unità e molteplicità.....
I DOCUMENTI DEL CONCILIOECUMENICO VATICANO II
 I DOCUMENTI DEL CONCILIOECUMENICO VATICANO II 1 BREVE STORIA DEL CONCILIO VATICANO II Qual è il valore religioso del nostro Concilio? L umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura
I DOCUMENTI DEL CONCILIOECUMENICO VATICANO II 1 BREVE STORIA DEL CONCILIO VATICANO II Qual è il valore religioso del nostro Concilio? L umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura
LA RIFORMA PROTESTANTE
 LA RIFORMA PROTESTANTE Lutero INDICE LA RIFORMA (DEFINIZIONE) LE CAUSE I FATTI LE CONSEGUENZE Cos è? E una rivoluzione religiosa che divise la cristianità in confessioni diverse (protestanti luterani,
LA RIFORMA PROTESTANTE Lutero INDICE LA RIFORMA (DEFINIZIONE) LE CAUSE I FATTI LE CONSEGUENZE Cos è? E una rivoluzione religiosa che divise la cristianità in confessioni diverse (protestanti luterani,
DISCIPLINA: Religione Cattolica
 CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
CLASSE PRIMA DISCIPLINA: Religione Cattolica SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE INDICAZIONI SINTETICA DI TEMI (CONTENUTI) O ARGOMENTI TRATTATI 1. Individuare ed esplicitare le domande di senso comuni agli uomini.
La Santa Sede CHIUSURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II PAOLO VI GLI ORGANISMI POST-CONCILIARI
 La Santa Sede CHIUSURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II PAOLO VI GLI ORGANISMI POST-CONCILIARI Sei organismi sono già stati creati per contribuire a realizzare concretamente le decisioni e le direttive
La Santa Sede CHIUSURA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II PAOLO VI GLI ORGANISMI POST-CONCILIARI Sei organismi sono già stati creati per contribuire a realizzare concretamente le decisioni e le direttive
Il Cinquecento: a) Situazione politica
 Il Cinquecento: a) Situazione politica A1- Italia - Re di Francia Carlo VIII con appoggio Ludovico il Moro scende in Italia. Non incontra resistenze e arriva a Napoli. (1494) - Lega antifrancese - Ritirata
Il Cinquecento: a) Situazione politica A1- Italia - Re di Francia Carlo VIII con appoggio Ludovico il Moro scende in Italia. Non incontra resistenze e arriva a Napoli. (1494) - Lega antifrancese - Ritirata
CRISTIANI NON CRISTIANI
 CRISTIANI ORTODOSSI CATTOLICI PROTESTANTI NON CRISTIANI EBREI ISLAMICI INDUISTI BUDDISTI Nel giorno di Pentecoste Gesù mantenne la promessa e inviò lo Spirito Santo SPIRITO SANTO APOSTOLI Rumore Vento
CRISTIANI ORTODOSSI CATTOLICI PROTESTANTI NON CRISTIANI EBREI ISLAMICI INDUISTI BUDDISTI Nel giorno di Pentecoste Gesù mantenne la promessa e inviò lo Spirito Santo SPIRITO SANTO APOSTOLI Rumore Vento
21 aprile del 753 fu fondata Roma (Romolo) XXXVI c.a XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V VI III II I. a. C.
 Invenzione Ruota (Sumeri 3500c.a.) Nascita scrittura (3100c.a.) Sancisce il passaggio dalla preistoria alla storia 1600 Invenzione Alfabeto Moderno 21 aprile del 753 fu fondata Roma (Romolo) 670 Scoperta
Invenzione Ruota (Sumeri 3500c.a.) Nascita scrittura (3100c.a.) Sancisce il passaggio dalla preistoria alla storia 1600 Invenzione Alfabeto Moderno 21 aprile del 753 fu fondata Roma (Romolo) 670 Scoperta
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico
Il Presidente della Repubblica
 VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
VISTO Il Presidente della Repubblica l articolo 87 della Costituzione; la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
Il Concilio Vaticano II Dichiarazione Nostra Aetate. Il dialogo con le religioni
 Il Concilio Vaticano II Dichiarazione Nostra Aetate Il dialogo con le religioni Il Concilio è stato il ventunesimo e ultimo dei concili della Chiesa cattolica Si svolse dal 1962 al 1965, sotto i pontificati
Il Concilio Vaticano II Dichiarazione Nostra Aetate Il dialogo con le religioni Il Concilio è stato il ventunesimo e ultimo dei concili della Chiesa cattolica Si svolse dal 1962 al 1965, sotto i pontificati
INDICE GENERALE. Avvertimento preliminare ai lettori 5. Prefazione alla nuova edizione 11
 INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
INDICE GENERALE Avvertimento preliminare ai lettori 5 Prefazione alla nuova edizione 11 Premessa all edizione italiana 15 Capitolo primo Una nuova introduzione? Interpretazione di Lutero al di là della
Elementi di Diritto Canonico
 1 José T. MARTÍN DE AGAR Elementi di Diritto Canonico 2ª edizione Edusc info@edusc.it, Roma 2008, 292 pag. Indice Generale NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA GENERALE DI BASE IN ITALIANO:
1 José T. MARTÍN DE AGAR Elementi di Diritto Canonico 2ª edizione Edusc info@edusc.it, Roma 2008, 292 pag. Indice Generale NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA GENERALE DI BASE IN ITALIANO:
LA CHIESA DELLE ORIGINI SI DIVIDE...
 LA CHIESA DELLE ORIGINI SI DIVIDE... RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 5A PRIMARIA SORAGNA A.S. 2012.2013 LA CHIESA CATTOLICA LA CHIESA Nel 1054 dopo lunghe discussioni riguardanti alcune verità di fede e l'importanza
LA CHIESA DELLE ORIGINI SI DIVIDE... RELIGIONE CATTOLICA CLASSE 5A PRIMARIA SORAGNA A.S. 2012.2013 LA CHIESA CATTOLICA LA CHIESA Nel 1054 dopo lunghe discussioni riguardanti alcune verità di fede e l'importanza
PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO
 CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO L UOMO E IL SACRO La Vocazione Missionaria della Chiesa. Il rinnovamento spirituale. Cristianesimo senza confini. Il cristianesimo nelle
CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 AREA STORICO-FENOMENOLOGICO L UOMO E IL SACRO La Vocazione Missionaria della Chiesa. Il rinnovamento spirituale. Cristianesimo senza confini. Il cristianesimo nelle
116 Capitolo 7 Europa carolingia La rinascita dell impero
 XIII Premessa 3 SNODO I MILLE ANNI DI STORIA 4 Capitolo 1 L idea di medioevo e le sue interpretazioni 4 1.1 Un età di decadenza 5 1.2 Un periodo della storia 7 1.3 La rivalutazione di un epoca 8 1.4 Il
XIII Premessa 3 SNODO I MILLE ANNI DI STORIA 4 Capitolo 1 L idea di medioevo e le sue interpretazioni 4 1.1 Un età di decadenza 5 1.2 Un periodo della storia 7 1.3 La rivalutazione di un epoca 8 1.4 Il
CLASSE QUINTA. 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio. Attività Verifiche Valutazione. Conoscenze ( Contenuti)
 CLASSE QUINTA 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio 1a Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 1b L alunno si confronta con l esperienza religiosa e del Cristianesimo
CLASSE QUINTA 1^ Unità di apprendimento: Apostoli in viaggio 1a Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 1b L alunno si confronta con l esperienza religiosa e del Cristianesimo
RIFORMA E CONTRORIFORMA
 RIFORMA E CONTRORIFORMA L EUROPA TRA TANTE RELIGIONI PROF.SSA A. MUCCI a.s. 2010-2011 QUESTIONE DI TERMINI! Riforma espressione con cui la storiografica ha indicato la protesta religiosa nei confronti
RIFORMA E CONTRORIFORMA L EUROPA TRA TANTE RELIGIONI PROF.SSA A. MUCCI a.s. 2010-2011 QUESTIONE DI TERMINI! Riforma espressione con cui la storiografica ha indicato la protesta religiosa nei confronti
Panoramica delle principali religioni
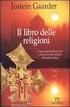 Panoramica delle principali religioni CRISTIANESIMO Il cristianesimo è la religione fondata sulla predicazione e sulla figura di Gesù di Nazareth I cristiani credono che Gesù sia il Messia, promesso dalla
Panoramica delle principali religioni CRISTIANESIMO Il cristianesimo è la religione fondata sulla predicazione e sulla figura di Gesù di Nazareth I cristiani credono che Gesù sia il Messia, promesso dalla
PASTORALE FAMILIARE. ritardo
 PASTORALE FAMILIARE Tre i capitoli della nostra vita : Ricerca della verità, cioè Dio (c.c.c.27ss). Rivelazione divina attraverso la quale Dio si manifesta all uomo (c.c.c.51ss). Risposta della fede (c.c.c.142ss).
PASTORALE FAMILIARE Tre i capitoli della nostra vita : Ricerca della verità, cioè Dio (c.c.c.27ss). Rivelazione divina attraverso la quale Dio si manifesta all uomo (c.c.c.51ss). Risposta della fede (c.c.c.142ss).
Indice. Prefazione Introduzione... 9
 Indice Prefazione................... 5 Introduzione................... 9 I. LA CHIESA CATTOLICA (GEOrG HInTzEn)... 13 1. Storia 13 Antichità 13 Medioevo 14 Evo moderno 15 2. Situazione odierna 15 3. Costituzione
Indice Prefazione................... 5 Introduzione................... 9 I. LA CHIESA CATTOLICA (GEOrG HInTzEn)... 13 1. Storia 13 Antichità 13 Medioevo 14 Evo moderno 15 2. Situazione odierna 15 3. Costituzione
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA
 IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
IL MEDIATORE DELLA SALVEZZA Soteriologia: Dispense per gli studenti Anno Accademico 2009 2010 I titoli indicati in rosso non entrano per l'esame Sommario PARTE INTRODUTTIVA: LA SALVEZZA DELL UOMO NEL VERBO
La Chiesa all inizio del Cinquecento
 La Chiesa all inizio del Cinquecento Gran parte del clero si era allontanata dagli insegnamenti di Cristo (umiltà, povertà, castità) CORRUZIONE MORALE DELLA CHIESA I Papi non erano più, da molti secoli,
La Chiesa all inizio del Cinquecento Gran parte del clero si era allontanata dagli insegnamenti di Cristo (umiltà, povertà, castità) CORRUZIONE MORALE DELLA CHIESA I Papi non erano più, da molti secoli,
Liceo G. Galilei Trento
 Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
Liceo G. Galilei Trento PIANI DI STUDIO IRC - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Unità orarie settimanali 1^biennio 2^biennio 5^anno Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Indirizzo Doppia lingua 1 1 1 1 1 Indirizzo
Prefazione Prima parte. 1. La Chiesa, bruna ma bella 9 2. Preparazione ad opera
 Indice Prefazione.... 5 Prima parte Il mio cammino nella Chiesa e con la Chiesa 1. La Chiesa, bruna ma bella 9 2. Preparazione ad opera dei movimenti preconciliari di rinnovamento 12 3. Influssi teologici
Indice Prefazione.... 5 Prima parte Il mio cammino nella Chiesa e con la Chiesa 1. La Chiesa, bruna ma bella 9 2. Preparazione ad opera dei movimenti preconciliari di rinnovamento 12 3. Influssi teologici
Anno 2013/2014 Programma di Storia Unità I Il Medioevo 1 Potere e strutture politiche nel Medioevo
 Anno 2013/2014 Programma di Storia Unità I Il Medioevo 1 Potere e strutture politiche nel Medioevo 1.1 Le condizioni materiali dell Europa 1.2 La nascita del sistema feudale 1.3 Il sacro romano impero
Anno 2013/2014 Programma di Storia Unità I Il Medioevo 1 Potere e strutture politiche nel Medioevo 1.1 Le condizioni materiali dell Europa 1.2 La nascita del sistema feudale 1.3 Il sacro romano impero
INDICE INDICE. Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA
 589 INDICE Premessa.... Abbreviazioni... V IX Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA 1. L esistenza di un vero diritto nella Chiesa di Cristo... 3 1.1. La contestazione
589 INDICE Premessa.... Abbreviazioni... V IX Parte Prima INTRODUZIONE CAPITOLO I IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA NELLA CHIESA 1. L esistenza di un vero diritto nella Chiesa di Cristo... 3 1.1. La contestazione
ADOLF ADAM WINFRIED HAUNERLAND CORSO DI LITURGIA. Nuova edizione interamente riveduta e aggiornata. Edizione italiana a cura di Gianni Francesconi
 ADOLF ADAM WINFRIED HAUNERLAND CORSO DI LITURGIA Nuova edizione interamente riveduta e aggiornata Edizione italiana a cura di Gianni Francesconi QUERINIANA Indice generale Premessa.... 5 Prefazione alla
ADOLF ADAM WINFRIED HAUNERLAND CORSO DI LITURGIA Nuova edizione interamente riveduta e aggiornata Edizione italiana a cura di Gianni Francesconi QUERINIANA Indice generale Premessa.... 5 Prefazione alla
Nel Medioevo, a differenza di oggi, il potere laico e il potere religioso erano legati e si confondevano tra loro.
 Nel Medioevo, a differenza di oggi, il potere laico e il potere religioso erano legati e si confondevano tra loro. Imperatore: difende la Chiesa e nomina i vescovi e gli abati l Vescovi e abati: avevano
Nel Medioevo, a differenza di oggi, il potere laico e il potere religioso erano legati e si confondevano tra loro. Imperatore: difende la Chiesa e nomina i vescovi e gli abati l Vescovi e abati: avevano
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla
 Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
Il Cinquecento rappresenta un momento decisivo per la cultura europea, che inizia a emanciparsi dalla secolare egemonia esercitata dalla chiesa sulla vita politica e culturale. Questo processo si avvia
RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas
 RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare
1. Programma di Teologia Fondamentale I IT /2010. Teologia Fondamentale I IT
 1. Programma di Teologia Fondamentale I IT - 2009/2010 Teologia Fondamentale I IT Schema sintetico del corso 2009-2010 INTRODUZIONE: ESSERE CREDENTI OGGI PRIMA PARTE LA DIVINA RIVELAZIONE E LA SUA TRASMISSIONE
1. Programma di Teologia Fondamentale I IT - 2009/2010 Teologia Fondamentale I IT Schema sintetico del corso 2009-2010 INTRODUZIONE: ESSERE CREDENTI OGGI PRIMA PARTE LA DIVINA RIVELAZIONE E LA SUA TRASMISSIONE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Al termine della scuola primaria L alunno: 1.1 Scoprire che la vita, la natura, il. di Gesù: far conoscere il Padre
 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Primaria - Religione Cattolica - Classe Prima COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Profilo
Disciplina d insegnamento: Religione cattolica
 CLASSE 1 A Che cos è la religione? Come si sono formate le religioni nel mondo? Un solo Dio, più dei Il mistero dell esistenza Il mistero della vita Stare con gli altri, il rapporto con l altro Stare nel
CLASSE 1 A Che cos è la religione? Come si sono formate le religioni nel mondo? Un solo Dio, più dei Il mistero dell esistenza Il mistero della vita Stare con gli altri, il rapporto con l altro Stare nel
1. L esistenza del magistero della Chiesa Le radici del ministero apostolico La Scrittura...131
 Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
Fondamenti del dogma Indice Pr e f a z i o n e d e l l a u t o r e... 5 Ab b r e v i a z i o n i... 7 No t a d e l c u r a t o r e... 9 In t r o d u z i o n e a l l o p e r a t e o l o g i c a d e l Ca
1. Introduzione all antropologia teologica orientale
 TEOLOGIA ORIENTALE 2 Anno Accademico 2012-2013 (Tutto il materiale didattico richiesto per lo studio personale è presente nella dispensa distribuita dal docente durante il corso) 1. Introduzione all antropologia
TEOLOGIA ORIENTALE 2 Anno Accademico 2012-2013 (Tutto il materiale didattico richiesto per lo studio personale è presente nella dispensa distribuita dal docente durante il corso) 1. Introduzione all antropologia
GRZEGORZ KADZIOCH. II ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e Orientale
 GRZEGORZ KADZIOCH II ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e Orientale EDITRICE PONTIFICIA UNIVERSITA GREGORIANA Roma 1997 INDICE GENERALE INTRODUZIONE PARTE
GRZEGORZ KADZIOCH II ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e Orientale EDITRICE PONTIFICIA UNIVERSITA GREGORIANA Roma 1997 INDICE GENERALE INTRODUZIONE PARTE
Apollinare di Laodicea
 TESI XIII Dopo aver affermato la relazionalità ad intra di Dio (ÐmooÚsioj), la riflessione teologica si è orientata a comprendere il modo dell unione tra la realtà divina e quella umana in Gesù Cristo.
TESI XIII Dopo aver affermato la relazionalità ad intra di Dio (ÐmooÚsioj), la riflessione teologica si è orientata a comprendere il modo dell unione tra la realtà divina e quella umana in Gesù Cristo.
Sezione III. Tradizione
 Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
Sezione III. Tradizione I. Introduzione generale. II. Il mistero di Dio nella Sacra Scrittura III. Il mistero di Dio nella Tradizione IV. Presentazione sistematica del Mistero di Dio 8. L epoca prenicea
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014. Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A. Scuola Primaria Classe 4^ - sez.
 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA-DISCIPLINARE Anno Scolastico 2013/2014 Scuola Primaria Classe 4^ - sez. A Disciplina Religione Cattolica Ins. STRIKA LUCIANA Presentazione della classe Livello cognitivo
LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA
 Walter Kasper LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 Aspetti di una teologia della liturgia. La liturgia di fronte alla crisi della modernità per una nuova cultura liturgica...
Walter Kasper LA LITURGIA DELLA CHIESA QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 Aspetti di una teologia della liturgia. La liturgia di fronte alla crisi della modernità per una nuova cultura liturgica...
RIFORMA E CONTRORIFORMA
 Schemi di supporto al testo Passi nella storia di Sergio Zavoli RIFORMA E CONTRORIFORMA www.didadada.it LA RIFORMA DI MARTIN LUTERO La Chiesa non si rinnova spiritualmente: I papi si preoccupano solo di:
Schemi di supporto al testo Passi nella storia di Sergio Zavoli RIFORMA E CONTRORIFORMA www.didadada.it LA RIFORMA DI MARTIN LUTERO La Chiesa non si rinnova spiritualmente: I papi si preoccupano solo di:
STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta)
 STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta) 1. Natura II Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi, in
STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta) 1. Natura II Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi, in
BASSO MEDIOEVO PARTE II
 BASSO MEDIOEVO PARTE II Tra xl e xii secolo diventarono più forti i contrasti tra papato e impero,soprattutto sulla questione della nomina dei vescovi. Molti cristiani volevano una riforma della Chiesa,
BASSO MEDIOEVO PARTE II Tra xl e xii secolo diventarono più forti i contrasti tra papato e impero,soprattutto sulla questione della nomina dei vescovi. Molti cristiani volevano una riforma della Chiesa,
FACOLTÀ. di MISSIOLOGIA PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA. 3 a Specializzazione 2 a Specializzazione 1 a Specializzazione Licenza Baccellierato
 FACOLTÀ di MISSIOLOGIA 3 a Specializzazione 2 a Specializzazione 1 a Specializzazione Licenza Baccellierato PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA Altre offerte Accademiche Baccellierato in Missiologia Il Baccellierato
FACOLTÀ di MISSIOLOGIA 3 a Specializzazione 2 a Specializzazione 1 a Specializzazione Licenza Baccellierato PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA Altre offerte Accademiche Baccellierato in Missiologia Il Baccellierato
SPIRITUALITA E ARTE. Relatore:S. E. Monsignor Luciano Pacomio
 SPIRITUALITA E ARTE dalle scelte storiche di Lutero all ultima dichiarazione luterano-cattolica sulla giustificazione Relatore:S. E. Monsignor Luciano Pacomio Volontari per l arte Diocesi di Mondovì Corso
SPIRITUALITA E ARTE dalle scelte storiche di Lutero all ultima dichiarazione luterano-cattolica sulla giustificazione Relatore:S. E. Monsignor Luciano Pacomio Volontari per l arte Diocesi di Mondovì Corso
ARCIDIOCESI DI LANCIANO-ORTONA
 ARCIDIOCESI DI LANCIANO-ORTONA CALENDARIO DIOCESANO 2015-2016 AGOSTO 2015 28-30 Convegno regionale per gli operatori di Pastorale Familiare a Prati di Tivo (TE) 29 Inizio Novena per la Madonna del Ponte
ARCIDIOCESI DI LANCIANO-ORTONA CALENDARIO DIOCESANO 2015-2016 AGOSTO 2015 28-30 Convegno regionale per gli operatori di Pastorale Familiare a Prati di Tivo (TE) 29 Inizio Novena per la Madonna del Ponte
CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO
 CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 2016-2017 CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 2016-2017 Vengono indicati gli impegni di rilevanza diocesana, gli eventi nei quali la presenza del vescovo assume un particolare
CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 2016-2017 CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 2016-2017 Vengono indicati gli impegni di rilevanza diocesana, gli eventi nei quali la presenza del vescovo assume un particolare
Attività di potenziamento e recupero
 Attività di potenziamento e recupero 10. Gesù e la Chiesa oggi Gesù e la Chiesa oggi (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet o materiale fornito
Attività di potenziamento e recupero 10. Gesù e la Chiesa oggi Gesù e la Chiesa oggi (attività e verifiche) 1 ATTIVITA DI POTENZIAMENTO Utilizzando un motore di ricerca di internet o materiale fornito
Cattolicesimo e Protestantesimo
 Cattolicesimo e Protestantesimo Papa Leone X, ritratto da Raffaello Sanzio (particolare); dipinto a olio su tavola, Galleria degli Uffizi di Firenze Martin Lutero, ritratto da Lucas Cranach il Vecchio
Cattolicesimo e Protestantesimo Papa Leone X, ritratto da Raffaello Sanzio (particolare); dipinto a olio su tavola, Galleria degli Uffizi di Firenze Martin Lutero, ritratto da Lucas Cranach il Vecchio
Vescovi e monaci nell alto Medioevo. pp ; 82-83
 Vescovi e monaci nell alto Medioevo pp. 76-79; 82-83 1 Vescovi e Monaci Clero secolare è composto da quei vescovi, sacerdoti e diaconi che non sono vincolati ad una "regola religiosa", essi quindi vivono
Vescovi e monaci nell alto Medioevo pp. 76-79; 82-83 1 Vescovi e Monaci Clero secolare è composto da quei vescovi, sacerdoti e diaconi che non sono vincolati ad una "regola religiosa", essi quindi vivono
Questo Sinodo, che, come ogni istituzione umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato, è retto dalle seguenti norme generali.
 Lettera Apostolica Motu Proprio APOSTOLICA SOLLICITUDO Istituzione del Sinodo dei Vescovi per la Chiesa Universale Lettera apostolica Motu proprio di Papa Paolo VI con il quale si istituisce il Sinodo
Lettera Apostolica Motu Proprio APOSTOLICA SOLLICITUDO Istituzione del Sinodo dei Vescovi per la Chiesa Universale Lettera apostolica Motu proprio di Papa Paolo VI con il quale si istituisce il Sinodo
INIZIAZIONE CRISTIANA DI ADULTO (età da anni 14)
 INIZIAZIONE CRISTIANA DI ADULTO (età da anni 14) Oggetto: Dati personali del Candidato/a alla ammissione al Catecumenato N.B. Questa scheda (in stampatello) venga recapitata contestualmente alla domanda
INIZIAZIONE CRISTIANA DI ADULTO (età da anni 14) Oggetto: Dati personali del Candidato/a alla ammissione al Catecumenato N.B. Questa scheda (in stampatello) venga recapitata contestualmente alla domanda
IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA
 Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
Walter Kasper IL VANGELO DI GESÙ CRISTO QUERINIANA INDICE GENERALE Prefazione.... 5 INTRODUZIONE ALLA FEDE Introduzione.... 9 1. La situazione della fede... 12 1. Crisi o kairós della fede 12 2. I fondamenti
Pellegrinaggio a Roma nell Anno della fede
 Diocesi di Molfetta Pellegrinaggio a Roma 29-30 Maggio 2013 2 giorni; 1 notte Pellegrinaggio a Roma nell Anno della fede Percorso catechistico-celebrativo Porta fidei semper nobis patet, quae in communionem
Diocesi di Molfetta Pellegrinaggio a Roma 29-30 Maggio 2013 2 giorni; 1 notte Pellegrinaggio a Roma nell Anno della fede Percorso catechistico-celebrativo Porta fidei semper nobis patet, quae in communionem
Dedico questo lavoro al liturgista francescano Rinaldo Falsini, dal quale continuo a imparare
 Dedico questo lavoro al liturgista francescano Rinaldo Falsini, dal quale continuo a imparare Antonio Clementi Il peccatore e la riconciliazione nella Chiesa Proprietà letteraria riservata. 2016 Antonio
Dedico questo lavoro al liturgista francescano Rinaldo Falsini, dal quale continuo a imparare Antonio Clementi Il peccatore e la riconciliazione nella Chiesa Proprietà letteraria riservata. 2016 Antonio
CALENDARIO ACCADEMICO A. A. 2015/2016
 69 ACCADEMICO A. A. 2015/2016 Legenda Indica un giorno in cui l Università rimane chiusa per l intera giornata. Indica un giorno in cui l Università rimane aperta al pubblico, ma le Segreterie restano
69 ACCADEMICO A. A. 2015/2016 Legenda Indica un giorno in cui l Università rimane chiusa per l intera giornata. Indica un giorno in cui l Università rimane aperta al pubblico, ma le Segreterie restano
Poteri universali e poteri locali
 Poteri universali e poteri locali Il Medioevo è stata un'epoca di grandi idealismi, politici e religiosi: per secoli si cercò un'utopistica unità del mondo conosciuto sotto un unico potere universale.
Poteri universali e poteri locali Il Medioevo è stata un'epoca di grandi idealismi, politici e religiosi: per secoli si cercò un'utopistica unità del mondo conosciuto sotto un unico potere universale.
Biblioteca. I volumi sono suddivisi per argomenti, come sotto indicato, con due macro-suddivisioni: PASTORALE e SPIRITUALITA
 Biblioteca Tutti i libri e i periodici trovano posto in una serie di scaffali che sono collocati in due posizioni e piazzati a forma di due U contrapposte, in modo da consentire un facile accesso 'a' e
Biblioteca Tutti i libri e i periodici trovano posto in una serie di scaffali che sono collocati in due posizioni e piazzati a forma di due U contrapposte, in modo da consentire un facile accesso 'a' e
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. Sede di Brescia. Istituto Superiore di Scienze Religiose
 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Brescia Istituto Superiore di Scienze Religiose ANNO ACCADEMICO 2009/2010 Istituto Superiore di Scienze Religiose È promosso dall Università Cattolica del Sacro
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Brescia Istituto Superiore di Scienze Religiose ANNO ACCADEMICO 2009/2010 Istituto Superiore di Scienze Religiose È promosso dall Università Cattolica del Sacro
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
SCHEDA DI PRESENTAZIONE TITOLO: LA RIFORMA PROTESTANTE BREVE DESCRIZIONE DELL UNITÀ DI APPRENDIMENTO: in questa unità di apprendimento si vuole introdurre le novità portate da Lutero DIDATTIZZAZIONE e
Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris
 CANONI 111-112 CIC Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris Orientalium Ecclesiarum, 2 Chiese particolari o riti : La Chiesa santa e cattolica, che è
CANONI 111-112 CIC Che significa una Chiesa rituale sui iuris; Chiese rituali; Riti orientali; Chiesa sui iuris Orientalium Ecclesiarum, 2 Chiese particolari o riti : La Chiesa santa e cattolica, che è
SCUOLA INTERDIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA Anno scolastico
 DIOCESI DI ASSISI NOCERA UMBRA GUALDO TADINO DIOCESI DI FOLIGNO SCUOLA INTERDIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA Anno scolastico 2017 2018 Via del Roccolo, 30 06034 FOLIGNO PG Tel 0742.321389 Promossa, in
DIOCESI DI ASSISI NOCERA UMBRA GUALDO TADINO DIOCESI DI FOLIGNO SCUOLA INTERDIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA Anno scolastico 2017 2018 Via del Roccolo, 30 06034 FOLIGNO PG Tel 0742.321389 Promossa, in
Ciclo di studi: Conoscere la Bibbia
 Ciclo di studi: Conoscere la Bibbia LA RIFORMA Religiose e morali economiche politiche Vendita indulgenze Calvinista cause Luterana chiese Anglicana La riforma protestante diffusione geografica Germania,
Ciclo di studi: Conoscere la Bibbia LA RIFORMA Religiose e morali economiche politiche Vendita indulgenze Calvinista cause Luterana chiese Anglicana La riforma protestante diffusione geografica Germania,
INDICE. Prefazione. digitalisiert durch IDS Basel/Bern, im Auftrag der Schweizerischen Nationalbibliothek
 INDICE Prefazione Prologo AVERE UN CUORE CHE ASCOLTA Sulla della teologia di Benedetto XVI.... 9 Amicizia con il Dio vivente 9 2. Essere a servizio di un 3. Chiesa profeticamente mariana 13 Capitolo Primo
INDICE Prefazione Prologo AVERE UN CUORE CHE ASCOLTA Sulla della teologia di Benedetto XVI.... 9 Amicizia con il Dio vivente 9 2. Essere a servizio di un 3. Chiesa profeticamente mariana 13 Capitolo Primo
Carlo Magno, il Sacro romano impero e il feudalesimo
 la nostra proposta didattica del mese Unità di apprendimento semplificata con glossario, schemi ed esercizi che facilitano l apprendimento A cura di Emma Mapelli Carlo Magno, il Sacro romano impero e il
la nostra proposta didattica del mese Unità di apprendimento semplificata con glossario, schemi ed esercizi che facilitano l apprendimento A cura di Emma Mapelli Carlo Magno, il Sacro romano impero e il
STORIA DEI COCILI DELLA CHIESA CATTOLICA
 STORIA DEI COCILI DELLA CHIESA CATTOLICA Il concetto religioso del concilio ( i primi si chiamavano anche Sinodi ) può essere derivato da un'affermazione di Cristo: "Dove due o tre saranno riuniti nel
STORIA DEI COCILI DELLA CHIESA CATTOLICA Il concetto religioso del concilio ( i primi si chiamavano anche Sinodi ) può essere derivato da un'affermazione di Cristo: "Dove due o tre saranno riuniti nel
L indulgenza INDULGENZE PLENARIE Per ottenere l Indulgenza plenaria il fedele deve: confessarsi sacramentalmente ricevere l Eucarestia - pregare per
 1 INDULGENZE PLENARIE Per ottenere l Indulgenza plenaria il fedele deve: confessarsi sacramentalmente ricevere l Eucarestia - pregare per le intenzioni del Papa -(padre nostro e ave maria Recitare il credo
1 INDULGENZE PLENARIE Per ottenere l Indulgenza plenaria il fedele deve: confessarsi sacramentalmente ricevere l Eucarestia - pregare per le intenzioni del Papa -(padre nostro e ave maria Recitare il credo
Segni esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale. S.Agostino
 Segni esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale S.Agostino Cosa sono i Sacramenti I sacramenti sono segni efficaci del mistero di salvezza di Cristo: ne sono infatti l'attuazione nel "tempo
Segni esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale S.Agostino Cosa sono i Sacramenti I sacramenti sono segni efficaci del mistero di salvezza di Cristo: ne sono infatti l'attuazione nel "tempo
Diocesano. Calendario
 Diocesano Calendario 2017-2018 Legenda Uffici Pastorali BEN Beni Culturali CAR Carità CAT Catechesi COM Comunicazioni Sociali FAM Famiglia IRC Insegnanti di Religione Cattolica LIT Liturgico MIS Cooperazione
Diocesano Calendario 2017-2018 Legenda Uffici Pastorali BEN Beni Culturali CAR Carità CAT Catechesi COM Comunicazioni Sociali FAM Famiglia IRC Insegnanti di Religione Cattolica LIT Liturgico MIS Cooperazione
PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016
 PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016 INDICATORI CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE. Conoscere espressioni, documenti, in particolare la Bibbia
PROGRAMMAZIONE RELIGIONE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016 INDICATORI CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE. Conoscere espressioni, documenti, in particolare la Bibbia
SCUOLA INTERDIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA Anno scolastico
 DIOCESI DI ASSISI NOCERA UMBRA GUALDO TADINO DIOCESI DI FOLIGNO SCUOLA INTERDIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA Anno scolastico 2014 2015 Via del Roccolo, 30 06034 FOLIGNO PG Tel 0742.321389 Promossa, in
DIOCESI DI ASSISI NOCERA UMBRA GUALDO TADINO DIOCESI DI FOLIGNO SCUOLA INTERDIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA Anno scolastico 2014 2015 Via del Roccolo, 30 06034 FOLIGNO PG Tel 0742.321389 Promossa, in
SAPIENZA Università di Roma
 SAPIENZA Università di Roma Facoltà di Scienze Politiche Indirizzo giuridico - internazionale Tesi di laurea in Diritto Ecclesiastico Italiano e Comparato LA LIBERTA RELIGIOSA IN SPAGNA Relatore: Prof.ssa
SAPIENZA Università di Roma Facoltà di Scienze Politiche Indirizzo giuridico - internazionale Tesi di laurea in Diritto Ecclesiastico Italiano e Comparato LA LIBERTA RELIGIOSA IN SPAGNA Relatore: Prof.ssa
CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA
 CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
CLASSE PRIMA Comprendere che la vita, la natura, sono dono di Dio. Conoscere l ambiente in cui è vissuto Gesù. Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio. Ascoltare alcune pagine bibliche dell Antico testamento
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA CONOSCENZE (I SAPERI) ABILITA' (SAPER FARE) DIO E L'UOMO DI COMPETENZA
 RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA Rflette su Dio Creatore e Padre. Conosce Gesù di Nazaret, L'Emmanuele "Dio con noi". Coglie l'importanza della propria crescita e del vivere insieme nell'accoglienza e
RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA Rflette su Dio Creatore e Padre. Conosce Gesù di Nazaret, L'Emmanuele "Dio con noi". Coglie l'importanza della propria crescita e del vivere insieme nell'accoglienza e
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano-
 Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
Convento-Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Squinzano- . IL COMANDAMENTO DELL AMORE Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza. Ama il prossimo tuo come te stesso.
Convenzione tra la Chiesa metodista coreana di Roma, la Tavola valdese e il Comitato permanente OPCEMI
 8 Convenzione tra la Chiesa metodista coreana di Roma, la Tavola valdese e il Comitato permanente OPCEMI N O T A La Chiesa Metodista Coreana di Roma nel 1996 chiede di essere accolta nell Unione delle
8 Convenzione tra la Chiesa metodista coreana di Roma, la Tavola valdese e il Comitato permanente OPCEMI N O T A La Chiesa Metodista Coreana di Roma nel 1996 chiede di essere accolta nell Unione delle
PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2016/2017
 PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2016/2017 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE RELIGIONE CATTOLICA 1 BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
PROGRAMMAZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2016/2017 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE RELIGIONE CATTOLICA 1 BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
EVANGELIUM VITAE LETTERA ENCICLICA SUL VALORE E L'INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA. Sommario dell'enciclica
 EVANGELIUM VITAE LETTERA ENCICLICA SUL VALORE E L'INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA Sommario L'indice della Evangelium Vitae (EV) è così strutturato: Introduzione (n. 1-6) Capitolo I - "La voce del sangue
EVANGELIUM VITAE LETTERA ENCICLICA SUL VALORE E L'INVIOLABILITÀ DELLA VITA UMANA Sommario L'indice della Evangelium Vitae (EV) è così strutturato: Introduzione (n. 1-6) Capitolo I - "La voce del sangue
ANNO ACCADEMICO
 1 CALENDARIO ANNO ACCADEMICO 2017-2018 Legenda Indica un giorno in cui l Università rimane chiusa per l intera giornata. Indica un giorno in cui l Università rimane aperta, pur non essendoci lezioni o
1 CALENDARIO ANNO ACCADEMICO 2017-2018 Legenda Indica un giorno in cui l Università rimane chiusa per l intera giornata. Indica un giorno in cui l Università rimane aperta, pur non essendoci lezioni o
3.11. Religione Scuola Primaria
 3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
3.11. Religione. 3.11.1 Scuola Primaria NUCLEO FONDANTE: Dio e l uomo al termine della classe terza al termine della classe quinta L alunno: riconosce Dio come Padre, riflette su Dio Creatore e si approccia
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno)
 COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE. Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo
 PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
PROGRAMMI SVOLTI DI RELIGIONE Insegnante: prof. Martis Rossano Classe: I - Sez.: B Liceo I. IL MISTERO DELL ESISTENZA 1. Chi sono io? A. Sempre uguale, sempre diverso B. Un solo io o tanti io? C. Un solo
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è
 Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
Sia la religione ebraica sia quella cristiana sono religioni rivelate, cioè religioni che trovano il loro fondamento nel fatto che Dio si è manifestato direttamente all uomo. Sia per gli ebrei sia per
LA PRIMAVERA DELLA CHIESA
 LA PRIMAVERA DELLA CHIESA 14/03/10 http://incoscienza.wordpress.com/ 1 IL VENTO DELLO SPIRITO Il 28 ottobre 1958 a 77 anni, con sorpresa di tutti per la sua avanzata età, Roncalli venne eletto Papa e assunse
LA PRIMAVERA DELLA CHIESA 14/03/10 http://incoscienza.wordpress.com/ 1 IL VENTO DELLO SPIRITO Il 28 ottobre 1958 a 77 anni, con sorpresa di tutti per la sua avanzata età, Roncalli venne eletto Papa e assunse
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA Prof. Andrea Guarise. PROGETTO DIDATTICO CLASSE 3 a E scientifico
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI T. LUCREZIO C. di Cittadella SCUOLA POLO PER LA DIMENSIONE EUROPEA DELL ISTRUZIONE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
